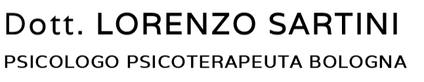SCRITTI
IL TEMPO LIBERO TRA L'ISTITUZIONE E L'ANGOSCIA
di Lorenzo Sartini
“…la noia è quella sgradevole ‘bonaccia dell’anima’, che precede il viaggio felice e i venti giulivi;
egli la deve sopportare, deve attenderne in sé gli effetti:
proprio questo è ciò che le nature inferiori non riescono assolutamente a ottenere da se medesime!
Fuggire con tutti i mezzi la noia è volgare: come è volgare lavorare senza piacere”
(Friederich Nietszche, La gaia scienza e Idilli di Messina).
Ritrovo la motivazione alla stesura di questo lavoro in due stimoli che mi hanno toccato qualche tempo fa, nel giro di pochissimi giorni di distanza l’uno dall’altro: il primo, durante un colloquio che ho svolto con un paziente, del quale farò menzione più avanti; e il secondo, nel corso della presentazione di un libro che, seppur avesse altro oggetto come tema, mi ha dato l’occasione di riflettere ulteriormente su quel medesimo pensiero. Ciò che fondamentalmente mi ha colpito, in ambedue le circostanze, è stata l’idea di una piatta assenza di pensiero riguardo a quei momenti che fanno parte della vita delle persone e che comunemente vengono indicati con la formula "tempo libero", ovvero un tempo connotato dalla non direttività e dalla non obbligatorietà, e che per ciò stesso viene sovente inteso come vuoto. Un tempo che spesso viene dato per scontato e a cui si fa fatica a dare un senso, e nel quale pare essere la stereotipia, l’automaticità priva di prospettive, a guidare le vite e le condotte dei protagonisti di quei momenti. Ma che tipo di rapporto intercorre tra l’uomo e questo tempo nel quale, potremmo dire, egli ha disponibilità di se stesso? Che cosa produce in lui e come viene affrontato questo tempo scevro da impegni e doveri?
Come anticipato, in questo percorso parto dal secondo stimolo, ovverosia la presentazione del libro di Francesco Galofaro, dottore di ricerca in semiotica, dal titolo “Dopo Gerico. I nuovi spazi della psichiatria” (2015). Nel libro si descrive l’esperienza che l’autore ha avuto modo di fare all’interno di un progetto residenziale per persone con diagnosi di schizofrenia; gruppi di 3-5 persone, in carico al SSN, abitano appartamenti pressoché completamente gestiti da loro stessi. L’unico aiuto esterno che queste persone hanno è costituito dagli assistenti familiari che monitorano l’assunzione della terapia farmacologica per ognuna di esse.
Galofaro, con il compito di fare una valutazione del servizio in termini di efficacia e ripetibilità, ha frequentato per diverso tempo gli appartamenti di queste persone, condividendo con loro esperienze, interrogandosi sui valori che vengono chiamati in causa in queste situazioni e, cercando di auto-osservarsi nella relazione che si osserva, raccogliendo dati mediante interviste più o meno strutturate. Un punto di enorme interesse dell’esperienza riportata nel libro, almeno per chi scrive, riguarda la questione della vita in comune, della quotidianità condivisa, della collettività forzata, e la ricerca di propri spazi di individualità.
Una domanda che Galofaro pone riguarda, in effetti, le modalità di ricerca e di recupero di una propria individualità in una condizione di residenzialità condivisa, per così dire, obbligata. Perché, certamente, si tratta di persone che stanno facendo un’esperienza positiva al di fuori di situazioni di contenimento psichiatrico ben note, però è un’esperienza che richiede la condivisione di spazi e tempi di cui, più che comprensibilmente, si farebbe volentieri a meno. L’osservazione della vita di queste persone ha portato a registrare una quotidianità costituita pressoché esclusivamente da routines. All’interno dell’organizzazione della vita degli appartamenti si fanno sempre le stesse cose: ciascuno ha i suoi propri riti che cerca di incastrare con quelli degli altri coinquilini. La routine la fa da padrona e la ripetizione delle stesse pratiche e delle stesse azioni pare costituire il perno dell’autogestione degli appartamenti. E la routine individuale viene ad avere un senso se rapportata alla routine collettiva, ciò che sembra gettare in una situazione di indifferenziazione gli abitanti dell’appartamento. La condivisione dell’appartamento, contraddistinta dai programmi giornalieri individuali sempre identici, comporta un deposito di tipo collettivo, gruppale: ossia, quell’appartamento non viene considerato segno distintivo della proprietà di uno, ma sollecita un vissuto abitudinario di con-divisione, stimolando l’idea dell’assorbimento del soggetto nello spazio (psico)fisico collettivo.
Ragion per cui, un modo che si è trovato per recuperare la propria individualità pare essere quello della privatizzazione degli spazi. In genere, si tende a privatizzare le stanze da letto, ma spesso le stanze vengono condivise con un’altra persona. Se un inquilino della casa ‘personalizza’ una stanza condivisa, allora la soluzione che viene adottata è che il compagno di stanza occuperà simbolicamente, ‘personalizzerà’ appunto, un altro spazio dell’appartamento, per esempio la sala. La privatizzazione di un spazio dell’appartamento sembra garantire l’intima convinzione di essere identificati come portatori di una propria individualità e, quindi, di potersi riconoscere come persone. In altri termini, il modo che viene utilizzato per recuperare il segno della propria individualità è costituito dal deposito della propria personalità in uno spazio dell’appartamento che viene organizzato secondo le proprie preferenze.
Capita che, ogni tanto, vengano organizzate delle ‘uscite’ con gli inquilini dei vari appartamenti, allora può accadere che ci si ritrovi a poter soggiornare per qualche giorno in una casa in montagna. In una situazione che, seppur caratterizzata da molte novità, da un cambiamento della routine abituale, continua però ad essere contraddistinta dai programmi: si devono fare delle attività, magari ludiche, ma pur sempre organizzate e predefinite. Lo svolgimento della propria vita si situa all’interno di un’organizzazione esistenziale già predisposta da altri.
Galofaro racconta di uno di questi soggiorni, in una grande casa colonica di montagna, che ha portato a confrontarsi con una quasi completa destrutturazione delle abitudini degli inquilini: “Lo spazio della casa colonica è tale da destrutturare quasi del tutto le regole usuali dell’appartamento e da causare una crisi delle funzioni attanziali che abbiamo individuato nella nostra analisi semiolinguistica: esso consiste in stanze molto grandi e prive di privacy; le dimensioni inusuali fanno sì che il peso della cura della casa e della preparazione del pranzo ricada quasi esclusivamente sulle assistenti, che finiscono per sostituirsi ai soggetti nella routine della cura domestica e non riescono più ad esercitare la funzione di destinanti” (2015, p. 54). In più, a causa del maltempo incontrato durante i giorni del soggiorno, salta, oltre la programmazione spaziale, anche quella temporale, poiché vengono ridotte le gite o le passeggiate che si aveva in proposito di fare.
Queste rotture dei programmi mettono gli ospiti (cioè, i beneficiari del progetto di reinserimento) in una situazione nuova: hanno del tempo veramente libero, non organizzato, e si ritrovano di fronte al vuoto. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, invece di utilizzare quel tempo libero a proprio piacere, visto che gli ospiti avrebbero potuto sfruttarlo come desideravano, essi non hanno saputo che cosa farne (“naufragano nella noia”, scrive Galofaro), entrando in crisi: chi stava ore in branda, chi fumava in continuazione, chi stava seduto guardando le pareti. Nel tempo libero, la noia. Come si risolve il problema della noia? Che cosa ci si fa con quel tempo libero?
La rottura del programma precostituito che organizza a priori la vita degli utenti sembra conduca all’opportunità di una nuova e diversa interrogazione su di sé, ovverosia a come poter gestire questo tempo-spazio vuoti.
Intermezzo psicoanalitico: la simbiosi istituzionale
Nel suo articolo forse più noto, “Psicoanalisi dell’inquadramento psicoanalitico” del 1967, Bleger afferma che la situazione psicoanalitica è caratterizzata dall’insieme dei fenomeni che avvengono nella relazione tra analista e paziente, e che questa situazione sia costituita da un processo, ovvero ciò che avviene all’interno della relazione, e da un non-processo, ossia l’inquadramento o setting, definito da alcune costanti (tempo, spazio, ruolo, compito) che costituiscono la cornice all’interno della quale il processo può svolgersi ed essere analizzato. Il fatto che il rapporto analitico duri anni e si fondi su un insieme di norme e attitudini permette di caratterizzarlo come un’istituzione, dunque l’inquadramento è “un’istituzione nel cui ambito si verificano dei fenomeni che chiamiamo comportamenti” (1967, p. 272). Per Bleger l’istituzione funge da deposito di parte della personalità dell’individuo, tanto che “l’identità è sempre – parzialmente o totalmente – un’identità di gruppo o istituzionale” (ibidem, p. 273), cioè si struttura per mezzo dell’appartenenza a gruppi o istituzioni.
Il soggetto non ha consapevolezza di questo processo poiché nelle istituzioni proietta il suo ‘mondo fantasma’, ossia il proprio modo di vedere le cose e relazionarsi con l’esterno, un modo che, partendo dal rapporto simbioticamente connotato con la figura materna, lo ha organizzato sin dalle primissime fasi della sua vita.
Se mantenere l’inquadramento, e la sua costanza, permette il lavoro di analisi, d’altra parte è proprio questa invarianza che porta a scontrarsi con un problema. In effetti, se l’inquadramento si mantiene invariato, viene a collocarsi sullo sfondo della relazione non essendo più preso in considerazione dal paziente. Diventa ‘muto’ poiché “ciò che è sempre presente non viene percepito” (ibidem, p. 273). L’invarianza di una situazione, come nel rapporto simbiotico, permette la proiezione di una parte di sé, quella che Bleger chiama ‘parte psicotica della personalità’ o ‘non-io’, in essa. La ‘parte psicotica della personalità’ o ‘non-io’ è fondamentale, secondo Bleger, per la formazione e l’organizzazione dell’io, dell’identità individuale, poiché è quella parte indifferenziata che costituisce il fondamento e la cornice dell’identità di una persona, è il ‘meta-io’. Probabilmente, in termini ‘gestaltici’, potrebbe essere definita lo sfondo dal quale, di volta in volta, emerge la figura, l’io, ossia la parte nevrotica della personalità, quella parte capace di stabilire relazioni con il mondo esterno e variarle a seconda delle circostanze.
Partendo dal concetto di ‘baluardo’ di M. e W. Baranger, ossia “quell’aspetto che l’analizzato cerca di non mettere in gioco, eludendo la regola fondamentale” (ibidem, p. 272) e che corrisponderebbe alla parte psicotica, o indifferenziata, della personalità, Bleger appoggia l’idea che il rapporto analitico con il suo perpetuarsi venga a costituirsi come un rapporto simbiotico. Nota, però, che con il perpetuarsi immutato dell’inquadramento è questo che diviene il depositario della parte simbiotica (psicotica) della personalità, ovverosia il ‘baluardo’ viene depositato nell’inquadramento. Aggiunge, inoltre, che in un contesto analitico gli inquadramenti da considerare sarebbero due: quello proposto dall’analista e accettato consapevolmente dal paziente e “quello in cui il paziente proietta il suo ‘mondo fantasma’. E quest’ultimo è una coazione a ripetere tanto più perfetta in quanto è la più completa, la meno conosciuta e percepibile” (ibidem, p. 276).
Ora, è con la rottura dell’inquadramento (dovuta per esempio alle vacanze, al cambiamento di un orario, all’impossibilità di essere presenti al colloquio e via dicendo) che si apre una fessura, un varco, attraverso cui può emergere la parte psicotica, il mondo fantasma, l’inquadramento del paziente, che rimangono senza depositari. Emerge la differenza tra l’inquadramento proposto dall’analista e quello proiettato nella situazione analitica dal paziente, comportando, questa destrutturazione, vissuti angoscianti: “Per il paziente si era rotto ‘qualcosa’ che era così e doveva essere come era sempre stato, e che egli non concepiva potesse essere in un altro modo. Esigeva che si ripetesse il vissuto…” (ibidem, p. 275). Fa irruzione una realtà fino ad allora non contemplata, mettendo in crisi il non-io e problematizzando l’io, che deve reintroiettare la sua parte simbiotica e trovare nuove difese per immobilizzarla o riproiettarla. È la rottura di un rapporto primitivo di assuefazione che, se non sistematicamente analizzato, si stabilizza andando a costituire la base dell’organizzazione della personalità. Si ha a che fare, in tali casi, con un io ‘adattato’: “questo ‘io fattico’ è un ‘io di appartenenza’ che si è formato e mantenuto grazie all’inserimento del soggetto in un’istituzione (che può essere la relazione terapeutica, l’Associazione Psicoanalitica Argentina, un gruppo di studio o di qualsiasi altro tipo): non è un ‘io interiorizzato’ che dia al soggetto stabilità interiore” (ibidem, p. 280).
La situazione descritta da Bleger sembra avere qualche attinenza con quella descritta da Galofaro a proposito della vacanza in montagna: i beneficiari del progetto di reinserimento, che fondano la propria quotidianità sulla programmazione e sull’abitudinarietà, nella vacanza in montagna avrebbero dovuto godere di uno stacco dalla routine quotidiana. Si trattava però di uno stacco o, per meglio dire, di un tempo libero, già organizzato (casa colonica, escursioni, gite, ecc.), istituito: anche lì ci si muoveva all’interno di una routine. La routine viene rotta poiché la struttura della casa colonica, l’apporto degli assistenti familiari e le condizioni metereologiche non permettono di sviluppare le giornate come si era previsto. Questa condizione è ‘sorprendente’, inaspettata, e mette di fronte ad una situazione cui non si pensava e alla quale non si è abituati. La rottura della routine provoca la fuoriuscita da una dimensione istituzionalizzata e mette gli ospiti a confronto con l’esperienza di sé e delle necessità del proprio corpo che, non pensate a priori, richiedono di essere prese in carico soggettivamente e soddisfatte.
Una quotidianità perturbante
Il sociologo francese Henri Lefebvre, in “Critica della vita quotidiana”, un testo del 1958, propone un’analisi del concetto di tempo libero e nota che, nell’epoca precedente all’avvento della società borghese, questo tempo non programmato veniva determinato dal lavoro, ossia “gli imperativi della comunità contadina” (1958, p. 36) con le loro necessità organizzavano sia il lavoro e sia il tempo libero. Con l’avvento della società industriale si è assistito ad una valorizzazione e alla conseguente parcellizzazione dell’attività lavorativa che ha portato alla netta distinzione (almeno nelle classi privilegiate) tra uomo “in quanto uomo” (ibidem, p. 37) e uomo come lavoratore. La vita familiare, diversamente da quanto avveniva precedentemente all’interno di un contesto di vita contadino, si separa dall’attività lavorativa: e lo stesso avviene per il tempo libero.
La società moderna industriale, con la richiesta di maggior specializzazione nel lavoro, e dunque con la netta separazione rispetto alla vita al di fuori del lavoro, ha suscitato un bisogno generale di tempo libero, cui ha prontamente risposto mediante la creazione di tecniche (intendendo con questo termine sia la creazione di apparecchi tecnologici quali la radio, la televisione, la macchina fotografica, ecc. e sia la predisposizione di luoghi o interessi ‘di vita’ come il bar, la sagra paesana, lo sport, l’hobby e via dicendo) aventi lo scopo di soddisfare quei nuovi bisogni sociali.
Ora l’esigenza maggiore viene ad essere quella della rottura: una rottura con la quotidianità, non soltanto lavorativa, ma anche con la quotidianità familiare. Si accentua il carattere di divertimento e, in questo tempo ‘liberato’, non si vogliono vivere preoccupazioni o obblighi o necessità, ma solamente si vuole sentirsi liberi e godere: “L’uomo cosiddetto ‘moderno’ spera dunque di trovare nel tempo libero ciò che il suo lavoro e la sua vita familiare o ‘privata’, non gli danno” (ibidem, p. 39). Il tempo libero viene a rappresentare “il non-quotidiano nel quotidiano” (ibidem, p. 47), ma si tratta di un’evasione dal quotidiano che può avere solamente un carattere illusorio giacché, puntualizza Lefebvre, non è possibile concretamente uscire dalla propria quotidianità. L’uomo aspira al tempo libero per liberarsi dal lavoro fonte di alienazione, ovvero uscire dalla propria quotidianità, e si ritrova a fare i conti con un tempo libero comunque organizzato socialmente che, sebbene espressione di un bisogno e segno di critica rispetto ad una quotidianità vissuta come alienante, si pone esso stesso come illusorio e ingannevole, dunque, almeno parzialmente, alienante.
In sintesi: la quotidianità è contraddistinta da una complessa organizzazione sociale che permea, in qualche grado regolandole e disciplinandole, tutte le sfere dell’umana esistenza (lavoro, tempo libero, vita familiare e vita privata): è questa costante organizzazione sociale, all’interno della quale l’uomo si trova a vivere, ad estraniare l’uomo da se stesso. In altri termini, è l’istituzione della quotidianità ad essere alienante e la questione fondamentale, la preoccupazione, riprendendo ancora Lefebvre, è quella “di far emergere il vivo, il nuovo, il positivo – i bisogni e le giuste soddisfazioni – dagli elementi negativi: dalle alienazioni” (ibidem, p. 49).
Compito, quest’ultimo enunciato da Lefebvre, la cui attuazione sembrerebbe tutt’altro che semplice e immediata. L’esperienza, in effetti, sembra proporre l’idea che non sia così facile dare corso a ciò che stimola l’uomo, ai suoi bisogni emergenti e alle “giuste soddisfazioni”. C’è qualcosa che sembra frapporsi tra l’uomo e la soddisfazione dei propri impulsi vitali, tra l’uomo e l’espressione della propria creatività ed originalità.
Il concetto espresso da Lefebvre con la formula “il non-quotidiano nel quotidiano” richiama alla mente l’idea freudiana di ‘perturbante’. Perturbante è la traduzione in italiano del tedesco unheimlich, antitetico al termine heimlich che, derivante da Heim, cioè casa, si può tradurre con confortevole, tranquillo. Freud ritiene che il perturbante sia “quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare” (1919, p. 83), una sensazione angosciosa che può derivare dal rinnovarsi di elementi infantili rimossi che vengono risvegliati da un impressione attuale o da convinzioni considerate superate che trovano una nuova convalida nella quotidianità.
Ricollegandomi anche a quanto espresso da Bleger a proposito della parte simbiotica della personalità, penso si possa esprimere ciò che Freud afferma sul perturbante, nel 1919, in questo modo: c’è qualcosa in più di quello che si riesce a comprendere nel modo di vivere la propria vita, la propria quotidianità; quando emerge questo qualcosa in più, che c’è sempre stato ma che fino ad un certo momento non si aveva la possibilità di considerare, si vive l’esperienza angosciosa del perturbante.
Enrique Pichon-Rivière in “Psicologia de la vida cotidiana” dedica diverse riflessioni alla questione dell’ozio. Sulla scorta di Freud afferma che attraverso il lavoro l’uomo riesce a darsi un equilibrio, mantenendo un fermo legame con la realtà e con la collettività. L’ozio, invece, costituirebbe un “atteggiamento mentale che ci permette di dedicarci a una determinata attività senza pensare prima ai risultati utili o pratici inerenti la vita” (1966/67, p. 33). Nell’ozio il soggetto, non sottoposto al vincolo dell’obbligatorietà, può dedicarsi ad aspetti della vita solitamente non coltivati a causa delle pressioni cui si è sottoposti dalle esigenze della quotidianità. Ma, d’altra parte, molte esperienze sembrano suggerire che la privazione di lavoro, dunque di un’attività vissuta con obbligatorietà, possa sfociare in situazioni soggettive di malessere; vedasi, per esempio, lo stato depressivo che spesso coglie i lavoratori all’indomani della sopraggiunta pensione. Di conseguenza, capita frequentemente che chi si ritrova con del tempo libero per oziare, se lo riempia con una serie di attività sociali (ma anche antisociali).
Una delle modalità utilizzate nella società industriale capitalista per riempire il tempo libero, il tempo della non obbligatorietà del lavoro, è la vacanza. Se prima il tempo libero veniva inteso come tempo da dedicare al riposo e alla pigrizia, ora l’uomo-consumatore viene stimolato dalla pubblicità e dalla voce dei mass media a soddisfare i propri desideri di felicità mediante modalità appartenenti, tradizionalmente, alle classi sociali più ricche. L’immaginario legato al tempo libero è ora quello del viaggio e della vacanza, attraverso cui coltivare il corpo e lo spirito e ricercare lo scambio culturale e l’interazione con gli altri. Si tratta, nota Pichon-Rivière, di un ozio istituzionalizzato.
Il tempo libero dell’ozio sarebbe il tempo del gioco, che l’analista svizzero-argentino definisce così: “Questa azione gratuita, deliberata e liberamente realizzata, racchiude in sé un universo, retto da leggi proprie, simile al mondo del sogno. Come in questo, diminuisce il potere repressivo della censura precedente e i desideri di ogni tipo trovano espressione nei gesti e nel linguaggio simbolico di questa forma di finzione. Ogni gioco persegue un obiettivo. Si tratta di costruire, attraverso un’attività particolare, uno schema che permetta di operare sulla realtà. La sua missione non si esaurisce in una liberazione di desideri occulti o repressi, ma mira ad una nuova pianificazione della realtà. Per questo risulta una delle forme più efficienti di apprendimento” (ibidem, p. 136).
Nella società moderna industriale, meccanizzata e automatizzata, il gioco rappresenta la possibilità della spontaneità e della libertà dell’atto creativo, seppure entro una cornice costituita da regole fisse cui si aderisce volontariamente. Il tempo del gioco, un tempo limitato ma che esige un abbandono e un’attenzione quasi assolute, può significare “l’opportunità di superare la frustrazione che soffriamo nel mondo della responsabilità familiare o del lavoro” (ibidem, p. 137).
Uno dei tratti fondamentali che attrae al gioco è l’incertezza. Non si conosce in anticipo il risultato, così, nel mistero del gioco, si può ritrovare la necessità di una sfida lanciata ad un destino ostile vissuto con frustrazione: tanto nei giochi che si fondano sulla competizione quanto in quelli definiti d’azzardo. In questi ultimi, che in genere si intensificano durante le vacanze quando non si hanno compiti prefissati da svolgere, si può ipotizzare l’intenzione di risolvere la propria frustrazione con l’illusione di “costruire il proprio destino sulla base della fantasia dell’incontro fortuito. È un’altra forma di strategia di fronte alla morte, un piano che si azzarda ad incontrare l’insolito”. Poiché, conclude Pichon-Rivière, “Il gioco ci strappa dall’impotenza di un ozio non pianificato, da un tempo che doveva essere vissuto come proprio e che sentiamo ci sta sfuggendo” (ibidem, p. 138).
L’alieno, dentro
Il signor Y si rivolge a me per un problema con il gioco d’azzardo: nello specifico gioca con le videolottery. Dice che ha iniziato a giocare per caso, seguendo l’esempio di un amico che frequenta lo stesso bar. Quel bar viene frequentato tutti i giorni poiché lì il signor Y fa la sua pausa pranzo dal lavoro. È un momento della giornata che viene indicato dal signor Y come dedito al relax, altrimenti si ritrova sempre impegnato con il lavoro (essendo un piccolo imprenditore ha tempi di lavoro flessibili ma onnipervasivi) e con la famiglia (è diventato padre da poco più di un mese).
Un giorno, dopo aver consumato il pranzo al solito bar, il signor Y accompagna il suo amico alla ‘macchinetta’ e prova anche lui a giocare. Il gioco lo ‘prende’ subito e l’indomani, così come i giorni seguenti, ripete l’esperienza.
In men che non si dica, il signor Y si ritrova confuso e angosciato perché si rende conto di non aver più il controllo della situazione. Giocare con le videolottery sembra piacergli, poiché ripete l’esperienza ma, subito dopo il gioco, si sente in colpa giacché sta perdendo dei soldi al bar, lasciando a casa da sole sua moglie e sua figlia, questo è il rimprovero che si fa. Vorrebbe smettere di giocare ma, quando si ritrova in un bar con del tempo libero a disposizione, dopo aver pranzato o per altre circostanze, non riesce a trattenersi e si trova compulsivamente spinto verso la ‘macchinetta’.
I colloqui si svolgono costantemente secondo uno stesso canovaccio: fa sempre molta fatica ad iniziare a parlare, afferma di non sapere che cosa dire e chiede che gli vengano poste delle domande. Il signor Y ha continuato a giocare dopo i primi colloqui, poi ha smesso e da circa un mese non sta giocando. Un giorno arriva al colloquio e, dopo aver sbrigativamente detto di stare bene, ripropone, incerto, il solito dubbioso schema: “Non so che cosa dire, sto bene; potrei parlare del tempo libero ma mi sembra inutile perché tanto il tempo libero va bene…”. Silenzio. Dopo poco decido di intervenire, facendogli notare che lui si è rivolto a me per il problema del gioco, attività che va ad innestarsi proprio in quel tempo che lui stesso definisce libero e che ora sta dicendo non comportargli problemi. Qualcosa non torna. “Ah, è vero…”, ci pensa su un attimo e poi prende a parlare di altro.
La ritrosia a parlare in seduta rappresenta, chiaramente, la difficoltà che il sig. Y vive nel parlare di se stesso, di ciò che lo abita e che lo attraversa, di ciò che sente muoversi dentro e che, per qualche motivo, ritiene di non poter esprimere. Come se, dalla pancia, o forse dal torace, come nel film ‘Alien’ di Ridley Scott, potesse uscire fuori qualcosa di incontenibile e inaccettabile: un mostro alieno, estraneo, inaspettato, sconosciuto.
Nel film, l’astronave ‘Nostromo’ sta tornando sulla terra dopo aver svolto una missione sul pianeta Thedus. L’equipaggio si trova in stato di ibernazione per il lungo viaggio che deve affrontare. Ad un certo momento, il computer di bordo riceve un segnale di aiuto, risvegliando così i membri dell’equipaggio. Tre di questi, Dallas, Kane e Lambert, sebbene perplessi e preoccupati, scendono con una navicella sul pianeta deserto dal quale proviene il segnale, per cercare di portare il loro soccorso. Lì, vedono il relitto di un’astronave aliena e vi entrano. Uno dei tre, Kane, entra in una stanza dell’astronave e vi trova delle grandi uova, una delle quali si apre. Ne fuoresce una massa viscida e appiccicosa che si attacca al casco di Kane, rompendolo, e rimanendo attaccata alla testa dell’astronauta. Gli altri due, accorsi in aiuto, prendono il collega rimasto senza sensi e lo riportano sulla navicella, contravvenendo alle regole previste dal protocollo per la sicurezza. Una volta dentro la navicella cercano di analizzare la massa aliena attaccata alla testa di Kane, non riuscendo però a scollarla. Capiscono che il loro collega si trova in uno stato di coma. Dopo poco la massa aliena si stacca da sola e cade a terra senza vita. La navetta rientra così sull’astronave madre e Kane si sveglia, incolume e, sembrerebbe, e per la contentezza di tutti, senza alcun danno. L’equipaggio, Kane compreso, prima di ripartire per il viaggio rimanente, si ritrova a cena, quando Kane inizia a star male: tossisce e manifesta violente e dolorose convulsioni. I colleghi lo tengono steso sul tavolo cercando di capire che cosa stia accadendo quando compare una macchia di sangue sul suo torace: ne esce improvvisamente, dilaniandolo, una creatura aliena, viscida, sanguinolenta e angosciante, che uccide Kane e scappa all’interno dell’astronave ‘Nostromo’.
Che cosa ci portiamo dentro, così come Kane, di così tanto angosciante e spaventoso?
Il Freud de ‘Introduzione alla psicoanalisi - Nuova serie di lezioni’ (1932) credo risponderebbe così:
“Ciò che si teme è evidentemente la propria libido. La differenza rispetto alla situazione dell’angoscia reale risiede in due punti: che il pericolo è interno invece che esterno, e che non viene riconosciuto consciamente come tale” (1932, p. 194).
È noto che il fondatore della psicoanalisi sostiene che l’angoscia sorgerebbe come segnale di pericolo di fronte alle pretese pulsionali, libidiche, del soggetto. Freud quando parla di pulsione intende “un certo ammontare di energia” che ha origine da un eccitamento nel corpo (“un concetto limite tra lo psichico e il somatico, […] il rappresentante psichico degli stimoli che traggono origine all’interno del corpo e pervengono alla psiche”, scrive in “Pulsioni e i loro destini”, nel 1915, p. 17) e che, diventando psichicamente attiva, preme verso una certa direzione, verso un’oggetto, “l’elemento più variabile della pulsione” (ibidem, p. 18), che possa permetterle la scarica, ovverosia l’eliminazione del suddetto eccitamento, ciò che costituisce la meta finale, il soddisfacimento, e che produce una sensazione di piacere.
Queste pretese libidiche, indicate da Freud anche con il termine di ‘bisogno’, vengono vissute internamente come una minaccia poiché il pensiero di un loro soddisfacimento evoca nel soggetto una situazione di pericolo esterno: un pericolo non necessariamente concreto, fattuale, ma senz’altro vissuto, soggettivamente, come reale e possibile (ad esempio, l’evirazione nel caso degli impulsi libidici verso la figura materna). Il soggetto avverte delle pulsioni libidiche che, in seguito al condizionamento educativo ed alle indicazioni morali ricevute dalle figure genitoriali e da lui fatte proprie, ritiene sconveniente esprimere socialmente, ritrovandosi a darsi dei limiti nella libera espressione delle proprie pulsioni: questo lo posso fare e quest’altro no. È da sottolineare che la famiglia, i genitori, fungono da tramite per recapitare al soggetto quelle richieste morali provenienti dalla società che mirerebbero a favorire la civile convivenza tra gli uomini. Rispetto a questa situazione che vive come pericolosa il soggetto, angosciato, può reprimere (se è ha un’organizzazione di personalità solida) o rimuovere (se ha un’organizzazione di personalità più debole) le proprie pretese pulsionali. Comunque sia, quando per motivi coscienti e quando per motivazioni inconsce, il soggetto arriva a negarsi, pur sentendone il bisogno, la possibilità di scaricare le proprie pulsioni mediante la ricerca di un oggetto specifico o la manifestazione di un’attività particolare, e si ritrova a fare i conti con una tensione interna, ora costituita da una commistione di pulsioni sessuali ed aggressive, che non riesce a risolvere: il risultato è che si sente male. Il soggetto, bloccato, si ammala.
Freud ritiene che questa mancanza di legittimità alla scarica pulsionale da parte del soggetto derivi da un “inconscio bisogno di punizione” (1932, p. 216) legato alla coscienza morale e interiorizzato sotto forma di Super-Io.
Pichon-Rivière, da parte sua, impernia il pensiero sull’idea che l’angoscia provata dal soggetto derivi dal non riuscire ad agire la propria motivazione, ovvero da un fallito adattamento (un adattamento passivo) rispetto alle richieste della situazione contestuale che vive. È questa la ‘malattia’ dell’essere umano. Il soggetto pichoniano, radicalmente e necessariamente rivolto verso l’esterno, per poter ottenere gratificazioni deve fare delle scelte oggettuali, deve stabilire dei vincoli con il mondo ‘fuori’. È nell’inevitabile esecuzione di questo compito che si scontra con l’angoscia, trovandosi al cospetto dell’ansia schizoparanoide (paura dell’attacco da parte dell’oggetto) e dell’ansia depressiva (paura della perdita dell’oggetto, cioè di distruggerlo): “Dalla nascita e durante il processo di sviluppo, il bambino soffre nella sua relazione con l’ambiente continue esigenze di adattamento. Si creano situazioni di conflitto tra le sue necessità e tendenze e le esigenze dell’ambiente. Nasce così l’angoscia come segnale di allarme di fronte al pericolo che crea la situazione conflittuale.” (1971, p. 252). Affrontare, elaborare e risolvere questi conflitti, ossia superare le ansie emergenti dai vincoli che lo legano al mondo esterno, permette al soggetto l’apprendimento e l’integrazione della realtà, ovvero “la capacità di trasformarla, modificando, a sua volta, se stesso” (ibidem, p. 250).
Per Pichon-Rivière la motivazione che spinge all’azione è da ricercarsi, più che nella ricerca della scarica di tensioni, come nella classica ipotesi freudiana, nella necessità che il soggetto vive di stabilire un vincolo con l’oggetto (realtà), di farlo proprio, di ‘apprenderlo’: ossia, potremmo dire, di apprendere la realtà. Non condivide l’idea delle pulsioni innate (Eros e Thanatos, spesso riportati con la formula istinto di vita ed istinto di morte) [bisogna specificare che nella traduzione in castigliano delle opere di Freud il termine tedesco 'Trieb', tradotto in italiano con 'pulsione', è stato tradotto con 'instinto', ossia 'istinto', cosa che ha probabilmente creato qualche confusione, non differenziando l'una dall'altro. Credo però che la sostanza del ragionamento pichionaiano non cambi] in grado di configurare il comportamento dell’individuo a priori, pensando invece ad una spinta, ad un impulso, dettato dalla necessità che si sperimenta in una situazione particolare. Le pulsioni che Freud chiama Eros e Thanatos, Pichon-Rivière le intende come comportamenti appresi, quando in una relazione vissuta come gratificante e quando come frustrante, dalle prime esperienze di interrelazione con l’ambiente. Il concetto di necessità, posto come condizione dello sviluppo della vita psichica del soggetto, situandosi nei vincoli che si istaurano con gli altri (soggetti/oggetti), si produce in rapporto alle proprie condizioni di vita. Sin dalla più precocissima età il soggetto internalizza le relazioni sociali sperimentate con il mondo esterno, ritrovandosi a confrontarsi con la riproduzione interna, “nell’ambito dell’io” (ibidem, p. 70), di quelle relazioni gruppali ed ecologiche sperimentate nel suo contesto di vita. Pichon-Rivière chiama ‘vincoli’ queste internalizzazioni e pensa a strutture vincolari che includono un soggetto, un oggetto e le loro reciproche interrelazioni, consce ed inconsce: dunque il soggetto ha a che fare, sin dall’inizio, con l’esperienza (sociale) e non con le pulsioni. La sfera inconscia sarà la risultante del rapporto tra le strutture vincolari internalizzate (che denomina gruppo interno) in continua interazione dialettica con gli oggetti del mondo esterno.
Il soggetto inizia a bloccarsi, e dunque ad ammalarsi, per l’incertezza e l’insicurezza che vive, da principio, in rapporto al gruppo a lui più vicino, quello che primariamente e maggiormente lo influenza, quello familiare: sperimentando una situazione gruppale nella quale la comunicazione viene ad essere caratterizzata da una molteplicità di interferenze e malintesi, percepisce che nella situazione attuale che sta vivendo succede qualcosa ma non riesce a capire che cosa, poiché “il gruppo dal quale proviene non gli permette di avere un’identità. La anormalità dei vincoli, i conflitti della comunicazione, rendono impossibile discriminare, sapere realmente ‘chi è chi’” (ibidem, p. 110). La confusa identità del soggetto viene invece rafforzata laddove risponda alle necessità del gruppo, a quegli obiettivi socialmente approvati, lì dove si ha la coincidenza tra ruolo aggiudicato, ossia il ruolo che il gruppo desidera il soggetto incarni, e ruolo assunto, quello che il soggetto va a ricoprire. Questa è una situazione con la quale il soggetto dovrà continuamente fare i conti. Risultando, la vita psichica del soggetto, dalla continua messa in discussione delle strutture vincolari già internalizzate che si confrontano con le necessità derivanti dalle nuove richieste sperimentate nella concretezza della vita quotidiana, il soggetto si trova costantemente ad interrogarsi sulla funzione da ricoprire all’interno dei suoi gruppi attuali, ovverosia su ciò che lo fa stare bene e su ciò che gli provoca, al contrario, malessere.
I precetti morali e valoriali della comunità sociale nella quale si vive, attraverso la famiglia, vengono interiorizzati: si interiorizza in questo modo l’istituzione e si ottiene così un primo abbozzo identitario. Nel tempo libero, non concretamente organizzato da una qualche istituzione esterna e dove ci si scontra con la mancanza di un compito predefinito, si crea una sorta di vuoto e si apre un pertugio per la possibilità della propria libera espressione. Si ha la possibilità di ‘giocare’, di confrontarsi con il ‘voler fare’ soggettivo piuttosto che con il ‘dover fare’ istituzionale, di aver a che fare con se stessi, di interrogarsi sulle proprie motivazioni e sulle proprie aspirazioni, ossia sulle proprie modalità di ricerca del piacere.
Ma, pur nell’assenza di una qualche concreta istituzione esterna, è lo sfondo psicotico (per dirla con Bleger) della vita del soggetto, costituito da una pervasività istituzionale discreta ma continua ed incessante, la cui parola dunque è assente soltanto in forma apparente, a rappresentare l’ostacolo principale per la ricerca della propria via.
D’altra parte, è proprio quel tempo cosiddetto libero, quel tempo non completamente organizzato e strutturato, ciò cui si è così disabituati che, interrogando il soggetto sulle proprie necessità, può essere inteso come un’opportunità per riorganizzare la propria individualità: ma una riorganizzazione che non deve essere pensata nei termini di una libertà assoluta, libera da ogni limite e da ogni vincolo, bensì sempre limitata, contingente, situazionale. Operativa. Una forma di libertà che può essere raggiunta solamente per mezzo di un fare motivato dalle proprie necessità giacché, suggerisce a conclusione di un suo scritto Pichon-Rivière (1966/67, p. 46), “si può essere liberi solo attraverso le motivazioni”.
Bibliografia
Bleger J. (1967), “Simbiosi e ambiguità”, Loreto, Edizioni Lauretana, 1992
Fischetti R., “Glossario blegeriano”, Roma, armando, 2014
Freud S. (1915), “Pulsioni e i loro destini”, in “Metapsicologia”, Torino, Bollati Boringhieri, 1993
Freud S. (1919), “Il perturbante”, Torino, Bollati Boringhieri, 2000
Freud S. (1921), “Psicologia delle masse e analisi dell’Io”, Torino, Bollati Boringhieri, 2000
Freud S. (1922), “L’Io e l’Es”, Torino, Bollati Boringhieri, 2000
Freud S. (1932), “Introduzione alla psicoanalisi – Nuova serie di lezioni”, Torino, Bollati Boringhieri, 1995
Galofaro F., “Dopo Gerico. I nuovi spazi della psichiatria”, Bologna, Editrice Esculapio, 2015
Lefebvre H. (1958), “Critica della vita quotidiana”, Bari, Dedalo edizioni, 1977
Nietzsche F. (1881-82), “La gaia scienza”, Milano, Adelphi, 2015
Pichon-Rivière E. (1966/67), “Psicologia de la vida cotidiana”, Buenos Aires, Nueva Vision, 2007
Pichon-Rivière E. (1971), “Dalla psicoanalisi alla psicologia sociale”, Loreto, Edizioni Lauretana, 1985
(L'articolo è tratto da 'Cuadernos de temas grupales e istitucionales', n° 21, Inverno 2017, www.area3.org.es, ed una versione ampliata del lavoro presentato nella "1ª Assemblea internazionale sulla ricerca nella Concezione Operativa di Gruppo", svoltasi a Rimini il 20-22 ottobre 2016. )
“…la noia è quella sgradevole ‘bonaccia dell’anima’, che precede il viaggio felice e i venti giulivi;
egli la deve sopportare, deve attenderne in sé gli effetti:
proprio questo è ciò che le nature inferiori non riescono assolutamente a ottenere da se medesime!
Fuggire con tutti i mezzi la noia è volgare: come è volgare lavorare senza piacere”
(Friederich Nietszche, La gaia scienza e Idilli di Messina).
Ritrovo la motivazione alla stesura di questo lavoro in due stimoli che mi hanno toccato qualche tempo fa, nel giro di pochissimi giorni di distanza l’uno dall’altro: il primo, durante un colloquio che ho svolto con un paziente, del quale farò menzione più avanti; e il secondo, nel corso della presentazione di un libro che, seppur avesse altro oggetto come tema, mi ha dato l’occasione di riflettere ulteriormente su quel medesimo pensiero. Ciò che fondamentalmente mi ha colpito, in ambedue le circostanze, è stata l’idea di una piatta assenza di pensiero riguardo a quei momenti che fanno parte della vita delle persone e che comunemente vengono indicati con la formula "tempo libero", ovvero un tempo connotato dalla non direttività e dalla non obbligatorietà, e che per ciò stesso viene sovente inteso come vuoto. Un tempo che spesso viene dato per scontato e a cui si fa fatica a dare un senso, e nel quale pare essere la stereotipia, l’automaticità priva di prospettive, a guidare le vite e le condotte dei protagonisti di quei momenti. Ma che tipo di rapporto intercorre tra l’uomo e questo tempo nel quale, potremmo dire, egli ha disponibilità di se stesso? Che cosa produce in lui e come viene affrontato questo tempo scevro da impegni e doveri?
Come anticipato, in questo percorso parto dal secondo stimolo, ovverosia la presentazione del libro di Francesco Galofaro, dottore di ricerca in semiotica, dal titolo “Dopo Gerico. I nuovi spazi della psichiatria” (2015). Nel libro si descrive l’esperienza che l’autore ha avuto modo di fare all’interno di un progetto residenziale per persone con diagnosi di schizofrenia; gruppi di 3-5 persone, in carico al SSN, abitano appartamenti pressoché completamente gestiti da loro stessi. L’unico aiuto esterno che queste persone hanno è costituito dagli assistenti familiari che monitorano l’assunzione della terapia farmacologica per ognuna di esse.
Galofaro, con il compito di fare una valutazione del servizio in termini di efficacia e ripetibilità, ha frequentato per diverso tempo gli appartamenti di queste persone, condividendo con loro esperienze, interrogandosi sui valori che vengono chiamati in causa in queste situazioni e, cercando di auto-osservarsi nella relazione che si osserva, raccogliendo dati mediante interviste più o meno strutturate. Un punto di enorme interesse dell’esperienza riportata nel libro, almeno per chi scrive, riguarda la questione della vita in comune, della quotidianità condivisa, della collettività forzata, e la ricerca di propri spazi di individualità.
Una domanda che Galofaro pone riguarda, in effetti, le modalità di ricerca e di recupero di una propria individualità in una condizione di residenzialità condivisa, per così dire, obbligata. Perché, certamente, si tratta di persone che stanno facendo un’esperienza positiva al di fuori di situazioni di contenimento psichiatrico ben note, però è un’esperienza che richiede la condivisione di spazi e tempi di cui, più che comprensibilmente, si farebbe volentieri a meno. L’osservazione della vita di queste persone ha portato a registrare una quotidianità costituita pressoché esclusivamente da routines. All’interno dell’organizzazione della vita degli appartamenti si fanno sempre le stesse cose: ciascuno ha i suoi propri riti che cerca di incastrare con quelli degli altri coinquilini. La routine la fa da padrona e la ripetizione delle stesse pratiche e delle stesse azioni pare costituire il perno dell’autogestione degli appartamenti. E la routine individuale viene ad avere un senso se rapportata alla routine collettiva, ciò che sembra gettare in una situazione di indifferenziazione gli abitanti dell’appartamento. La condivisione dell’appartamento, contraddistinta dai programmi giornalieri individuali sempre identici, comporta un deposito di tipo collettivo, gruppale: ossia, quell’appartamento non viene considerato segno distintivo della proprietà di uno, ma sollecita un vissuto abitudinario di con-divisione, stimolando l’idea dell’assorbimento del soggetto nello spazio (psico)fisico collettivo.
Ragion per cui, un modo che si è trovato per recuperare la propria individualità pare essere quello della privatizzazione degli spazi. In genere, si tende a privatizzare le stanze da letto, ma spesso le stanze vengono condivise con un’altra persona. Se un inquilino della casa ‘personalizza’ una stanza condivisa, allora la soluzione che viene adottata è che il compagno di stanza occuperà simbolicamente, ‘personalizzerà’ appunto, un altro spazio dell’appartamento, per esempio la sala. La privatizzazione di un spazio dell’appartamento sembra garantire l’intima convinzione di essere identificati come portatori di una propria individualità e, quindi, di potersi riconoscere come persone. In altri termini, il modo che viene utilizzato per recuperare il segno della propria individualità è costituito dal deposito della propria personalità in uno spazio dell’appartamento che viene organizzato secondo le proprie preferenze.
Capita che, ogni tanto, vengano organizzate delle ‘uscite’ con gli inquilini dei vari appartamenti, allora può accadere che ci si ritrovi a poter soggiornare per qualche giorno in una casa in montagna. In una situazione che, seppur caratterizzata da molte novità, da un cambiamento della routine abituale, continua però ad essere contraddistinta dai programmi: si devono fare delle attività, magari ludiche, ma pur sempre organizzate e predefinite. Lo svolgimento della propria vita si situa all’interno di un’organizzazione esistenziale già predisposta da altri.
Galofaro racconta di uno di questi soggiorni, in una grande casa colonica di montagna, che ha portato a confrontarsi con una quasi completa destrutturazione delle abitudini degli inquilini: “Lo spazio della casa colonica è tale da destrutturare quasi del tutto le regole usuali dell’appartamento e da causare una crisi delle funzioni attanziali che abbiamo individuato nella nostra analisi semiolinguistica: esso consiste in stanze molto grandi e prive di privacy; le dimensioni inusuali fanno sì che il peso della cura della casa e della preparazione del pranzo ricada quasi esclusivamente sulle assistenti, che finiscono per sostituirsi ai soggetti nella routine della cura domestica e non riescono più ad esercitare la funzione di destinanti” (2015, p. 54). In più, a causa del maltempo incontrato durante i giorni del soggiorno, salta, oltre la programmazione spaziale, anche quella temporale, poiché vengono ridotte le gite o le passeggiate che si aveva in proposito di fare.
Queste rotture dei programmi mettono gli ospiti (cioè, i beneficiari del progetto di reinserimento) in una situazione nuova: hanno del tempo veramente libero, non organizzato, e si ritrovano di fronte al vuoto. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, invece di utilizzare quel tempo libero a proprio piacere, visto che gli ospiti avrebbero potuto sfruttarlo come desideravano, essi non hanno saputo che cosa farne (“naufragano nella noia”, scrive Galofaro), entrando in crisi: chi stava ore in branda, chi fumava in continuazione, chi stava seduto guardando le pareti. Nel tempo libero, la noia. Come si risolve il problema della noia? Che cosa ci si fa con quel tempo libero?
La rottura del programma precostituito che organizza a priori la vita degli utenti sembra conduca all’opportunità di una nuova e diversa interrogazione su di sé, ovverosia a come poter gestire questo tempo-spazio vuoti.
Intermezzo psicoanalitico: la simbiosi istituzionale
Nel suo articolo forse più noto, “Psicoanalisi dell’inquadramento psicoanalitico” del 1967, Bleger afferma che la situazione psicoanalitica è caratterizzata dall’insieme dei fenomeni che avvengono nella relazione tra analista e paziente, e che questa situazione sia costituita da un processo, ovvero ciò che avviene all’interno della relazione, e da un non-processo, ossia l’inquadramento o setting, definito da alcune costanti (tempo, spazio, ruolo, compito) che costituiscono la cornice all’interno della quale il processo può svolgersi ed essere analizzato. Il fatto che il rapporto analitico duri anni e si fondi su un insieme di norme e attitudini permette di caratterizzarlo come un’istituzione, dunque l’inquadramento è “un’istituzione nel cui ambito si verificano dei fenomeni che chiamiamo comportamenti” (1967, p. 272). Per Bleger l’istituzione funge da deposito di parte della personalità dell’individuo, tanto che “l’identità è sempre – parzialmente o totalmente – un’identità di gruppo o istituzionale” (ibidem, p. 273), cioè si struttura per mezzo dell’appartenenza a gruppi o istituzioni.
Il soggetto non ha consapevolezza di questo processo poiché nelle istituzioni proietta il suo ‘mondo fantasma’, ossia il proprio modo di vedere le cose e relazionarsi con l’esterno, un modo che, partendo dal rapporto simbioticamente connotato con la figura materna, lo ha organizzato sin dalle primissime fasi della sua vita.
Se mantenere l’inquadramento, e la sua costanza, permette il lavoro di analisi, d’altra parte è proprio questa invarianza che porta a scontrarsi con un problema. In effetti, se l’inquadramento si mantiene invariato, viene a collocarsi sullo sfondo della relazione non essendo più preso in considerazione dal paziente. Diventa ‘muto’ poiché “ciò che è sempre presente non viene percepito” (ibidem, p. 273). L’invarianza di una situazione, come nel rapporto simbiotico, permette la proiezione di una parte di sé, quella che Bleger chiama ‘parte psicotica della personalità’ o ‘non-io’, in essa. La ‘parte psicotica della personalità’ o ‘non-io’ è fondamentale, secondo Bleger, per la formazione e l’organizzazione dell’io, dell’identità individuale, poiché è quella parte indifferenziata che costituisce il fondamento e la cornice dell’identità di una persona, è il ‘meta-io’. Probabilmente, in termini ‘gestaltici’, potrebbe essere definita lo sfondo dal quale, di volta in volta, emerge la figura, l’io, ossia la parte nevrotica della personalità, quella parte capace di stabilire relazioni con il mondo esterno e variarle a seconda delle circostanze.
Partendo dal concetto di ‘baluardo’ di M. e W. Baranger, ossia “quell’aspetto che l’analizzato cerca di non mettere in gioco, eludendo la regola fondamentale” (ibidem, p. 272) e che corrisponderebbe alla parte psicotica, o indifferenziata, della personalità, Bleger appoggia l’idea che il rapporto analitico con il suo perpetuarsi venga a costituirsi come un rapporto simbiotico. Nota, però, che con il perpetuarsi immutato dell’inquadramento è questo che diviene il depositario della parte simbiotica (psicotica) della personalità, ovverosia il ‘baluardo’ viene depositato nell’inquadramento. Aggiunge, inoltre, che in un contesto analitico gli inquadramenti da considerare sarebbero due: quello proposto dall’analista e accettato consapevolmente dal paziente e “quello in cui il paziente proietta il suo ‘mondo fantasma’. E quest’ultimo è una coazione a ripetere tanto più perfetta in quanto è la più completa, la meno conosciuta e percepibile” (ibidem, p. 276).
Ora, è con la rottura dell’inquadramento (dovuta per esempio alle vacanze, al cambiamento di un orario, all’impossibilità di essere presenti al colloquio e via dicendo) che si apre una fessura, un varco, attraverso cui può emergere la parte psicotica, il mondo fantasma, l’inquadramento del paziente, che rimangono senza depositari. Emerge la differenza tra l’inquadramento proposto dall’analista e quello proiettato nella situazione analitica dal paziente, comportando, questa destrutturazione, vissuti angoscianti: “Per il paziente si era rotto ‘qualcosa’ che era così e doveva essere come era sempre stato, e che egli non concepiva potesse essere in un altro modo. Esigeva che si ripetesse il vissuto…” (ibidem, p. 275). Fa irruzione una realtà fino ad allora non contemplata, mettendo in crisi il non-io e problematizzando l’io, che deve reintroiettare la sua parte simbiotica e trovare nuove difese per immobilizzarla o riproiettarla. È la rottura di un rapporto primitivo di assuefazione che, se non sistematicamente analizzato, si stabilizza andando a costituire la base dell’organizzazione della personalità. Si ha a che fare, in tali casi, con un io ‘adattato’: “questo ‘io fattico’ è un ‘io di appartenenza’ che si è formato e mantenuto grazie all’inserimento del soggetto in un’istituzione (che può essere la relazione terapeutica, l’Associazione Psicoanalitica Argentina, un gruppo di studio o di qualsiasi altro tipo): non è un ‘io interiorizzato’ che dia al soggetto stabilità interiore” (ibidem, p. 280).
La situazione descritta da Bleger sembra avere qualche attinenza con quella descritta da Galofaro a proposito della vacanza in montagna: i beneficiari del progetto di reinserimento, che fondano la propria quotidianità sulla programmazione e sull’abitudinarietà, nella vacanza in montagna avrebbero dovuto godere di uno stacco dalla routine quotidiana. Si trattava però di uno stacco o, per meglio dire, di un tempo libero, già organizzato (casa colonica, escursioni, gite, ecc.), istituito: anche lì ci si muoveva all’interno di una routine. La routine viene rotta poiché la struttura della casa colonica, l’apporto degli assistenti familiari e le condizioni metereologiche non permettono di sviluppare le giornate come si era previsto. Questa condizione è ‘sorprendente’, inaspettata, e mette di fronte ad una situazione cui non si pensava e alla quale non si è abituati. La rottura della routine provoca la fuoriuscita da una dimensione istituzionalizzata e mette gli ospiti a confronto con l’esperienza di sé e delle necessità del proprio corpo che, non pensate a priori, richiedono di essere prese in carico soggettivamente e soddisfatte.
Una quotidianità perturbante
Il sociologo francese Henri Lefebvre, in “Critica della vita quotidiana”, un testo del 1958, propone un’analisi del concetto di tempo libero e nota che, nell’epoca precedente all’avvento della società borghese, questo tempo non programmato veniva determinato dal lavoro, ossia “gli imperativi della comunità contadina” (1958, p. 36) con le loro necessità organizzavano sia il lavoro e sia il tempo libero. Con l’avvento della società industriale si è assistito ad una valorizzazione e alla conseguente parcellizzazione dell’attività lavorativa che ha portato alla netta distinzione (almeno nelle classi privilegiate) tra uomo “in quanto uomo” (ibidem, p. 37) e uomo come lavoratore. La vita familiare, diversamente da quanto avveniva precedentemente all’interno di un contesto di vita contadino, si separa dall’attività lavorativa: e lo stesso avviene per il tempo libero.
La società moderna industriale, con la richiesta di maggior specializzazione nel lavoro, e dunque con la netta separazione rispetto alla vita al di fuori del lavoro, ha suscitato un bisogno generale di tempo libero, cui ha prontamente risposto mediante la creazione di tecniche (intendendo con questo termine sia la creazione di apparecchi tecnologici quali la radio, la televisione, la macchina fotografica, ecc. e sia la predisposizione di luoghi o interessi ‘di vita’ come il bar, la sagra paesana, lo sport, l’hobby e via dicendo) aventi lo scopo di soddisfare quei nuovi bisogni sociali.
Ora l’esigenza maggiore viene ad essere quella della rottura: una rottura con la quotidianità, non soltanto lavorativa, ma anche con la quotidianità familiare. Si accentua il carattere di divertimento e, in questo tempo ‘liberato’, non si vogliono vivere preoccupazioni o obblighi o necessità, ma solamente si vuole sentirsi liberi e godere: “L’uomo cosiddetto ‘moderno’ spera dunque di trovare nel tempo libero ciò che il suo lavoro e la sua vita familiare o ‘privata’, non gli danno” (ibidem, p. 39). Il tempo libero viene a rappresentare “il non-quotidiano nel quotidiano” (ibidem, p. 47), ma si tratta di un’evasione dal quotidiano che può avere solamente un carattere illusorio giacché, puntualizza Lefebvre, non è possibile concretamente uscire dalla propria quotidianità. L’uomo aspira al tempo libero per liberarsi dal lavoro fonte di alienazione, ovvero uscire dalla propria quotidianità, e si ritrova a fare i conti con un tempo libero comunque organizzato socialmente che, sebbene espressione di un bisogno e segno di critica rispetto ad una quotidianità vissuta come alienante, si pone esso stesso come illusorio e ingannevole, dunque, almeno parzialmente, alienante.
In sintesi: la quotidianità è contraddistinta da una complessa organizzazione sociale che permea, in qualche grado regolandole e disciplinandole, tutte le sfere dell’umana esistenza (lavoro, tempo libero, vita familiare e vita privata): è questa costante organizzazione sociale, all’interno della quale l’uomo si trova a vivere, ad estraniare l’uomo da se stesso. In altri termini, è l’istituzione della quotidianità ad essere alienante e la questione fondamentale, la preoccupazione, riprendendo ancora Lefebvre, è quella “di far emergere il vivo, il nuovo, il positivo – i bisogni e le giuste soddisfazioni – dagli elementi negativi: dalle alienazioni” (ibidem, p. 49).
Compito, quest’ultimo enunciato da Lefebvre, la cui attuazione sembrerebbe tutt’altro che semplice e immediata. L’esperienza, in effetti, sembra proporre l’idea che non sia così facile dare corso a ciò che stimola l’uomo, ai suoi bisogni emergenti e alle “giuste soddisfazioni”. C’è qualcosa che sembra frapporsi tra l’uomo e la soddisfazione dei propri impulsi vitali, tra l’uomo e l’espressione della propria creatività ed originalità.
Il concetto espresso da Lefebvre con la formula “il non-quotidiano nel quotidiano” richiama alla mente l’idea freudiana di ‘perturbante’. Perturbante è la traduzione in italiano del tedesco unheimlich, antitetico al termine heimlich che, derivante da Heim, cioè casa, si può tradurre con confortevole, tranquillo. Freud ritiene che il perturbante sia “quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare” (1919, p. 83), una sensazione angosciosa che può derivare dal rinnovarsi di elementi infantili rimossi che vengono risvegliati da un impressione attuale o da convinzioni considerate superate che trovano una nuova convalida nella quotidianità.
Ricollegandomi anche a quanto espresso da Bleger a proposito della parte simbiotica della personalità, penso si possa esprimere ciò che Freud afferma sul perturbante, nel 1919, in questo modo: c’è qualcosa in più di quello che si riesce a comprendere nel modo di vivere la propria vita, la propria quotidianità; quando emerge questo qualcosa in più, che c’è sempre stato ma che fino ad un certo momento non si aveva la possibilità di considerare, si vive l’esperienza angosciosa del perturbante.
Enrique Pichon-Rivière in “Psicologia de la vida cotidiana” dedica diverse riflessioni alla questione dell’ozio. Sulla scorta di Freud afferma che attraverso il lavoro l’uomo riesce a darsi un equilibrio, mantenendo un fermo legame con la realtà e con la collettività. L’ozio, invece, costituirebbe un “atteggiamento mentale che ci permette di dedicarci a una determinata attività senza pensare prima ai risultati utili o pratici inerenti la vita” (1966/67, p. 33). Nell’ozio il soggetto, non sottoposto al vincolo dell’obbligatorietà, può dedicarsi ad aspetti della vita solitamente non coltivati a causa delle pressioni cui si è sottoposti dalle esigenze della quotidianità. Ma, d’altra parte, molte esperienze sembrano suggerire che la privazione di lavoro, dunque di un’attività vissuta con obbligatorietà, possa sfociare in situazioni soggettive di malessere; vedasi, per esempio, lo stato depressivo che spesso coglie i lavoratori all’indomani della sopraggiunta pensione. Di conseguenza, capita frequentemente che chi si ritrova con del tempo libero per oziare, se lo riempia con una serie di attività sociali (ma anche antisociali).
Una delle modalità utilizzate nella società industriale capitalista per riempire il tempo libero, il tempo della non obbligatorietà del lavoro, è la vacanza. Se prima il tempo libero veniva inteso come tempo da dedicare al riposo e alla pigrizia, ora l’uomo-consumatore viene stimolato dalla pubblicità e dalla voce dei mass media a soddisfare i propri desideri di felicità mediante modalità appartenenti, tradizionalmente, alle classi sociali più ricche. L’immaginario legato al tempo libero è ora quello del viaggio e della vacanza, attraverso cui coltivare il corpo e lo spirito e ricercare lo scambio culturale e l’interazione con gli altri. Si tratta, nota Pichon-Rivière, di un ozio istituzionalizzato.
Il tempo libero dell’ozio sarebbe il tempo del gioco, che l’analista svizzero-argentino definisce così: “Questa azione gratuita, deliberata e liberamente realizzata, racchiude in sé un universo, retto da leggi proprie, simile al mondo del sogno. Come in questo, diminuisce il potere repressivo della censura precedente e i desideri di ogni tipo trovano espressione nei gesti e nel linguaggio simbolico di questa forma di finzione. Ogni gioco persegue un obiettivo. Si tratta di costruire, attraverso un’attività particolare, uno schema che permetta di operare sulla realtà. La sua missione non si esaurisce in una liberazione di desideri occulti o repressi, ma mira ad una nuova pianificazione della realtà. Per questo risulta una delle forme più efficienti di apprendimento” (ibidem, p. 136).
Nella società moderna industriale, meccanizzata e automatizzata, il gioco rappresenta la possibilità della spontaneità e della libertà dell’atto creativo, seppure entro una cornice costituita da regole fisse cui si aderisce volontariamente. Il tempo del gioco, un tempo limitato ma che esige un abbandono e un’attenzione quasi assolute, può significare “l’opportunità di superare la frustrazione che soffriamo nel mondo della responsabilità familiare o del lavoro” (ibidem, p. 137).
Uno dei tratti fondamentali che attrae al gioco è l’incertezza. Non si conosce in anticipo il risultato, così, nel mistero del gioco, si può ritrovare la necessità di una sfida lanciata ad un destino ostile vissuto con frustrazione: tanto nei giochi che si fondano sulla competizione quanto in quelli definiti d’azzardo. In questi ultimi, che in genere si intensificano durante le vacanze quando non si hanno compiti prefissati da svolgere, si può ipotizzare l’intenzione di risolvere la propria frustrazione con l’illusione di “costruire il proprio destino sulla base della fantasia dell’incontro fortuito. È un’altra forma di strategia di fronte alla morte, un piano che si azzarda ad incontrare l’insolito”. Poiché, conclude Pichon-Rivière, “Il gioco ci strappa dall’impotenza di un ozio non pianificato, da un tempo che doveva essere vissuto come proprio e che sentiamo ci sta sfuggendo” (ibidem, p. 138).
L’alieno, dentro
Il signor Y si rivolge a me per un problema con il gioco d’azzardo: nello specifico gioca con le videolottery. Dice che ha iniziato a giocare per caso, seguendo l’esempio di un amico che frequenta lo stesso bar. Quel bar viene frequentato tutti i giorni poiché lì il signor Y fa la sua pausa pranzo dal lavoro. È un momento della giornata che viene indicato dal signor Y come dedito al relax, altrimenti si ritrova sempre impegnato con il lavoro (essendo un piccolo imprenditore ha tempi di lavoro flessibili ma onnipervasivi) e con la famiglia (è diventato padre da poco più di un mese).
Un giorno, dopo aver consumato il pranzo al solito bar, il signor Y accompagna il suo amico alla ‘macchinetta’ e prova anche lui a giocare. Il gioco lo ‘prende’ subito e l’indomani, così come i giorni seguenti, ripete l’esperienza.
In men che non si dica, il signor Y si ritrova confuso e angosciato perché si rende conto di non aver più il controllo della situazione. Giocare con le videolottery sembra piacergli, poiché ripete l’esperienza ma, subito dopo il gioco, si sente in colpa giacché sta perdendo dei soldi al bar, lasciando a casa da sole sua moglie e sua figlia, questo è il rimprovero che si fa. Vorrebbe smettere di giocare ma, quando si ritrova in un bar con del tempo libero a disposizione, dopo aver pranzato o per altre circostanze, non riesce a trattenersi e si trova compulsivamente spinto verso la ‘macchinetta’.
I colloqui si svolgono costantemente secondo uno stesso canovaccio: fa sempre molta fatica ad iniziare a parlare, afferma di non sapere che cosa dire e chiede che gli vengano poste delle domande. Il signor Y ha continuato a giocare dopo i primi colloqui, poi ha smesso e da circa un mese non sta giocando. Un giorno arriva al colloquio e, dopo aver sbrigativamente detto di stare bene, ripropone, incerto, il solito dubbioso schema: “Non so che cosa dire, sto bene; potrei parlare del tempo libero ma mi sembra inutile perché tanto il tempo libero va bene…”. Silenzio. Dopo poco decido di intervenire, facendogli notare che lui si è rivolto a me per il problema del gioco, attività che va ad innestarsi proprio in quel tempo che lui stesso definisce libero e che ora sta dicendo non comportargli problemi. Qualcosa non torna. “Ah, è vero…”, ci pensa su un attimo e poi prende a parlare di altro.
La ritrosia a parlare in seduta rappresenta, chiaramente, la difficoltà che il sig. Y vive nel parlare di se stesso, di ciò che lo abita e che lo attraversa, di ciò che sente muoversi dentro e che, per qualche motivo, ritiene di non poter esprimere. Come se, dalla pancia, o forse dal torace, come nel film ‘Alien’ di Ridley Scott, potesse uscire fuori qualcosa di incontenibile e inaccettabile: un mostro alieno, estraneo, inaspettato, sconosciuto.
Nel film, l’astronave ‘Nostromo’ sta tornando sulla terra dopo aver svolto una missione sul pianeta Thedus. L’equipaggio si trova in stato di ibernazione per il lungo viaggio che deve affrontare. Ad un certo momento, il computer di bordo riceve un segnale di aiuto, risvegliando così i membri dell’equipaggio. Tre di questi, Dallas, Kane e Lambert, sebbene perplessi e preoccupati, scendono con una navicella sul pianeta deserto dal quale proviene il segnale, per cercare di portare il loro soccorso. Lì, vedono il relitto di un’astronave aliena e vi entrano. Uno dei tre, Kane, entra in una stanza dell’astronave e vi trova delle grandi uova, una delle quali si apre. Ne fuoresce una massa viscida e appiccicosa che si attacca al casco di Kane, rompendolo, e rimanendo attaccata alla testa dell’astronauta. Gli altri due, accorsi in aiuto, prendono il collega rimasto senza sensi e lo riportano sulla navicella, contravvenendo alle regole previste dal protocollo per la sicurezza. Una volta dentro la navicella cercano di analizzare la massa aliena attaccata alla testa di Kane, non riuscendo però a scollarla. Capiscono che il loro collega si trova in uno stato di coma. Dopo poco la massa aliena si stacca da sola e cade a terra senza vita. La navetta rientra così sull’astronave madre e Kane si sveglia, incolume e, sembrerebbe, e per la contentezza di tutti, senza alcun danno. L’equipaggio, Kane compreso, prima di ripartire per il viaggio rimanente, si ritrova a cena, quando Kane inizia a star male: tossisce e manifesta violente e dolorose convulsioni. I colleghi lo tengono steso sul tavolo cercando di capire che cosa stia accadendo quando compare una macchia di sangue sul suo torace: ne esce improvvisamente, dilaniandolo, una creatura aliena, viscida, sanguinolenta e angosciante, che uccide Kane e scappa all’interno dell’astronave ‘Nostromo’.
Che cosa ci portiamo dentro, così come Kane, di così tanto angosciante e spaventoso?
Il Freud de ‘Introduzione alla psicoanalisi - Nuova serie di lezioni’ (1932) credo risponderebbe così:
“Ciò che si teme è evidentemente la propria libido. La differenza rispetto alla situazione dell’angoscia reale risiede in due punti: che il pericolo è interno invece che esterno, e che non viene riconosciuto consciamente come tale” (1932, p. 194).
È noto che il fondatore della psicoanalisi sostiene che l’angoscia sorgerebbe come segnale di pericolo di fronte alle pretese pulsionali, libidiche, del soggetto. Freud quando parla di pulsione intende “un certo ammontare di energia” che ha origine da un eccitamento nel corpo (“un concetto limite tra lo psichico e il somatico, […] il rappresentante psichico degli stimoli che traggono origine all’interno del corpo e pervengono alla psiche”, scrive in “Pulsioni e i loro destini”, nel 1915, p. 17) e che, diventando psichicamente attiva, preme verso una certa direzione, verso un’oggetto, “l’elemento più variabile della pulsione” (ibidem, p. 18), che possa permetterle la scarica, ovverosia l’eliminazione del suddetto eccitamento, ciò che costituisce la meta finale, il soddisfacimento, e che produce una sensazione di piacere.
Queste pretese libidiche, indicate da Freud anche con il termine di ‘bisogno’, vengono vissute internamente come una minaccia poiché il pensiero di un loro soddisfacimento evoca nel soggetto una situazione di pericolo esterno: un pericolo non necessariamente concreto, fattuale, ma senz’altro vissuto, soggettivamente, come reale e possibile (ad esempio, l’evirazione nel caso degli impulsi libidici verso la figura materna). Il soggetto avverte delle pulsioni libidiche che, in seguito al condizionamento educativo ed alle indicazioni morali ricevute dalle figure genitoriali e da lui fatte proprie, ritiene sconveniente esprimere socialmente, ritrovandosi a darsi dei limiti nella libera espressione delle proprie pulsioni: questo lo posso fare e quest’altro no. È da sottolineare che la famiglia, i genitori, fungono da tramite per recapitare al soggetto quelle richieste morali provenienti dalla società che mirerebbero a favorire la civile convivenza tra gli uomini. Rispetto a questa situazione che vive come pericolosa il soggetto, angosciato, può reprimere (se è ha un’organizzazione di personalità solida) o rimuovere (se ha un’organizzazione di personalità più debole) le proprie pretese pulsionali. Comunque sia, quando per motivi coscienti e quando per motivazioni inconsce, il soggetto arriva a negarsi, pur sentendone il bisogno, la possibilità di scaricare le proprie pulsioni mediante la ricerca di un oggetto specifico o la manifestazione di un’attività particolare, e si ritrova a fare i conti con una tensione interna, ora costituita da una commistione di pulsioni sessuali ed aggressive, che non riesce a risolvere: il risultato è che si sente male. Il soggetto, bloccato, si ammala.
Freud ritiene che questa mancanza di legittimità alla scarica pulsionale da parte del soggetto derivi da un “inconscio bisogno di punizione” (1932, p. 216) legato alla coscienza morale e interiorizzato sotto forma di Super-Io.
Pichon-Rivière, da parte sua, impernia il pensiero sull’idea che l’angoscia provata dal soggetto derivi dal non riuscire ad agire la propria motivazione, ovvero da un fallito adattamento (un adattamento passivo) rispetto alle richieste della situazione contestuale che vive. È questa la ‘malattia’ dell’essere umano. Il soggetto pichoniano, radicalmente e necessariamente rivolto verso l’esterno, per poter ottenere gratificazioni deve fare delle scelte oggettuali, deve stabilire dei vincoli con il mondo ‘fuori’. È nell’inevitabile esecuzione di questo compito che si scontra con l’angoscia, trovandosi al cospetto dell’ansia schizoparanoide (paura dell’attacco da parte dell’oggetto) e dell’ansia depressiva (paura della perdita dell’oggetto, cioè di distruggerlo): “Dalla nascita e durante il processo di sviluppo, il bambino soffre nella sua relazione con l’ambiente continue esigenze di adattamento. Si creano situazioni di conflitto tra le sue necessità e tendenze e le esigenze dell’ambiente. Nasce così l’angoscia come segnale di allarme di fronte al pericolo che crea la situazione conflittuale.” (1971, p. 252). Affrontare, elaborare e risolvere questi conflitti, ossia superare le ansie emergenti dai vincoli che lo legano al mondo esterno, permette al soggetto l’apprendimento e l’integrazione della realtà, ovvero “la capacità di trasformarla, modificando, a sua volta, se stesso” (ibidem, p. 250).
Per Pichon-Rivière la motivazione che spinge all’azione è da ricercarsi, più che nella ricerca della scarica di tensioni, come nella classica ipotesi freudiana, nella necessità che il soggetto vive di stabilire un vincolo con l’oggetto (realtà), di farlo proprio, di ‘apprenderlo’: ossia, potremmo dire, di apprendere la realtà. Non condivide l’idea delle pulsioni innate (Eros e Thanatos, spesso riportati con la formula istinto di vita ed istinto di morte) [bisogna specificare che nella traduzione in castigliano delle opere di Freud il termine tedesco 'Trieb', tradotto in italiano con 'pulsione', è stato tradotto con 'instinto', ossia 'istinto', cosa che ha probabilmente creato qualche confusione, non differenziando l'una dall'altro. Credo però che la sostanza del ragionamento pichionaiano non cambi] in grado di configurare il comportamento dell’individuo a priori, pensando invece ad una spinta, ad un impulso, dettato dalla necessità che si sperimenta in una situazione particolare. Le pulsioni che Freud chiama Eros e Thanatos, Pichon-Rivière le intende come comportamenti appresi, quando in una relazione vissuta come gratificante e quando come frustrante, dalle prime esperienze di interrelazione con l’ambiente. Il concetto di necessità, posto come condizione dello sviluppo della vita psichica del soggetto, situandosi nei vincoli che si istaurano con gli altri (soggetti/oggetti), si produce in rapporto alle proprie condizioni di vita. Sin dalla più precocissima età il soggetto internalizza le relazioni sociali sperimentate con il mondo esterno, ritrovandosi a confrontarsi con la riproduzione interna, “nell’ambito dell’io” (ibidem, p. 70), di quelle relazioni gruppali ed ecologiche sperimentate nel suo contesto di vita. Pichon-Rivière chiama ‘vincoli’ queste internalizzazioni e pensa a strutture vincolari che includono un soggetto, un oggetto e le loro reciproche interrelazioni, consce ed inconsce: dunque il soggetto ha a che fare, sin dall’inizio, con l’esperienza (sociale) e non con le pulsioni. La sfera inconscia sarà la risultante del rapporto tra le strutture vincolari internalizzate (che denomina gruppo interno) in continua interazione dialettica con gli oggetti del mondo esterno.
Il soggetto inizia a bloccarsi, e dunque ad ammalarsi, per l’incertezza e l’insicurezza che vive, da principio, in rapporto al gruppo a lui più vicino, quello che primariamente e maggiormente lo influenza, quello familiare: sperimentando una situazione gruppale nella quale la comunicazione viene ad essere caratterizzata da una molteplicità di interferenze e malintesi, percepisce che nella situazione attuale che sta vivendo succede qualcosa ma non riesce a capire che cosa, poiché “il gruppo dal quale proviene non gli permette di avere un’identità. La anormalità dei vincoli, i conflitti della comunicazione, rendono impossibile discriminare, sapere realmente ‘chi è chi’” (ibidem, p. 110). La confusa identità del soggetto viene invece rafforzata laddove risponda alle necessità del gruppo, a quegli obiettivi socialmente approvati, lì dove si ha la coincidenza tra ruolo aggiudicato, ossia il ruolo che il gruppo desidera il soggetto incarni, e ruolo assunto, quello che il soggetto va a ricoprire. Questa è una situazione con la quale il soggetto dovrà continuamente fare i conti. Risultando, la vita psichica del soggetto, dalla continua messa in discussione delle strutture vincolari già internalizzate che si confrontano con le necessità derivanti dalle nuove richieste sperimentate nella concretezza della vita quotidiana, il soggetto si trova costantemente ad interrogarsi sulla funzione da ricoprire all’interno dei suoi gruppi attuali, ovverosia su ciò che lo fa stare bene e su ciò che gli provoca, al contrario, malessere.
I precetti morali e valoriali della comunità sociale nella quale si vive, attraverso la famiglia, vengono interiorizzati: si interiorizza in questo modo l’istituzione e si ottiene così un primo abbozzo identitario. Nel tempo libero, non concretamente organizzato da una qualche istituzione esterna e dove ci si scontra con la mancanza di un compito predefinito, si crea una sorta di vuoto e si apre un pertugio per la possibilità della propria libera espressione. Si ha la possibilità di ‘giocare’, di confrontarsi con il ‘voler fare’ soggettivo piuttosto che con il ‘dover fare’ istituzionale, di aver a che fare con se stessi, di interrogarsi sulle proprie motivazioni e sulle proprie aspirazioni, ossia sulle proprie modalità di ricerca del piacere.
Ma, pur nell’assenza di una qualche concreta istituzione esterna, è lo sfondo psicotico (per dirla con Bleger) della vita del soggetto, costituito da una pervasività istituzionale discreta ma continua ed incessante, la cui parola dunque è assente soltanto in forma apparente, a rappresentare l’ostacolo principale per la ricerca della propria via.
D’altra parte, è proprio quel tempo cosiddetto libero, quel tempo non completamente organizzato e strutturato, ciò cui si è così disabituati che, interrogando il soggetto sulle proprie necessità, può essere inteso come un’opportunità per riorganizzare la propria individualità: ma una riorganizzazione che non deve essere pensata nei termini di una libertà assoluta, libera da ogni limite e da ogni vincolo, bensì sempre limitata, contingente, situazionale. Operativa. Una forma di libertà che può essere raggiunta solamente per mezzo di un fare motivato dalle proprie necessità giacché, suggerisce a conclusione di un suo scritto Pichon-Rivière (1966/67, p. 46), “si può essere liberi solo attraverso le motivazioni”.
Bibliografia
Bleger J. (1967), “Simbiosi e ambiguità”, Loreto, Edizioni Lauretana, 1992
Fischetti R., “Glossario blegeriano”, Roma, armando, 2014
Freud S. (1915), “Pulsioni e i loro destini”, in “Metapsicologia”, Torino, Bollati Boringhieri, 1993
Freud S. (1919), “Il perturbante”, Torino, Bollati Boringhieri, 2000
Freud S. (1921), “Psicologia delle masse e analisi dell’Io”, Torino, Bollati Boringhieri, 2000
Freud S. (1922), “L’Io e l’Es”, Torino, Bollati Boringhieri, 2000
Freud S. (1932), “Introduzione alla psicoanalisi – Nuova serie di lezioni”, Torino, Bollati Boringhieri, 1995
Galofaro F., “Dopo Gerico. I nuovi spazi della psichiatria”, Bologna, Editrice Esculapio, 2015
Lefebvre H. (1958), “Critica della vita quotidiana”, Bari, Dedalo edizioni, 1977
Nietzsche F. (1881-82), “La gaia scienza”, Milano, Adelphi, 2015
Pichon-Rivière E. (1966/67), “Psicologia de la vida cotidiana”, Buenos Aires, Nueva Vision, 2007
Pichon-Rivière E. (1971), “Dalla psicoanalisi alla psicologia sociale”, Loreto, Edizioni Lauretana, 1985
(L'articolo è tratto da 'Cuadernos de temas grupales e istitucionales', n° 21, Inverno 2017, www.area3.org.es, ed una versione ampliata del lavoro presentato nella "1ª Assemblea internazionale sulla ricerca nella Concezione Operativa di Gruppo", svoltasi a Rimini il 20-22 ottobre 2016. )
Condividi:
Dott. Lorenzo Sartini via Pellegrino Matteucci, 21 40137 Bologna cell: 3338443719 mail: [email protected]
C. F. SRTLNZ73C21I608M P. IVA: 02755261209