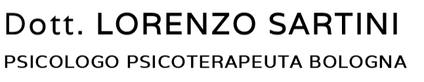SCRITTI
LA SOTTILE OPEROSITA' DEL TEMPO SOSPESO
di Lorenzo Sartini
Buscar una cosa
es siempre encontrar otra.
Así, para hallar algo,
hay que buscar lo que no es.
Buscar al pájaro para encontrar a la rosa,
buscar el amor para hallar el exilio,
buscar la nada para descubrir un hombre,
ir hacia atrás para ir hacia delante.
La clave del camino,
más que en sus bifurcaciones,
su sospechoso comienzo
o su dudoso final,
está en el cáustico humor
de su doble sentido.
Siempre se llega,
pero a otra parte.
Todo pasa.
Pero a la inversa.
(Roberto Juarroz, “Poesía Vertical, XII – 15”) [1]
“Il terremoto non è come ti lascia, ma come ti trova”, è la frase che disse un’anziana signora che viveva sola, ad una psicologa che lavorava sull’emergenza prodotta dal terremoto che aveva scosso la terra e le vite delle persone che abitavano in quel piccolo paese del centro Italia.
Quando accadono situazioni catastrofiche, come il terremoto, si è preda, nell’immediato, di una grande paura: la paura di perdere la propria vita. Nel caso del terremoto è un qualcosa che, in genere, ci accompagna in modo intenso per qualche secondo, forse per pochi minuti. Più propriamente, possiamo forse sostenere che si scateni una situazione di panico: è il panico che connota meglio quei momenti, venendo letteralmente a mancare la terra sotto ai propri piedi. Non si sa che cosa accadrà, quanto durerà e quali saranno le conseguenze che il terremoto lascerà.
Se il trauma è fare l’esperienza di una situazione inaspettata che viene vissuta come minaccia rispetto alla propria sopravvivenza e che tracima la possibilità di comprenderla cognitivamente e di contenerla emotivamente, suscitando paura e impotenza, l’avvento di un grave terremoto costituisce, senza ombra di dubbio, un evento traumatico.
Questa definizione però permette anche di pensare che una situazione, per quanto drammatica, non venga vissuta da tutte le persone allo stesso modo, bensì le reazioni ad essa possono variare.
È questo che rilevava l’anziana signora con quella frase: “Il terremoto non è come ti lascia, ma come ti trova”. Voleva dire che è dalle condizioni in cui si trova una persona quando irrompe il terremoto, ovvero quando arriva la crisi, che dipenderà il modo in cui sarà possibile affrontare le inevitabili conseguenze, di ordine materiale e psicologico, che seguiranno. Se una persona si trova in una situazione già critica dal punto di vista psicologico, sostenere una situazione di pericolo, o di tensione, come quella costituita dall’avvento di un grave terremoto sarà un compito enormemente più difficile, ossia generante un quantitativo di angoscia molto più elevato, rispetto a chi vive una situazione di maggior stabilità personale.
Questo principio ritengo valga anche per la situazione pandemica che stiamo vivendo. Non tutti vivono la pandemia da Covid-19 allo stesso modo: le condizioni materiali ed economiche, psicologiche e sociali di una persona influiscono enormemente sul modo in cui quella persona potrà affrontare e sopportare la crisi pandemica ed il senso di disperazione che essa comporta. Ciò però non toglie che tutti ne siamo toccati e che ciascuno si ritrovi a dover fare i conti con una situazione insolita e inaspettata che, in un modo o nell’altro, ci perturba. Nelle situazioni perturbanti, inevitabilmente, ci si interroga, ed emergono domande prima velate. Prima dimenticate.
Dobbiamo anche considerare che nel caso di un evento inaspettato come quello del terremoto, di un grave terremoto, la sensazione di smarrimento non si esaurisce con la fine delle scosse telluriche, poiché non crollano solo le case, gli edifici, ma crollano le istituzioni, e con esse l’importante funzione che le istituzioni svolgono per il mantenimento dell’idea che le persone hanno di se stesse, ossia per il mantenimento dell’idea di una propria “identità”. Con il terremoto non crollano soltanto le istituzioni esterne, gli edifici concreti nei quali vengono svolti servizi per rispondere alle necessità dei cittadini, ma anche le istituzioni interne, ovvero l’idea che noi abbiamo delle istituzioni e che deriva dalle implicazioni psicologiche che hanno origine nel rapporto che gli esseri umani intrattengono con le istituzioni medesime.
Ora, mi pare importante sottolineare che con la pandemia da Covid-19, stiamo parlando di una situazione per molti aspetti diversa da quella di un terremoto: ci stiamo confrontando con qualcosa che presenta un’estensione spaziale certamente maggiore, visto che la pandemia da Covid-19 non riguarda solamente territori particolari con le comunità sociali che li abitano, ma sta imperversando su tutto il globo terrestre[2], pur con modalità di influenza e intensità differenti; ed anche l’estensione temporale è differente visto che non abbiamo a che fare con un evento che si esprime raggiungendo un apice di intensità che poi andrà scemando in un periodo relativamente breve, bensì con un evento meno intenso dal punto di vista percettivo ma che si sta protraendo in maniera indefinita, per un tempo che non possiamo prevedere. In alcuni paesi, e penso a quelli dell’America Latina, dall’inizio della pandemia e fino ad oggi non è stato registrato un calo significativo dei contagi e dei decessi, ragion per cui quelle popolazioni non sono mai uscite dal lockdown, dal confinamento imposto inizialmente dalle autorità governative; in altri invece, e qui mi riferisco chiaramente ai paesi europei (anche se si sono registrate differenti modalità di azione nei vari paesi), abbiamo osservato una riduzione dei contagi e dei decessi in prossimità dell’arrivo della stagione calda, dell’estate, ciò che, in abbinamento con la dichiarata intenzione di continuare a “far girare” l’economia, ha fatto decidere le autorità governative per la “riapertura”. Ben sapendo che, con l’avvento della stagione fredda, se non si fosse riusciti ad azzerare i contagi, avremmo avuto a che fare con un nuovo aumento dei “casi”, la cosiddetta “seconda ondata”, e dunque con la necessità di una nuova “chiusura”. Situazione ampiamente prevista da molti scienziati sin dall’inizio della pandemia e, per tale motivo, certamente non sorprendente per le autorità governative che avevano il compito di decidere sulle misure da assumere per evitare che ciò accadesse. Le autorità governative, richiamandosi alla necessità di non poter fermare l’economia del paese, hanno comunque deciso di riaprire, comportando questa misura un nuovo aumento dei contagi. E dei decessi.
Che cosa si intende con “chiusura”? In termini concreti, con chiusura si intende l’interruzione, o almeno una notevole riduzione, dell’attività dei servizi pubblici e commerciali rivolti ai cittadini. Sono stati chiusi gli esercizi commerciali, o ne è stata fortemente ridotta l’attività, allo stesso modo dei servizi offerti alla persona proposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Sono state chiuse palestre, scuole di musica, teatri, musei, biblioteche, uffici pubblici e privati; mentre si è deciso di modificare e regolamentare in senso restrittivo le prestazioni espletate dalle banche, dagli uffici postali, dai servizi sanitari e scolastici, e così via. Dobbiamo però anche considerare che con il confinamento ci siamo trovati a vivere con maggiore intensità situazioni quotidiane che forse mai avevamo vissuto in modo così denso: mi sto chiaramente riferendo alla famiglia; ma anche, per esempio, a coloro che non potendo più andare in ufficio e svolgendo l’attività lavorativa da casa, hanno visto incrementare notevolmente il tempo dedicato al lavoro. In sostanza, siamo stati costretti a mutare il nostro modo di stare in rapporto con tutte quelle situazioni che, costituendo dei punti di riferimento, strutturavano la nostra vita. Da un punto di vista psicologico, quando si parla di istituzioni si parla di questo: situazioni abituali che regolano la nostra quotidianità. Nel corso di questo periodo è cambiato, e sta cambiando, il modo in cui viviamo le istituzioni che ci definiscono e che condizionano le nostre richieste, le istituzioni che organizzano la nostra vita e la nostra personalità: da una parte, alcune sono state chiuse o, quanto meno, ne è stata notevolmente ridotta la fruibilità; e dall’altra, di alcune è aumentata la loro costanza nella nostra vita. Ci troviamo nel bel mezzo di un mutamento che nessuno ha prospettato. Un mutamento non pensato, disorganizzato. Catastrofico, direbbe Bion.
Come ha evidenziato José Bleger[3], l’essere umano trae sicurezza ed identità dall’appartenenza ad un’istituzione, ciò che costituisce un sostegno ed un riferimento estremamente importante al fine dell’organizzazione e della stabilizzazione della propria personalità. Per cui, quando abbiamo a che fare con il crollo delle istituzioni, come avviene dopo un grave terremoto, o come sta avvenendo nella crisi pandemica attuale, veniamo gettati in una situazione di grande disperazione, sebbene non se ne abbia immediatamente consapevolezza, poiché abbiamo a che fare con la perdita dei punti di riferimento abitualmente utilizzati. Ci sentiamo perduti, dovendoci confrontare con una situazione di confusione e di smarrimento alla quale è necessario dare una risposta.
A questo punto non ci si può esimere dall’approfondire la tematica della simbiosi, certamente molto complessa, che Bleger utilizza per pensare al rapporto fra il soggetto e le istituzioni. Diremo pertanto che l’analista argentino sostiene l’esistenza, sin dalla nascita, di una specifica organizzazione dell’Io e del mondo esterno, una struttura che include sia il soggetto che il suo ambiente di vita. Un’organizzazione primitiva che, crescendo, il bambino dovrà modificare per poter arrivare ad avere il senso di una sua individualità, un’idea di sé, discriminata dalla realtà circostante. Questo nucleo ambiguo primitivo (costituito da Io e non-Io, dall’Io e dall’Altro) non può essere totalmente contenuto nella personalità dell’individuo per cui deve essere, almeno parzialmente, depositato sul mondo esterno. Ciascuna persona deposita questo nucleo simbiotico nelle cose della sua vita: le abitudini, la famiglia, lo studio, la professione, i vari gruppi o associazioni di appartenenza, ecc. Vale a dire che il deposito del nucleo ambiguo può avvenire su ogni cosa che possa costituire una fonte di sicurezza per il soggetto. È ciò che potremmo definire l’inquadramento (o setting) sociale del soggetto: il modo con cui il soggetto organizza la sua vita appoggiandosi su situazioni quotidiane che fungono da riferimento e che, una volta investite, vengono date per scontate, considerate come ovvie e naturali. Situazioni che, in qualche modo, finiscono per delimitare il suo territorio di movimento, organizzando la sua attività quotidiana e progettuale.
Come ci ricorda la psicoanalista Silvia Amati Sas[4] rifacendosi alla stessa matrice teorica blegeriana, durante i periodi di crescita, come nell’adolescenza, durante i periodi di crisi personale, così come quando avvengono crisi sociali, ossia eventi sociali traumatici (terremoto, guerra, ecc., ma anche, naturalmente, pandemie), può accadere che questi depositari non siano più disponibili, ragion per cui il soggetto deve riappropriarsi del deposito del nucleo ambiguo. Questa reintroiezione del nucleo psicotico provoca una disorganizzazione dell’identità del soggetto, un obnubilamento, una sorta di stordimento, potendo ciò generare tutta una serie di sintomi che vanno dall’ipocondria ai disturbi dell’immagine corporea, da forme diversificate di somatizzazione fino alla sensazione di spersonalizzazione, causando vissuti di intensa angoscia. Tutto viene rimesso in gioco: l’idea che si aveva di se stessi viene rimessa in discussione e, a fronte di questa disorganizzazione esistenziale, è necessario trovare altri riferimenti (depositari) che possano sostituire quelli precedenti e fornire sicurezza. Nel mentre, però, ci si trova a doversi confrontare con l’esperienza del vuoto. E dell’angoscia.
Per fare un esempio pratico del mutamento che ci sta investendo possiamo semplicemente pensare a quanto la situazione di pandemia abbia spinto ognuno di noi ad interrogarsi su come è stata vissuta la propria vita fino al momento attuale. La crisi pandemica ha fornito l’opportunità, pur in una situazione di angosciosa crisi, di dare valore ed importanza ad aspetti della nostra esistenza che prima erano stati completamente soffocati e quasi dimenticati. Ci ha fatto pensare, anche solo per un attimo, alla possibilità di poter vivere la propria vita in modo diverso, in modo alternativo rispetto a come è stata vissuta finora. Credo che tutti abbiamo avuto modo di confrontarci con questo pensiero, e con l’angoscia che ne deriva laddove sia stata registrata una differenza sostanziosa tra la vita vissuta e quella desiderata.
Una modalità cui ci si può appellare per affrontare questa angoscia è il ricorso a meccanismi di difesa che, rifacendoci al linguaggio di un’altra famosa psicoanalista, Melanie Klein, possiamo definire di tipo schizo-paranoide: viene negata la situazione di pericolo, per cui si ha a che fare con uno stato di angoscia del quale non si ha consapevolezza; oppure la situazione complessiva nella quale ci si trova viene scissa, frammentata, legittimando soltanto una delle parti in causa, quella con la quale ci si identifica, e disconoscendo l’altra parte (o le altre parti), sulla quale vengono proiettati i propri impulsi aggressivi; a quel punto ci si sente perseguitati dalla parte rifiutata, disconosciuta, dalla quale, quando verrà in qualche modo presentificata, ci si sentirà aggrediti.
Secondo lo schema kleiniano dello sviluppo dell’infante, nella prima fase, quella definita “schizo-paranoide” (schizo perché i meccanismi di difesa utilizzati sono di tipo schizoide, paranoide perché è presente la paura di essere attaccati dall’altro), il bambino vive la frammentazione dell’oggetto: in questa fase il bambino non è in rapporto con l’oggetto nella sua totalità (per esempio, la madre), bensì con oggetti parziali, ossia con parti di esso (con il seno, per esempio), e l’oggetto sarà riconosciuto come “buono” laddove sarà gratificante e “cattivo” laddove invece non soddisferà il bisogno che il bambino esprime, risultando dunque frustrante. È come se il bambino avesse a che fare con due oggetti invece che con uno solo.
Quando queste parti, ed i vincoli intrattenuti con esse, potranno essere ricomposte andando a ricostituire l’oggetto intero, l’oggetto totale, si entrerà nella fase successiva, quella definita depressiva. Nella posizione depressiva il bambino vive una situazione di ambivalenza, provando amore e odio per lo stesso oggetto, quando nella fase precedente, invece, l’amore veniva vissuto in relazione all’oggetto (parziale) buono e l’odio in rapporto all’oggetto (parziale) cattivo. Questa ricomposizione dell’oggetto comporta che nella posizione depressiva il bambino avrà a che fare con la colpa (per il fatto di aver desiderato distruggere l’oggetto amato e da cui era amato), la paura (per il fatto di poterlo perdere) e la tristezza (per il fatto di vivere come se stesse già distruggendo l’oggetto). Il soggetto si confronta con il pensiero della perdita dell’oggetto, che considera dovuta alla propria ostilità, ragione per la quale deve elaborare il lutto: elaborazione che può fare soltanto per mezzo di meccanismi di riparazione. Se il soggetto riuscirà a riparare (attraverso pensieri, atteggiamenti, attività, ecc.) l’oggetto fantasticamente distrutto allora uscirà dalla posizione depressiva proseguendo favorevolmente nel suo processo di sviluppo, che vedrà un’alternanza mista e continua di queste due fasi. La mancata elaborazione della posizione depressiva, invece, che comporta soprattutto l’elaborazione della solitudine e della sofferenza, come dice Pichon-Rivière[5], predispone alla nevrosi.
Il punto è che non è scontato elaborare in senso evolutivo la posizione depressiva proprio perché si ha sempre a che fare con una perdita, con la necessità di una ristrutturazione dei propri schemi e con un adeguamento alla nuova situazione. Con l’organizzazione di una nuova identità e di una nuova idea di sé. Con il cambiamento, appunto.
Nel perdurare della pandemia abbiamo sovente visto in atto condotte di negazione, quando affermando la non esistenza del virus e quando, dall’altra parte, esprimendo un’acritica accettazione delle informazioni istituzionali (come se non si riuscisse a considerare la possibilità, concreta in quanto dimostrata più volte nella storia, di poter essere oggetto di informazioni istituzionali distorte o inattendibili); così come estremamente diffusa è stata la reazione di angoscia persecutoria, vedendo nell’altro che manifestava un pensiero diverso un aggressore: da una parte, chi crede nella pericolosità del virus da Covid-19 accusa chi non ci crede di essere un pericolo per la comunità sociale umana, situazione che ha portato alla evidente produzione di capri espiatori (l’esempio eclatante è quello dei “runners” che, nella prima ondata della pandemia, pur correndo in solitaria, sono stati accusati di essere pericolosi strumenti di contagio, suscitando una sorta di isteria sociale incontrollata, salvo poi il Governo permettere questo tipo di attività, attraverso l’emanazione dei decreti istituzionali, e dunque non considerandola così pericolosa come inizialmente sostenuto); dall’altra, chi non ritiene il virus da Covid-19 pericoloso accusa chi invece vi crede di farsi ingannare dalle autorità istituzionali che sfrutterebbero la situazione di crisi per restringere le libertà individuali e creare una società di tipo totalitario.
Estremamente difficoltoso riuscire a mantenere una punto di vista, per così dire, intermedio, provando a sospendere il giudizio e cercando di “integrare” le due posizioni.
Con il trascorrere del tempo ed il perdurare del periodo di crisi, sembra essere divenuto viepiù possibile iniziare ad avvicinare la parte prima disconosciuta, ossia iniziare a mettersi nei panni dell’altro, prendere in considerazione anche la parte prima rifiutata, non vedendo più in essa soltanto un nemico da respingere, ma anche un pensiero con una propria legittimità, per cui da vagliare. A questo punto si è entrati, rifacendoci ancora una volta allo schema kleiniano delle fasi dello sviluppo, in una fase depressiva caratterizzata da sentimenti di tristezza e dal senso di disperazione, espresso dal pensiero di trovarsi in una condizione di immobilità (il tempo sospeso) e di impotenza (non posso fare niente perché non so neppure che cosa accadrà domani). Un periodo che, forse anche per la stanchezza dovuta al permanere in una situazione connotata da profonda incertezza, molti considerano ancora più gravoso e difficile rispetto a quello vissuto durante la prima ondata della pandemia, nella quale le autorità governative avevano deciso per una chiusura certamente più consistente delle attività sociali e istituzionali.
Il “tempo sospeso”, formula ampiamente utilizzata in questo periodo, penso sia un concetto molto interessante che possa essere inteso come “emergente” della situazione attuale. Con questa formula si intende un tempo fermo, immobile, un periodo del quale non si riesce a vedere la fine per l’impossibilità di prevedere ciò che avverrà. Un tempo di attesa, senza possibilità di fare progetti perché non si sa come si trasformerà il mondo circostante. Un tempo senza futuro. Un tempo disperato, nel quale si ha a che fare con una percezione di se stessi caratterizzata da staticità e passività.
Penso però che queste idee di inoperosità e inattività non rispecchino la concreta situazione vissuta, e che possano essere conseguenza della inevitabile mancanza di chiarezza rispetto alla situazione (depressiva) di riorganizzazione che si sta vivendo, in rapporto alla impossibilità di vedersi proiettati nel futuro.
M. viene al consueto colloquio settimanale e non sa di cosa parlare perché dice di sentirsi sempre allo stesso punto e che, dal colloquio della settimana scorsa, nulla è cambiato. Prendendo spunto dalla situazione della pandemia afferma di sentirsi vivere in un tempo sospeso, un tempo fermo, nel quale nulla accade, e riferisce di essere pervaso da un senso di impotenza, avendo l’idea di non star facendo niente per se stesso, di trovarsi in una condizione di immobilità. Questo è il vissuto psicologico che M. esprime con tristezza e rassegnazione: un vissuto di tipo depressivo. Si riferisce alla situazione legata alla pandemia ma, contemporaneamente, propone una serie di fatti che paiono descrivere la conflittualità che sta vivendo a livello identitario, utilizzando ciò che è fuori (in questo caso, la pandemia) per parlare di sé, nel qui ed ora con me: i cambiamenti che ha dovuto sostenere nell’ambito professionale, reinventandosi in ruoli che prima non gli competevano; il trasloco nella nuova casa, in una situazione ambientale che gli ricorda quella nella quale viveva con la sua famiglia d’origine; le opportunità che sta scoprendo in quella nuova situazione abitativa, così come le difficoltà che sta affrontando per riorganizzare la propria vita nella nuova casa insieme alla persona con cui convive. Un paradosso: per quanto M. ritenga di non star facendo nulla, vivendo in un tempo sospeso, immobile, sembrerebbe, al contrario, che si trovi immerso in una fase di lavoro e cambiamento, che sia profondamente impegnato a riorganizzare la propria vita, ossia la modalità di stare in relazione con l’altro e, dunque, la propria personalità. M. sta lavorando molto, sta faticosamente cercando di rimettere insieme i pezzi sparsi, frammentati, disorganizzati, della sua esistenza, potremmo dire, ma gli sembra di non star facendo nulla.
È importante precisare, arrivati a questo punto, che le due fasi evolutive individuate dalla Klein, quella schizoparanoide e quella depressiva, non sono così nettamente discriminabili l’una dall’altra, ed anzi l’una può solo dispiegarsi appoggiandosi sull’altra. Sono due fasi che dobbiamo pensare intrecciate, sia a un livello di analisi individuale che, e tanto più, a livello di analisi sociale. È solo per semplicità di analisi e d’esposizione che le distinguo in modo così netto.
Fatta questa doverosa puntualizzazione, l’ipotesi che propongo è che la paradossalità evidenziata da M., cioè il darsi tanto da fare ritenendo di non star facendo nulla, possa costituire un aspetto caratteristico di questa fase di “sospensione” che socialmente stiamo tutti vivendo e che penso possa essere sovrapponibile a quella fase che Melanie Klein chiama “posizione depressiva”. Una fase caratterizzata da grande attività e fatica (“il lattante mobilita tutto il suo amore, capacità e talenti per ricreare un mondo interno buono”, scrive Hanna Segal per descrivere la posizione depressiva postulata dalla Klein[6]), non accompagnate però dall’idea di una chiara progettualità visto che, in questa fase di possibile trasformazione, ovvero di perdita della precedente identità, non ci si focalizza sul futuro, sulla direzione che verrà presa, su ciò che accadrà, ma su ciò che sta già avvenendo. È questa la fase in cui si dispiegano le possibilità creative. È questa la fase del presente. Del presente come opportunità, e non soltanto come schiacciamento.
Solo a posteriori, a lavoro avvenuto, sarà possibile rendersi conto di ciò che è stato fatto e di ciò che è cambiato, e non mentre ci si trova direttamente implicati nella situazione vissuta.
In una fase di riorganizzazione creativa, più che con una chiara visione del futuro, ci confrontiamo con la tristezza e la paura per ciò che si è lasciato e l’incertezza e la confusione per ciò che è e che potrà essere. Solo quando sarà stato possibile integrare l’oggetto (esperienza) prima scisso e confrontarsi ed elaborare la situazione depressiva, sarà possibile pianificare la propria azione. Solamente a quel punto sarà possibile vedersi proiettati nel futuro e pensare ad un progetto. È in quel momento che si potrà avere un’immagine più nitida di se stessi e potrà “tornare” il futuro.
Per quanto sempre, in una certa misura, abbiamo a che fare con frammenti o fantasie di futuro, prima penso ci si confronti più decisamente con l’assenza di certezze poiché si ha a che fare con “il timore di albergare dentro di sé oggetti morenti o morti. Questa è la ragione profonda della loro disperazione e angoscia”[7]. Prima si deve riuscire a sopportare la disperazione, la mancanza di speranza; prima si deve riuscire a sostenere la situazione presente, a sostare nel presente senza proiettarsi nel futuro.
Penso che la situazione attuale della pandemia da Covid-19 ci stia mettendo a confronto proprio con questa questione: vivere il qui ed ora del presente. Ma il riuscire a farlo non è scontato perché, come diceva l’anziana signora, dipende da come ti trova il terremoto.
[1] Roberto Juarroz, “Poesía Vertical”, Catedra Ediciones, Madrid, 2012.
La traduco così in italiano: Cercare una cosa/ è sempre trovarne un’altra./ Così, per trovare qualcosa,/è necessario cercare ciò che non è./ Cercare il passero per trovare una rosa,/ cercare l’amore per trovare l’esilio,/ cercare il nulla per scoprire un uomo,/ andare indietro per andare avanti./ La chiave del percorso,/ più che nelle sue biforcazioni/ il suo sospettoso inizio/ o il suo dubbioso finale/ si trova nel caustico umore/ del suo doppio significato./ Sempre si arriva,/ ma da un’altra parte./ Tutto accade,/ ma al contrario.
[2] Cfr. la Teoria degli Ambiti di José Bleger.
[3] José Bleger, “Simbiosi e ambiguità”, Armando Editore, Roma, 2010.
[4] Silvia Amati Sas, “Ambiguità, conformismo e adattamento sociale alla violenza”, Franco Angeli, Milano, 2020.
[5] Enrique Pichon-Rivière, “Posizione schizoparanoide, depressiva e patoritmica. Approccio freudiano, kleiniano e riflessologico. La nostra posizione.” Lezione del 11/07/1966 alla Scuola Privata di Psichiatria Sociale, da www.lorenzosartini.com.
[6] Hanna Segal, “Melanie Klein”, Editore Boringhieri, Torino, 1981.
[7] Hanna Segal, ibid.
(Pubblicato su "I Quaderni della Formazione" n. 01/21, "Nel tempo capovolto della pandemia", edito da Sol.Co Mantova, https://www.solcomantova.it/wp-content/uploads/2021/03/quaderno-2021-num_DEF_con-copertina.pdf)
20 dicembre 2020
Quando accadono situazioni catastrofiche, come il terremoto, si è preda, nell’immediato, di una grande paura: la paura di perdere la propria vita. Nel caso del terremoto è un qualcosa che, in genere, ci accompagna in modo intenso per qualche secondo, forse per pochi minuti. Più propriamente, possiamo forse sostenere che si scateni una situazione di panico: è il panico che connota meglio quei momenti, venendo letteralmente a mancare la terra sotto ai propri piedi. Non si sa che cosa accadrà, quanto durerà e quali saranno le conseguenze che il terremoto lascerà.
Se il trauma è fare l’esperienza di una situazione inaspettata che viene vissuta come minaccia rispetto alla propria sopravvivenza e che tracima la possibilità di comprenderla cognitivamente e di contenerla emotivamente, suscitando paura e impotenza, l’avvento di un grave terremoto costituisce, senza ombra di dubbio, un evento traumatico.
Questa definizione però permette anche di pensare che una situazione, per quanto drammatica, non venga vissuta da tutte le persone allo stesso modo, bensì le reazioni ad essa possono variare.
È questo che rilevava l’anziana signora con quella frase: “Il terremoto non è come ti lascia, ma come ti trova”. Voleva dire che è dalle condizioni in cui si trova una persona quando irrompe il terremoto, ovvero quando arriva la crisi, che dipenderà il modo in cui sarà possibile affrontare le inevitabili conseguenze, di ordine materiale e psicologico, che seguiranno. Se una persona si trova in una situazione già critica dal punto di vista psicologico, sostenere una situazione di pericolo, o di tensione, come quella costituita dall’avvento di un grave terremoto sarà un compito enormemente più difficile, ossia generante un quantitativo di angoscia molto più elevato, rispetto a chi vive una situazione di maggior stabilità personale.
Questo principio ritengo valga anche per la situazione pandemica che stiamo vivendo. Non tutti vivono la pandemia da Covid-19 allo stesso modo: le condizioni materiali ed economiche, psicologiche e sociali di una persona influiscono enormemente sul modo in cui quella persona potrà affrontare e sopportare la crisi pandemica ed il senso di disperazione che essa comporta. Ciò però non toglie che tutti ne siamo toccati e che ciascuno si ritrovi a dover fare i conti con una situazione insolita e inaspettata che, in un modo o nell’altro, ci perturba. Nelle situazioni perturbanti, inevitabilmente, ci si interroga, ed emergono domande prima velate. Prima dimenticate.
Dobbiamo anche considerare che nel caso di un evento inaspettato come quello del terremoto, di un grave terremoto, la sensazione di smarrimento non si esaurisce con la fine delle scosse telluriche, poiché non crollano solo le case, gli edifici, ma crollano le istituzioni, e con esse l’importante funzione che le istituzioni svolgono per il mantenimento dell’idea che le persone hanno di se stesse, ossia per il mantenimento dell’idea di una propria “identità”. Con il terremoto non crollano soltanto le istituzioni esterne, gli edifici concreti nei quali vengono svolti servizi per rispondere alle necessità dei cittadini, ma anche le istituzioni interne, ovvero l’idea che noi abbiamo delle istituzioni e che deriva dalle implicazioni psicologiche che hanno origine nel rapporto che gli esseri umani intrattengono con le istituzioni medesime.
Ora, mi pare importante sottolineare che con la pandemia da Covid-19, stiamo parlando di una situazione per molti aspetti diversa da quella di un terremoto: ci stiamo confrontando con qualcosa che presenta un’estensione spaziale certamente maggiore, visto che la pandemia da Covid-19 non riguarda solamente territori particolari con le comunità sociali che li abitano, ma sta imperversando su tutto il globo terrestre[2], pur con modalità di influenza e intensità differenti; ed anche l’estensione temporale è differente visto che non abbiamo a che fare con un evento che si esprime raggiungendo un apice di intensità che poi andrà scemando in un periodo relativamente breve, bensì con un evento meno intenso dal punto di vista percettivo ma che si sta protraendo in maniera indefinita, per un tempo che non possiamo prevedere. In alcuni paesi, e penso a quelli dell’America Latina, dall’inizio della pandemia e fino ad oggi non è stato registrato un calo significativo dei contagi e dei decessi, ragion per cui quelle popolazioni non sono mai uscite dal lockdown, dal confinamento imposto inizialmente dalle autorità governative; in altri invece, e qui mi riferisco chiaramente ai paesi europei (anche se si sono registrate differenti modalità di azione nei vari paesi), abbiamo osservato una riduzione dei contagi e dei decessi in prossimità dell’arrivo della stagione calda, dell’estate, ciò che, in abbinamento con la dichiarata intenzione di continuare a “far girare” l’economia, ha fatto decidere le autorità governative per la “riapertura”. Ben sapendo che, con l’avvento della stagione fredda, se non si fosse riusciti ad azzerare i contagi, avremmo avuto a che fare con un nuovo aumento dei “casi”, la cosiddetta “seconda ondata”, e dunque con la necessità di una nuova “chiusura”. Situazione ampiamente prevista da molti scienziati sin dall’inizio della pandemia e, per tale motivo, certamente non sorprendente per le autorità governative che avevano il compito di decidere sulle misure da assumere per evitare che ciò accadesse. Le autorità governative, richiamandosi alla necessità di non poter fermare l’economia del paese, hanno comunque deciso di riaprire, comportando questa misura un nuovo aumento dei contagi. E dei decessi.
Che cosa si intende con “chiusura”? In termini concreti, con chiusura si intende l’interruzione, o almeno una notevole riduzione, dell’attività dei servizi pubblici e commerciali rivolti ai cittadini. Sono stati chiusi gli esercizi commerciali, o ne è stata fortemente ridotta l’attività, allo stesso modo dei servizi offerti alla persona proposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Sono state chiuse palestre, scuole di musica, teatri, musei, biblioteche, uffici pubblici e privati; mentre si è deciso di modificare e regolamentare in senso restrittivo le prestazioni espletate dalle banche, dagli uffici postali, dai servizi sanitari e scolastici, e così via. Dobbiamo però anche considerare che con il confinamento ci siamo trovati a vivere con maggiore intensità situazioni quotidiane che forse mai avevamo vissuto in modo così denso: mi sto chiaramente riferendo alla famiglia; ma anche, per esempio, a coloro che non potendo più andare in ufficio e svolgendo l’attività lavorativa da casa, hanno visto incrementare notevolmente il tempo dedicato al lavoro. In sostanza, siamo stati costretti a mutare il nostro modo di stare in rapporto con tutte quelle situazioni che, costituendo dei punti di riferimento, strutturavano la nostra vita. Da un punto di vista psicologico, quando si parla di istituzioni si parla di questo: situazioni abituali che regolano la nostra quotidianità. Nel corso di questo periodo è cambiato, e sta cambiando, il modo in cui viviamo le istituzioni che ci definiscono e che condizionano le nostre richieste, le istituzioni che organizzano la nostra vita e la nostra personalità: da una parte, alcune sono state chiuse o, quanto meno, ne è stata notevolmente ridotta la fruibilità; e dall’altra, di alcune è aumentata la loro costanza nella nostra vita. Ci troviamo nel bel mezzo di un mutamento che nessuno ha prospettato. Un mutamento non pensato, disorganizzato. Catastrofico, direbbe Bion.
Come ha evidenziato José Bleger[3], l’essere umano trae sicurezza ed identità dall’appartenenza ad un’istituzione, ciò che costituisce un sostegno ed un riferimento estremamente importante al fine dell’organizzazione e della stabilizzazione della propria personalità. Per cui, quando abbiamo a che fare con il crollo delle istituzioni, come avviene dopo un grave terremoto, o come sta avvenendo nella crisi pandemica attuale, veniamo gettati in una situazione di grande disperazione, sebbene non se ne abbia immediatamente consapevolezza, poiché abbiamo a che fare con la perdita dei punti di riferimento abitualmente utilizzati. Ci sentiamo perduti, dovendoci confrontare con una situazione di confusione e di smarrimento alla quale è necessario dare una risposta.
A questo punto non ci si può esimere dall’approfondire la tematica della simbiosi, certamente molto complessa, che Bleger utilizza per pensare al rapporto fra il soggetto e le istituzioni. Diremo pertanto che l’analista argentino sostiene l’esistenza, sin dalla nascita, di una specifica organizzazione dell’Io e del mondo esterno, una struttura che include sia il soggetto che il suo ambiente di vita. Un’organizzazione primitiva che, crescendo, il bambino dovrà modificare per poter arrivare ad avere il senso di una sua individualità, un’idea di sé, discriminata dalla realtà circostante. Questo nucleo ambiguo primitivo (costituito da Io e non-Io, dall’Io e dall’Altro) non può essere totalmente contenuto nella personalità dell’individuo per cui deve essere, almeno parzialmente, depositato sul mondo esterno. Ciascuna persona deposita questo nucleo simbiotico nelle cose della sua vita: le abitudini, la famiglia, lo studio, la professione, i vari gruppi o associazioni di appartenenza, ecc. Vale a dire che il deposito del nucleo ambiguo può avvenire su ogni cosa che possa costituire una fonte di sicurezza per il soggetto. È ciò che potremmo definire l’inquadramento (o setting) sociale del soggetto: il modo con cui il soggetto organizza la sua vita appoggiandosi su situazioni quotidiane che fungono da riferimento e che, una volta investite, vengono date per scontate, considerate come ovvie e naturali. Situazioni che, in qualche modo, finiscono per delimitare il suo territorio di movimento, organizzando la sua attività quotidiana e progettuale.
Come ci ricorda la psicoanalista Silvia Amati Sas[4] rifacendosi alla stessa matrice teorica blegeriana, durante i periodi di crescita, come nell’adolescenza, durante i periodi di crisi personale, così come quando avvengono crisi sociali, ossia eventi sociali traumatici (terremoto, guerra, ecc., ma anche, naturalmente, pandemie), può accadere che questi depositari non siano più disponibili, ragion per cui il soggetto deve riappropriarsi del deposito del nucleo ambiguo. Questa reintroiezione del nucleo psicotico provoca una disorganizzazione dell’identità del soggetto, un obnubilamento, una sorta di stordimento, potendo ciò generare tutta una serie di sintomi che vanno dall’ipocondria ai disturbi dell’immagine corporea, da forme diversificate di somatizzazione fino alla sensazione di spersonalizzazione, causando vissuti di intensa angoscia. Tutto viene rimesso in gioco: l’idea che si aveva di se stessi viene rimessa in discussione e, a fronte di questa disorganizzazione esistenziale, è necessario trovare altri riferimenti (depositari) che possano sostituire quelli precedenti e fornire sicurezza. Nel mentre, però, ci si trova a doversi confrontare con l’esperienza del vuoto. E dell’angoscia.
Per fare un esempio pratico del mutamento che ci sta investendo possiamo semplicemente pensare a quanto la situazione di pandemia abbia spinto ognuno di noi ad interrogarsi su come è stata vissuta la propria vita fino al momento attuale. La crisi pandemica ha fornito l’opportunità, pur in una situazione di angosciosa crisi, di dare valore ed importanza ad aspetti della nostra esistenza che prima erano stati completamente soffocati e quasi dimenticati. Ci ha fatto pensare, anche solo per un attimo, alla possibilità di poter vivere la propria vita in modo diverso, in modo alternativo rispetto a come è stata vissuta finora. Credo che tutti abbiamo avuto modo di confrontarci con questo pensiero, e con l’angoscia che ne deriva laddove sia stata registrata una differenza sostanziosa tra la vita vissuta e quella desiderata.
Una modalità cui ci si può appellare per affrontare questa angoscia è il ricorso a meccanismi di difesa che, rifacendoci al linguaggio di un’altra famosa psicoanalista, Melanie Klein, possiamo definire di tipo schizo-paranoide: viene negata la situazione di pericolo, per cui si ha a che fare con uno stato di angoscia del quale non si ha consapevolezza; oppure la situazione complessiva nella quale ci si trova viene scissa, frammentata, legittimando soltanto una delle parti in causa, quella con la quale ci si identifica, e disconoscendo l’altra parte (o le altre parti), sulla quale vengono proiettati i propri impulsi aggressivi; a quel punto ci si sente perseguitati dalla parte rifiutata, disconosciuta, dalla quale, quando verrà in qualche modo presentificata, ci si sentirà aggrediti.
Secondo lo schema kleiniano dello sviluppo dell’infante, nella prima fase, quella definita “schizo-paranoide” (schizo perché i meccanismi di difesa utilizzati sono di tipo schizoide, paranoide perché è presente la paura di essere attaccati dall’altro), il bambino vive la frammentazione dell’oggetto: in questa fase il bambino non è in rapporto con l’oggetto nella sua totalità (per esempio, la madre), bensì con oggetti parziali, ossia con parti di esso (con il seno, per esempio), e l’oggetto sarà riconosciuto come “buono” laddove sarà gratificante e “cattivo” laddove invece non soddisferà il bisogno che il bambino esprime, risultando dunque frustrante. È come se il bambino avesse a che fare con due oggetti invece che con uno solo.
Quando queste parti, ed i vincoli intrattenuti con esse, potranno essere ricomposte andando a ricostituire l’oggetto intero, l’oggetto totale, si entrerà nella fase successiva, quella definita depressiva. Nella posizione depressiva il bambino vive una situazione di ambivalenza, provando amore e odio per lo stesso oggetto, quando nella fase precedente, invece, l’amore veniva vissuto in relazione all’oggetto (parziale) buono e l’odio in rapporto all’oggetto (parziale) cattivo. Questa ricomposizione dell’oggetto comporta che nella posizione depressiva il bambino avrà a che fare con la colpa (per il fatto di aver desiderato distruggere l’oggetto amato e da cui era amato), la paura (per il fatto di poterlo perdere) e la tristezza (per il fatto di vivere come se stesse già distruggendo l’oggetto). Il soggetto si confronta con il pensiero della perdita dell’oggetto, che considera dovuta alla propria ostilità, ragione per la quale deve elaborare il lutto: elaborazione che può fare soltanto per mezzo di meccanismi di riparazione. Se il soggetto riuscirà a riparare (attraverso pensieri, atteggiamenti, attività, ecc.) l’oggetto fantasticamente distrutto allora uscirà dalla posizione depressiva proseguendo favorevolmente nel suo processo di sviluppo, che vedrà un’alternanza mista e continua di queste due fasi. La mancata elaborazione della posizione depressiva, invece, che comporta soprattutto l’elaborazione della solitudine e della sofferenza, come dice Pichon-Rivière[5], predispone alla nevrosi.
Il punto è che non è scontato elaborare in senso evolutivo la posizione depressiva proprio perché si ha sempre a che fare con una perdita, con la necessità di una ristrutturazione dei propri schemi e con un adeguamento alla nuova situazione. Con l’organizzazione di una nuova identità e di una nuova idea di sé. Con il cambiamento, appunto.
Nel perdurare della pandemia abbiamo sovente visto in atto condotte di negazione, quando affermando la non esistenza del virus e quando, dall’altra parte, esprimendo un’acritica accettazione delle informazioni istituzionali (come se non si riuscisse a considerare la possibilità, concreta in quanto dimostrata più volte nella storia, di poter essere oggetto di informazioni istituzionali distorte o inattendibili); così come estremamente diffusa è stata la reazione di angoscia persecutoria, vedendo nell’altro che manifestava un pensiero diverso un aggressore: da una parte, chi crede nella pericolosità del virus da Covid-19 accusa chi non ci crede di essere un pericolo per la comunità sociale umana, situazione che ha portato alla evidente produzione di capri espiatori (l’esempio eclatante è quello dei “runners” che, nella prima ondata della pandemia, pur correndo in solitaria, sono stati accusati di essere pericolosi strumenti di contagio, suscitando una sorta di isteria sociale incontrollata, salvo poi il Governo permettere questo tipo di attività, attraverso l’emanazione dei decreti istituzionali, e dunque non considerandola così pericolosa come inizialmente sostenuto); dall’altra, chi non ritiene il virus da Covid-19 pericoloso accusa chi invece vi crede di farsi ingannare dalle autorità istituzionali che sfrutterebbero la situazione di crisi per restringere le libertà individuali e creare una società di tipo totalitario.
Estremamente difficoltoso riuscire a mantenere una punto di vista, per così dire, intermedio, provando a sospendere il giudizio e cercando di “integrare” le due posizioni.
Con il trascorrere del tempo ed il perdurare del periodo di crisi, sembra essere divenuto viepiù possibile iniziare ad avvicinare la parte prima disconosciuta, ossia iniziare a mettersi nei panni dell’altro, prendere in considerazione anche la parte prima rifiutata, non vedendo più in essa soltanto un nemico da respingere, ma anche un pensiero con una propria legittimità, per cui da vagliare. A questo punto si è entrati, rifacendoci ancora una volta allo schema kleiniano delle fasi dello sviluppo, in una fase depressiva caratterizzata da sentimenti di tristezza e dal senso di disperazione, espresso dal pensiero di trovarsi in una condizione di immobilità (il tempo sospeso) e di impotenza (non posso fare niente perché non so neppure che cosa accadrà domani). Un periodo che, forse anche per la stanchezza dovuta al permanere in una situazione connotata da profonda incertezza, molti considerano ancora più gravoso e difficile rispetto a quello vissuto durante la prima ondata della pandemia, nella quale le autorità governative avevano deciso per una chiusura certamente più consistente delle attività sociali e istituzionali.
Il “tempo sospeso”, formula ampiamente utilizzata in questo periodo, penso sia un concetto molto interessante che possa essere inteso come “emergente” della situazione attuale. Con questa formula si intende un tempo fermo, immobile, un periodo del quale non si riesce a vedere la fine per l’impossibilità di prevedere ciò che avverrà. Un tempo di attesa, senza possibilità di fare progetti perché non si sa come si trasformerà il mondo circostante. Un tempo senza futuro. Un tempo disperato, nel quale si ha a che fare con una percezione di se stessi caratterizzata da staticità e passività.
Penso però che queste idee di inoperosità e inattività non rispecchino la concreta situazione vissuta, e che possano essere conseguenza della inevitabile mancanza di chiarezza rispetto alla situazione (depressiva) di riorganizzazione che si sta vivendo, in rapporto alla impossibilità di vedersi proiettati nel futuro.
M. viene al consueto colloquio settimanale e non sa di cosa parlare perché dice di sentirsi sempre allo stesso punto e che, dal colloquio della settimana scorsa, nulla è cambiato. Prendendo spunto dalla situazione della pandemia afferma di sentirsi vivere in un tempo sospeso, un tempo fermo, nel quale nulla accade, e riferisce di essere pervaso da un senso di impotenza, avendo l’idea di non star facendo niente per se stesso, di trovarsi in una condizione di immobilità. Questo è il vissuto psicologico che M. esprime con tristezza e rassegnazione: un vissuto di tipo depressivo. Si riferisce alla situazione legata alla pandemia ma, contemporaneamente, propone una serie di fatti che paiono descrivere la conflittualità che sta vivendo a livello identitario, utilizzando ciò che è fuori (in questo caso, la pandemia) per parlare di sé, nel qui ed ora con me: i cambiamenti che ha dovuto sostenere nell’ambito professionale, reinventandosi in ruoli che prima non gli competevano; il trasloco nella nuova casa, in una situazione ambientale che gli ricorda quella nella quale viveva con la sua famiglia d’origine; le opportunità che sta scoprendo in quella nuova situazione abitativa, così come le difficoltà che sta affrontando per riorganizzare la propria vita nella nuova casa insieme alla persona con cui convive. Un paradosso: per quanto M. ritenga di non star facendo nulla, vivendo in un tempo sospeso, immobile, sembrerebbe, al contrario, che si trovi immerso in una fase di lavoro e cambiamento, che sia profondamente impegnato a riorganizzare la propria vita, ossia la modalità di stare in relazione con l’altro e, dunque, la propria personalità. M. sta lavorando molto, sta faticosamente cercando di rimettere insieme i pezzi sparsi, frammentati, disorganizzati, della sua esistenza, potremmo dire, ma gli sembra di non star facendo nulla.
È importante precisare, arrivati a questo punto, che le due fasi evolutive individuate dalla Klein, quella schizoparanoide e quella depressiva, non sono così nettamente discriminabili l’una dall’altra, ed anzi l’una può solo dispiegarsi appoggiandosi sull’altra. Sono due fasi che dobbiamo pensare intrecciate, sia a un livello di analisi individuale che, e tanto più, a livello di analisi sociale. È solo per semplicità di analisi e d’esposizione che le distinguo in modo così netto.
Fatta questa doverosa puntualizzazione, l’ipotesi che propongo è che la paradossalità evidenziata da M., cioè il darsi tanto da fare ritenendo di non star facendo nulla, possa costituire un aspetto caratteristico di questa fase di “sospensione” che socialmente stiamo tutti vivendo e che penso possa essere sovrapponibile a quella fase che Melanie Klein chiama “posizione depressiva”. Una fase caratterizzata da grande attività e fatica (“il lattante mobilita tutto il suo amore, capacità e talenti per ricreare un mondo interno buono”, scrive Hanna Segal per descrivere la posizione depressiva postulata dalla Klein[6]), non accompagnate però dall’idea di una chiara progettualità visto che, in questa fase di possibile trasformazione, ovvero di perdita della precedente identità, non ci si focalizza sul futuro, sulla direzione che verrà presa, su ciò che accadrà, ma su ciò che sta già avvenendo. È questa la fase in cui si dispiegano le possibilità creative. È questa la fase del presente. Del presente come opportunità, e non soltanto come schiacciamento.
Solo a posteriori, a lavoro avvenuto, sarà possibile rendersi conto di ciò che è stato fatto e di ciò che è cambiato, e non mentre ci si trova direttamente implicati nella situazione vissuta.
In una fase di riorganizzazione creativa, più che con una chiara visione del futuro, ci confrontiamo con la tristezza e la paura per ciò che si è lasciato e l’incertezza e la confusione per ciò che è e che potrà essere. Solo quando sarà stato possibile integrare l’oggetto (esperienza) prima scisso e confrontarsi ed elaborare la situazione depressiva, sarà possibile pianificare la propria azione. Solamente a quel punto sarà possibile vedersi proiettati nel futuro e pensare ad un progetto. È in quel momento che si potrà avere un’immagine più nitida di se stessi e potrà “tornare” il futuro.
Per quanto sempre, in una certa misura, abbiamo a che fare con frammenti o fantasie di futuro, prima penso ci si confronti più decisamente con l’assenza di certezze poiché si ha a che fare con “il timore di albergare dentro di sé oggetti morenti o morti. Questa è la ragione profonda della loro disperazione e angoscia”[7]. Prima si deve riuscire a sopportare la disperazione, la mancanza di speranza; prima si deve riuscire a sostenere la situazione presente, a sostare nel presente senza proiettarsi nel futuro.
Penso che la situazione attuale della pandemia da Covid-19 ci stia mettendo a confronto proprio con questa questione: vivere il qui ed ora del presente. Ma il riuscire a farlo non è scontato perché, come diceva l’anziana signora, dipende da come ti trova il terremoto.
[1] Roberto Juarroz, “Poesía Vertical”, Catedra Ediciones, Madrid, 2012.
La traduco così in italiano: Cercare una cosa/ è sempre trovarne un’altra./ Così, per trovare qualcosa,/è necessario cercare ciò che non è./ Cercare il passero per trovare una rosa,/ cercare l’amore per trovare l’esilio,/ cercare il nulla per scoprire un uomo,/ andare indietro per andare avanti./ La chiave del percorso,/ più che nelle sue biforcazioni/ il suo sospettoso inizio/ o il suo dubbioso finale/ si trova nel caustico umore/ del suo doppio significato./ Sempre si arriva,/ ma da un’altra parte./ Tutto accade,/ ma al contrario.
[2] Cfr. la Teoria degli Ambiti di José Bleger.
[3] José Bleger, “Simbiosi e ambiguità”, Armando Editore, Roma, 2010.
[4] Silvia Amati Sas, “Ambiguità, conformismo e adattamento sociale alla violenza”, Franco Angeli, Milano, 2020.
[5] Enrique Pichon-Rivière, “Posizione schizoparanoide, depressiva e patoritmica. Approccio freudiano, kleiniano e riflessologico. La nostra posizione.” Lezione del 11/07/1966 alla Scuola Privata di Psichiatria Sociale, da www.lorenzosartini.com.
[6] Hanna Segal, “Melanie Klein”, Editore Boringhieri, Torino, 1981.
[7] Hanna Segal, ibid.
(Pubblicato su "I Quaderni della Formazione" n. 01/21, "Nel tempo capovolto della pandemia", edito da Sol.Co Mantova, https://www.solcomantova.it/wp-content/uploads/2021/03/quaderno-2021-num_DEF_con-copertina.pdf)
20 dicembre 2020
Condividi:
Dott. Lorenzo Sartini via Pellegrino Matteucci, 21 40137 Bologna cell: 3338443719 mail: [email protected]
C. F. SRTLNZ73C21I608M P. IVA: 02755261209