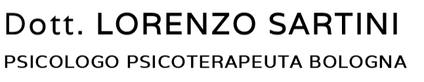SCRITTI
QUOTIDIANA CONFLITTUALITA'
di Lorenzo Sartini
Credo sia d’uopo iniziare con la derivazione etimologica del termine conflitto: da conflictus, urto, cozzo; che deriva da con-fligere, urtare una cosa contro un’altra; composto da con = cum, insieme, e fligere, percuotere, da cui flictus, percussione, collisione.
Solitamente il termine conflitto viene usato con un’accezione negativa: il conflitto viene considerato come qualcosa di male, come qualcosa di sbagliato, come qualcosa che non si deve fare e che è meglio, per quanto possibile, evitare.
Si dice conflitto e subito si pensa alla guerra: si pensa ad un comportamento che possa nuocere a qualcuno o qualcosa e la cui finalità sia soltanto la distruzione e la degenerazione (guerra: azione di eserciti nemici che si offendono in ogni guisa avendo per fine la vittoria; e, più in generale, dissidio tra due o più stati, il quale, non potendosi definire per via di giustizia, si definisce per quella delle armi).
Si dice conflitto e subito si pensa a qualcosa che sia del tutto contrapposto alla pace (in questo senso intesa anche come serenità domestica e familiare). Il conflitto come ciò che di più contrario c’è alla pace.
Ma forse è necessario fermarsi un po’ di più a pensare al significato della parola pace e, soprattutto, che cosa è necessario fare per arrivare ad una situazione di pace.
Riprendendo il poeta Edoardo Sanguineti:
“qui, se a una guerra non ci pensa una pace,
un’altra pace ci ha lì pronta la guerra…”
(Ballata della guerra)
Etimologicamente pace deriva da pax, pacis, e sta a significare un accordo tra due parti contendenti, ossia il ristabilirsi di una situazione di tranquillità precedentemente perduta. Il termine veniva usato in ambito politico, allorché i contendenti erano i diversi stati sovrani che cercavano di restaurare una situazione di pace, che quindi è il frutto di un accordo tra due entità sovrane. Ma la parola si applicava anche per indicare il realizzarsi di una pacificazione tra familiari.
Diretto derivato è il verbo latino pacare, calmare, tranquillizzare, pacificare, inteso nel senso di mettere in pace creditore e debitore, ossia saldare un debito, e da qui il nostro pagare. Sembra che nell’Impero Romano venissero pacati i soldati mercenari per non andare via, magari a combattere alla mercè del nemico, nei periodi di pausa tra una guerra e l’altra.
Dunque in seno alla parola pace è già presente la situazione di conflitto; è solamente affrontando un conflitto che si può sperare di giungere ad una situazione di pace.
Citando Gino Pagliarani, uno psicosocioanalista originario di Rimini e morto qualche anno fa in Svizzera, dov’era andato a vivere, possiamo affermare che
“la pace – paradossalmente – non è pacifica”.
(I due dolori del conflitto)
Si perviene ad una situazione di pace soltanto impegnandosi nella risoluzione dei conflitti che quotidianamente ci coinvolgono: nel nostro mondo interno ma anche nella realtà esterna, in famiglia, sul lavoro, nei luoghi del tempo libero, nei gruppi e nelle associazioni delle quali facciamo parte. Questi ambiti appena menzionati sono tutti contesti relazionali, che vedono protagonista me e l’altro (l’altro generalizzato di G. H. Mead), ed in effetti dobbiamo pensare che è possibile parlare di situazione conflittuale solamente laddove si stabilisca una relazione tra me e l’altro.
Il conflitto dunque, partendo da questi presupposti, sembra faccia parte della nostra vita: ma noi siamo pronti per affrontarlo? Abbiamo gli strumenti tecnici (le conoscenze) e personali (la capacità emotiva) per farvi fronte?
La domanda non è retorica perché molto spesso di fronte ad una situazione di instabilità, ovvero di conflittualità, si preferisce ricorrere ad un’azione quanto più decisa e risolutiva, la guerra, piuttosto che permanere nella complessità e nella difficoltà della situazione conflittuale. Si preferisce passare direttamente all’azione, provandosi a risolvere una situazione considerata di emergenza, piuttosto che soffermarsi, sostare nella condizione di incertezza e provare a cercare con l’altro, con il nostro contendente o interlocutore, i termini di un accordo.
È la storia che ci dice che le guerre non sono mai state risolutive di situazioni conflittuali (anzi spesso hanno prodotto esattamente l’effetto opposto, ossia quello di accentuarle) e che hanno sempre prodotto un dolore lacerante e infecondo. Contrariamente il dolore e la sofferenza che si patiscono nell’affrontare il conflitto sembrano caratterizzarsi per la loro generatività.
Ma permanere in una situazione conflittuale significa riuscire a rimanere lì, in quel momento, e cercare di comprendere l’altro e le sue ragioni, quell’altro che con il suo atteggiamento genera in noi così tanta rabbia; significa riuscire a gestire le ansie che da questa hanno, inevitabilmente, origine; significa mettersi nella prospettiva di concedere uno spazio dentro di noi all’altro, per accoglierlo, con le sue idee ed i suoi valori, e per farcelo conoscere; significa accettare la possibilità di venir messi in discussione nei propri pensieri e nelle proprie convinzioni, accettare la possibilità che l’altro possa influenzarci e farci star male perché ci si rende conto che le ragioni dell’altro, così diverse dalle nostre, hanno una loro motivazione.
Piuttosto che permanere in questo stato di inquietudine e di sofferenza si preferisce reagire allora, nelle situazioni che ci mettono in difficoltà, con la collera e con la rabbia, fino ad assumere atteggiamenti impensabili, in quanto all’espressione della violenza, fino ad un attimo prima.
Ciò, partendo anche dalla considerazione che sembra ci sia l’abitudine a considerare le situazioni che ci coinvolgono come estreme: sembra che si possa vivere o in una situazione di pace o in una situazione di guerra, comunque situazioni nelle quali si ha una posizione netta rispetto alla tematica trattata; o c’è il consenso completo oppure c’è un dissenso così forte da generare inevitabilmente lo scontro.
Forse buona cosa, e mi pare anche più realistica, sarebbe iniziare a pensare che le situazioni che ci coinvolgono e le relazioni che intratteniamo con gli altri non siano così nettamente schematizzabili e distinguibili: o totalmente buone o totalmente cattive. La maggior parte dei rapporti che ci vedono coinvolti non sono così polarizzati, ma sono rapporti nei quali si esperiscono diversi pensieri ed una pluralità di sentimenti, anche molto contrastanti tra loro sino ad arrivare alla contraddittorietà. Sono situazioni più sfumate, caratterizzate dall’incontro delle differenze, le mie e quelle dell’altro.
A questo proposito, capovolgendo il comune e stereotipato vertice di osservazione per il quale l’identità è essere uguali a se stessi, si potrebbe arrivare a sostenere che ci si possa definire solo partendo dalle differenze, che si possa definire se stessi solo partendo dal confronto con l’altro, ovvero che è il confronto con l’altro a permettere la definizione della propria identità. Invece, sembrerebbe che il senso comune ci dica che sia proprio questo incontro di differenze, chiaramente vissuto come problematico, a far percepire il conflitto in chiave negativa.
Dall’altra parte però, dobbiamo anche pensare che quando non si ha questo confronto tra differenze si cade sul versante opposto, ovvero quello dell’indifferenza: tutto uguale e indifferenziato, ossia senza differenze, appunto perché non ci si misura e non si ha la possibilità di rispecchiarsi nell’altro, di prendere l’altro come modello dal quale stagliarsi, dal quale differenziarsi.
L’altro è il nostro confine che ci limita e che, contemporaneamente, ci organizza, anche se sembra si cerchi continuamente di eliminarlo.
Ed in effetti, paradossalmente, è l’indifferenza e non il conflitto a far quotidianamente parte della nostra realtà più consapevole: la povertà, l’immigrazione, la mancanza di diritti nel più debole per esempio, sono tutte situazioni che, almeno per la maggior parte di noi, sembrano non riguardarci, non toccarci. Il solo lasciarsi toccare vorrebbe dire aprirsi ad un confronto con queste situazioni che provocherebbero certamente un conflitto: tra noi e la nostra coscienza. Ed allora per chetare e tranquillizzare la nostra coscienza si parla di tolleranza e di inclusione, termini che implicano una certa auto-referenzialità visto che ci si pone dalla parte del potere, arrogandosi la facoltà di concedere all’altro il diritto di esistere: io ti tollero, io ti includo a patto però che tu divenga come sono io, o come voglio io. E così si perde, ancora una volta, di vista l’altro: con la sua storia e la sua cultura, con le sue tradizioni e le sue motivazioni.
Anche per queste vie si cerca di eludere il conflitto.
Certo che oggi, considerando le ansie dovute al mondo globalizzato e quindi alla fatica di dover ampliare le nostre prospettive per riconoscersi in identità più larghe rispetto a quelle locali, fare completamente affidamento e rinchiudersi nella propria identità, considerata fissa e stabile, risulta essere una modalità di rapportarsi con il mondo esterno molto più comoda e rassicurante.
Ci si rinchiude nella propria casa e chi s’è visto s’è visto, tanto c’è la televisione o qualche altro mass-media che ci informa su ciò che accade nel mondo lì fuori.
Ma dobbiamo anche porci la domanda: che cosa perdiamo così facendo? Che cosa perdiamo quando non ci permettiamo di confliggere, cioè di entrare in relazione, con l’altro, che sia lo straniero o la nostra coscienza, il nostro mondo interno, come si diceva prima?
L’altro rappresenta infatti anche quelle nostre parti interne che si tende a nascondere nel più remoto angolo della coscienza, quelle parti che ci appartengono ma rispetto alle quali preferiamo fare finta di niente e rifuggirne il confronto; l’altro, in fin dei conti, siamo noi stessi.
Ed anzi i conflitti più difficili da affrontare sembra proprio che siano quelli che mettono a confronto con se stessi.
Chi non ha mai provato quella situazione di oppressiva immobilità e di stallo che blocca nell’impossibilità di prendere una decisione, di scegliere?
Una situazione rispetto alla quale qualunque soluzione o risposta viene sentita e vissuta come inadeguata. È questo il conflitto intrapsichico, interno, che forse è più difficile pensare e che sembra impossibile, nelle situazioni di forte ansia e tensione, riuscire a definire. Ed è così che, rimanendo nell’oscurità del nostro mondo psichico, questo conflitto vissuto ma non compreso tende a spostarsi su altri oggetti, su altri eventi di vita, cercando un’altra via dalla quale sfogarsi.
Così può accadere che, dopo essersi arrabbiati con Tizio e non aver affrontato la situazione conflittuale che ci separa ma che contemporaneamente ci lega a lui, si sfoghi inconsapevolmente la rabbia su Caio che non c’entrava niente, ma che si trovava ad attraversare la strada proprio mentre noi stavamo transitando per quella via. Oppure questo conflitto non affrontato si potrebbe manifestare nel corpo, attraverso dei disturbi fisici e somatici che possiamo considerare come rappresentativi del nostro stato di timore e di incertezza.
Si vivono situazioni nelle quali si preferisce, o forse più semplicemente è l’unica cosa che si riesce a fare in quei momenti, fuggire da relazioni conflittuali che vengono percepite drammatiche in quanto potenzialmente distruttive e disgreganti rispetto alla propria esistenza psichica. Casi nei quali la tentazione dalla quale subito si viene colti è quella di lasciarsi andare, di abbandonare tutto e di arrendersi.
Sostenere il conflitto è faticoso.
Ma è proprio questo ciò che si dovrebbe provare a fare: sostenerlo per affrontarlo ed arrivare a prendere una decisione consapevole in merito. Rispetto alla situazione di vuoto esistenziale che si prova nel conflitto, in quanto non ci sono punti di riferimento certi poiché tutto va rimesso in discussione nel confronto con l’altro, o con se stessi, si dovrebbe cercare di abitare quel vuoto per riuscire a dargli forma; si dovrebbe provare ad avvicinare l’elemento scatenante il conflitto, esterno ed interno, senza con-fondersi con esso ma aprendo alla possibilità di rapportarsi con il vuoto percepito in quella situazione, organizzando una nuova esperienza esistenziale.
Allorché ci si sente bloccati invece, con tutta probabilità è perché di fronte a situazioni che mettono in discussione il proprio pensiero e la propria identità ci si richiama a soluzioni preordinate e stereotipate, ricercando ed auspicando un esito certo e definitivo per il conflitto; speranza vana e paradossale se si pensa che si sta parlando di un momento relazionale caratterizzato, per definizione, da una mutevole complessità. Non è possibile stare fermi se si viene coinvolti in un conflitto, così come non è possibile pensare di vivere, nel senso più pieno della parola, senza dover affrontare continuamente dei conflitti.
Ma a quanto pare, al contrario, ciò che più di ogni altra cosa comunemente si ricerca, cadendo però, probabilmente, in un’abbagliante illusione, sembra essere una risoluzione finale del conflitto, pensando che dopo quello non c’è ne sarà più un altro. Fondamentalmente, si ricerca una risoluzione che possa farci evitare altri conflitti, e darci sicurezza e stabilità di fronte alla difficoltà costituita dal dover stare continuamente in relazione con l’altro e dal conseguente dispendio emotivo che questo rapporto comporta.
È ciò che nell’analisi istituzionale si definisce burocratizzazione, ossia quando l’istituzione perde di vista l’obiettivo principale, il fine, e fa in modo che i mezzi giustifichino se stessi e si automantengano, divenendo essi stessi il nuovo fine.
Ecco, nel nostro caso, riprendendo le parole di Carla Weber (1), una psicosocioanalista, “la ricerca di sicurezza, di stabilità, di integrità del sé che in una certa misura è condizione necessaria per sentirci capaci di pensare, fare e amare diventa invece il tutto, cioè il fine esistenziale costantemente perseguito, anche a scapito della propria possibilità e capacità di vita”
Torna qui il discorso sull’identità e sui pericoli, da leggersi come potenziali cambiamenti, che possono metterla in discussione.
Ma dobbiamo soffermarci sul fatto che l’identità, se da una parte si può pensare che permetta la funzione del riconoscimento, e contemporaneamente, dell’auto-riconoscimento attraverso la coincidenza con se stessi, dall’altra parte richiama anche alla rinuncia della possibilità di evolvere.
Chiudendo le porte al confronto con l’altro perdiamo la possibilità di rispondere alle nostre mancanze, a ciò che non siamo. È l’altro infatti che, seppur indirettamente, ci indica la strada, o meglio una delle possibili strade da seguire per arrivare ad essere ciò che ancora non siamo.
È l’altro che, mentre noi siamo girati a guardare altrove, ci tocca con la sua mano e ci indica una possibile direzione. Pensavamo volesse darci uno schiaffo, ed invece ci ha accarezzato; come si dice, la differenza tra uno schiaffo ed una carezza è tutta lì, nella velocità del gesto.
L’essere umano è un essere relazionale, non si trova mai solo e, sin dalle prime fasi della sua esistenza, si trova ad interagire con l’altro (2): inizialmente con la mamma; poi entrano in scena il papà, i fratellini, i parenti e gli amici, ed i compagni di scuola, ecc. ecc., tutte situazioni relazionali, ossia incontri con le differenze, all’interno delle quali la persona si forma e si arricchisce. Quindi l’indifferenza, ovvero la “riduzione della dimensione relazionale che riduce alla singolarità l’esperienza è, di fatto, una mortificazione” (Ugo Morelli).
Non si tratta di accettare tutto sempre e comunque, bensì di avere la convinzione che il nostro è soltanto uno dei punti di vista possibili, e che gli altri punti di vista abbiano tanta ragion d’essere e buone motivazioni come il nostro, seppur diversi, o meglio differenti. E dunque è a partire dal riconoscere il nostro punto di vista come legittimo, ma anche come solamente uno dei molteplici possibili, che possiamo aprirci e confliggere con l’altro, e ricercando, con l’altro, la possibilità di un dialogo.
Allora possiamo concludere affermando che attraverso il conflitto non si ricerca la guerra bensì una situazione di armonia e che, citando l’imperatore stoico Marco Aurelio,
“È conflitto la vita, è viaggio di un pellegrino”.
Note:
1. L’articolo qui ripreso, “Conflitto intrapsichico. Il teatro interno.”, così come la successiva citazione del Dott. Ugo Morelli, sono reperibili all’indirizzo www.polemos.it: sito dal quale, oltre a quelli direttamente riportati, sono stati tratti molti degli stimoli che si sono utilizzati per la redazione di questo lavoro.
2. Si potrebbe addirittura sostenere che all’inizio, nelle prime fasi di vita, l’infante è l’altro, dipendendo totalmente dalle cure dell’altro, la mamma, e probabilmente sussistendo ancora una fase di indifferenziazione rispetto ad essa. Una differenziazione, a livello psichico, potendo dunque pensarsi come diverso e distaccato dall’oggetto (mamma), sopraggiungerà solamente più tardi (cfr. Josè Bleger, “Simbiosi e ambiguità”, Edizioni Lauretana, 1992).
(2008)
Credo sia d’uopo iniziare con la derivazione etimologica del termine conflitto: da conflictus, urto, cozzo; che deriva da con-fligere, urtare una cosa contro un’altra; composto da con = cum, insieme, e fligere, percuotere, da cui flictus, percussione, collisione.
Solitamente il termine conflitto viene usato con un’accezione negativa: il conflitto viene considerato come qualcosa di male, come qualcosa di sbagliato, come qualcosa che non si deve fare e che è meglio, per quanto possibile, evitare.
Si dice conflitto e subito si pensa alla guerra: si pensa ad un comportamento che possa nuocere a qualcuno o qualcosa e la cui finalità sia soltanto la distruzione e la degenerazione (guerra: azione di eserciti nemici che si offendono in ogni guisa avendo per fine la vittoria; e, più in generale, dissidio tra due o più stati, il quale, non potendosi definire per via di giustizia, si definisce per quella delle armi).
Si dice conflitto e subito si pensa a qualcosa che sia del tutto contrapposto alla pace (in questo senso intesa anche come serenità domestica e familiare). Il conflitto come ciò che di più contrario c’è alla pace.
Ma forse è necessario fermarsi un po’ di più a pensare al significato della parola pace e, soprattutto, che cosa è necessario fare per arrivare ad una situazione di pace.
Riprendendo il poeta Edoardo Sanguineti:
“qui, se a una guerra non ci pensa una pace,
un’altra pace ci ha lì pronta la guerra…”
(Ballata della guerra)
Etimologicamente pace deriva da pax, pacis, e sta a significare un accordo tra due parti contendenti, ossia il ristabilirsi di una situazione di tranquillità precedentemente perduta. Il termine veniva usato in ambito politico, allorché i contendenti erano i diversi stati sovrani che cercavano di restaurare una situazione di pace, che quindi è il frutto di un accordo tra due entità sovrane. Ma la parola si applicava anche per indicare il realizzarsi di una pacificazione tra familiari.
Diretto derivato è il verbo latino pacare, calmare, tranquillizzare, pacificare, inteso nel senso di mettere in pace creditore e debitore, ossia saldare un debito, e da qui il nostro pagare. Sembra che nell’Impero Romano venissero pacati i soldati mercenari per non andare via, magari a combattere alla mercè del nemico, nei periodi di pausa tra una guerra e l’altra.
Dunque in seno alla parola pace è già presente la situazione di conflitto; è solamente affrontando un conflitto che si può sperare di giungere ad una situazione di pace.
Citando Gino Pagliarani, uno psicosocioanalista originario di Rimini e morto qualche anno fa in Svizzera, dov’era andato a vivere, possiamo affermare che
“la pace – paradossalmente – non è pacifica”.
(I due dolori del conflitto)
Si perviene ad una situazione di pace soltanto impegnandosi nella risoluzione dei conflitti che quotidianamente ci coinvolgono: nel nostro mondo interno ma anche nella realtà esterna, in famiglia, sul lavoro, nei luoghi del tempo libero, nei gruppi e nelle associazioni delle quali facciamo parte. Questi ambiti appena menzionati sono tutti contesti relazionali, che vedono protagonista me e l’altro (l’altro generalizzato di G. H. Mead), ed in effetti dobbiamo pensare che è possibile parlare di situazione conflittuale solamente laddove si stabilisca una relazione tra me e l’altro.
Il conflitto dunque, partendo da questi presupposti, sembra faccia parte della nostra vita: ma noi siamo pronti per affrontarlo? Abbiamo gli strumenti tecnici (le conoscenze) e personali (la capacità emotiva) per farvi fronte?
La domanda non è retorica perché molto spesso di fronte ad una situazione di instabilità, ovvero di conflittualità, si preferisce ricorrere ad un’azione quanto più decisa e risolutiva, la guerra, piuttosto che permanere nella complessità e nella difficoltà della situazione conflittuale. Si preferisce passare direttamente all’azione, provandosi a risolvere una situazione considerata di emergenza, piuttosto che soffermarsi, sostare nella condizione di incertezza e provare a cercare con l’altro, con il nostro contendente o interlocutore, i termini di un accordo.
È la storia che ci dice che le guerre non sono mai state risolutive di situazioni conflittuali (anzi spesso hanno prodotto esattamente l’effetto opposto, ossia quello di accentuarle) e che hanno sempre prodotto un dolore lacerante e infecondo. Contrariamente il dolore e la sofferenza che si patiscono nell’affrontare il conflitto sembrano caratterizzarsi per la loro generatività.
Ma permanere in una situazione conflittuale significa riuscire a rimanere lì, in quel momento, e cercare di comprendere l’altro e le sue ragioni, quell’altro che con il suo atteggiamento genera in noi così tanta rabbia; significa riuscire a gestire le ansie che da questa hanno, inevitabilmente, origine; significa mettersi nella prospettiva di concedere uno spazio dentro di noi all’altro, per accoglierlo, con le sue idee ed i suoi valori, e per farcelo conoscere; significa accettare la possibilità di venir messi in discussione nei propri pensieri e nelle proprie convinzioni, accettare la possibilità che l’altro possa influenzarci e farci star male perché ci si rende conto che le ragioni dell’altro, così diverse dalle nostre, hanno una loro motivazione.
Piuttosto che permanere in questo stato di inquietudine e di sofferenza si preferisce reagire allora, nelle situazioni che ci mettono in difficoltà, con la collera e con la rabbia, fino ad assumere atteggiamenti impensabili, in quanto all’espressione della violenza, fino ad un attimo prima.
Ciò, partendo anche dalla considerazione che sembra ci sia l’abitudine a considerare le situazioni che ci coinvolgono come estreme: sembra che si possa vivere o in una situazione di pace o in una situazione di guerra, comunque situazioni nelle quali si ha una posizione netta rispetto alla tematica trattata; o c’è il consenso completo oppure c’è un dissenso così forte da generare inevitabilmente lo scontro.
Forse buona cosa, e mi pare anche più realistica, sarebbe iniziare a pensare che le situazioni che ci coinvolgono e le relazioni che intratteniamo con gli altri non siano così nettamente schematizzabili e distinguibili: o totalmente buone o totalmente cattive. La maggior parte dei rapporti che ci vedono coinvolti non sono così polarizzati, ma sono rapporti nei quali si esperiscono diversi pensieri ed una pluralità di sentimenti, anche molto contrastanti tra loro sino ad arrivare alla contraddittorietà. Sono situazioni più sfumate, caratterizzate dall’incontro delle differenze, le mie e quelle dell’altro.
A questo proposito, capovolgendo il comune e stereotipato vertice di osservazione per il quale l’identità è essere uguali a se stessi, si potrebbe arrivare a sostenere che ci si possa definire solo partendo dalle differenze, che si possa definire se stessi solo partendo dal confronto con l’altro, ovvero che è il confronto con l’altro a permettere la definizione della propria identità. Invece, sembrerebbe che il senso comune ci dica che sia proprio questo incontro di differenze, chiaramente vissuto come problematico, a far percepire il conflitto in chiave negativa.
Dall’altra parte però, dobbiamo anche pensare che quando non si ha questo confronto tra differenze si cade sul versante opposto, ovvero quello dell’indifferenza: tutto uguale e indifferenziato, ossia senza differenze, appunto perché non ci si misura e non si ha la possibilità di rispecchiarsi nell’altro, di prendere l’altro come modello dal quale stagliarsi, dal quale differenziarsi.
L’altro è il nostro confine che ci limita e che, contemporaneamente, ci organizza, anche se sembra si cerchi continuamente di eliminarlo.
Ed in effetti, paradossalmente, è l’indifferenza e non il conflitto a far quotidianamente parte della nostra realtà più consapevole: la povertà, l’immigrazione, la mancanza di diritti nel più debole per esempio, sono tutte situazioni che, almeno per la maggior parte di noi, sembrano non riguardarci, non toccarci. Il solo lasciarsi toccare vorrebbe dire aprirsi ad un confronto con queste situazioni che provocherebbero certamente un conflitto: tra noi e la nostra coscienza. Ed allora per chetare e tranquillizzare la nostra coscienza si parla di tolleranza e di inclusione, termini che implicano una certa auto-referenzialità visto che ci si pone dalla parte del potere, arrogandosi la facoltà di concedere all’altro il diritto di esistere: io ti tollero, io ti includo a patto però che tu divenga come sono io, o come voglio io. E così si perde, ancora una volta, di vista l’altro: con la sua storia e la sua cultura, con le sue tradizioni e le sue motivazioni.
Anche per queste vie si cerca di eludere il conflitto.
Certo che oggi, considerando le ansie dovute al mondo globalizzato e quindi alla fatica di dover ampliare le nostre prospettive per riconoscersi in identità più larghe rispetto a quelle locali, fare completamente affidamento e rinchiudersi nella propria identità, considerata fissa e stabile, risulta essere una modalità di rapportarsi con il mondo esterno molto più comoda e rassicurante.
Ci si rinchiude nella propria casa e chi s’è visto s’è visto, tanto c’è la televisione o qualche altro mass-media che ci informa su ciò che accade nel mondo lì fuori.
Ma dobbiamo anche porci la domanda: che cosa perdiamo così facendo? Che cosa perdiamo quando non ci permettiamo di confliggere, cioè di entrare in relazione, con l’altro, che sia lo straniero o la nostra coscienza, il nostro mondo interno, come si diceva prima?
L’altro rappresenta infatti anche quelle nostre parti interne che si tende a nascondere nel più remoto angolo della coscienza, quelle parti che ci appartengono ma rispetto alle quali preferiamo fare finta di niente e rifuggirne il confronto; l’altro, in fin dei conti, siamo noi stessi.
Ed anzi i conflitti più difficili da affrontare sembra proprio che siano quelli che mettono a confronto con se stessi.
Chi non ha mai provato quella situazione di oppressiva immobilità e di stallo che blocca nell’impossibilità di prendere una decisione, di scegliere?
Una situazione rispetto alla quale qualunque soluzione o risposta viene sentita e vissuta come inadeguata. È questo il conflitto intrapsichico, interno, che forse è più difficile pensare e che sembra impossibile, nelle situazioni di forte ansia e tensione, riuscire a definire. Ed è così che, rimanendo nell’oscurità del nostro mondo psichico, questo conflitto vissuto ma non compreso tende a spostarsi su altri oggetti, su altri eventi di vita, cercando un’altra via dalla quale sfogarsi.
Così può accadere che, dopo essersi arrabbiati con Tizio e non aver affrontato la situazione conflittuale che ci separa ma che contemporaneamente ci lega a lui, si sfoghi inconsapevolmente la rabbia su Caio che non c’entrava niente, ma che si trovava ad attraversare la strada proprio mentre noi stavamo transitando per quella via. Oppure questo conflitto non affrontato si potrebbe manifestare nel corpo, attraverso dei disturbi fisici e somatici che possiamo considerare come rappresentativi del nostro stato di timore e di incertezza.
Si vivono situazioni nelle quali si preferisce, o forse più semplicemente è l’unica cosa che si riesce a fare in quei momenti, fuggire da relazioni conflittuali che vengono percepite drammatiche in quanto potenzialmente distruttive e disgreganti rispetto alla propria esistenza psichica. Casi nei quali la tentazione dalla quale subito si viene colti è quella di lasciarsi andare, di abbandonare tutto e di arrendersi.
Sostenere il conflitto è faticoso.
Ma è proprio questo ciò che si dovrebbe provare a fare: sostenerlo per affrontarlo ed arrivare a prendere una decisione consapevole in merito. Rispetto alla situazione di vuoto esistenziale che si prova nel conflitto, in quanto non ci sono punti di riferimento certi poiché tutto va rimesso in discussione nel confronto con l’altro, o con se stessi, si dovrebbe cercare di abitare quel vuoto per riuscire a dargli forma; si dovrebbe provare ad avvicinare l’elemento scatenante il conflitto, esterno ed interno, senza con-fondersi con esso ma aprendo alla possibilità di rapportarsi con il vuoto percepito in quella situazione, organizzando una nuova esperienza esistenziale.
Allorché ci si sente bloccati invece, con tutta probabilità è perché di fronte a situazioni che mettono in discussione il proprio pensiero e la propria identità ci si richiama a soluzioni preordinate e stereotipate, ricercando ed auspicando un esito certo e definitivo per il conflitto; speranza vana e paradossale se si pensa che si sta parlando di un momento relazionale caratterizzato, per definizione, da una mutevole complessità. Non è possibile stare fermi se si viene coinvolti in un conflitto, così come non è possibile pensare di vivere, nel senso più pieno della parola, senza dover affrontare continuamente dei conflitti.
Ma a quanto pare, al contrario, ciò che più di ogni altra cosa comunemente si ricerca, cadendo però, probabilmente, in un’abbagliante illusione, sembra essere una risoluzione finale del conflitto, pensando che dopo quello non c’è ne sarà più un altro. Fondamentalmente, si ricerca una risoluzione che possa farci evitare altri conflitti, e darci sicurezza e stabilità di fronte alla difficoltà costituita dal dover stare continuamente in relazione con l’altro e dal conseguente dispendio emotivo che questo rapporto comporta.
È ciò che nell’analisi istituzionale si definisce burocratizzazione, ossia quando l’istituzione perde di vista l’obiettivo principale, il fine, e fa in modo che i mezzi giustifichino se stessi e si automantengano, divenendo essi stessi il nuovo fine.
Ecco, nel nostro caso, riprendendo le parole di Carla Weber (1), una psicosocioanalista, “la ricerca di sicurezza, di stabilità, di integrità del sé che in una certa misura è condizione necessaria per sentirci capaci di pensare, fare e amare diventa invece il tutto, cioè il fine esistenziale costantemente perseguito, anche a scapito della propria possibilità e capacità di vita”
Torna qui il discorso sull’identità e sui pericoli, da leggersi come potenziali cambiamenti, che possono metterla in discussione.
Ma dobbiamo soffermarci sul fatto che l’identità, se da una parte si può pensare che permetta la funzione del riconoscimento, e contemporaneamente, dell’auto-riconoscimento attraverso la coincidenza con se stessi, dall’altra parte richiama anche alla rinuncia della possibilità di evolvere.
Chiudendo le porte al confronto con l’altro perdiamo la possibilità di rispondere alle nostre mancanze, a ciò che non siamo. È l’altro infatti che, seppur indirettamente, ci indica la strada, o meglio una delle possibili strade da seguire per arrivare ad essere ciò che ancora non siamo.
È l’altro che, mentre noi siamo girati a guardare altrove, ci tocca con la sua mano e ci indica una possibile direzione. Pensavamo volesse darci uno schiaffo, ed invece ci ha accarezzato; come si dice, la differenza tra uno schiaffo ed una carezza è tutta lì, nella velocità del gesto.
L’essere umano è un essere relazionale, non si trova mai solo e, sin dalle prime fasi della sua esistenza, si trova ad interagire con l’altro (2): inizialmente con la mamma; poi entrano in scena il papà, i fratellini, i parenti e gli amici, ed i compagni di scuola, ecc. ecc., tutte situazioni relazionali, ossia incontri con le differenze, all’interno delle quali la persona si forma e si arricchisce. Quindi l’indifferenza, ovvero la “riduzione della dimensione relazionale che riduce alla singolarità l’esperienza è, di fatto, una mortificazione” (Ugo Morelli).
Non si tratta di accettare tutto sempre e comunque, bensì di avere la convinzione che il nostro è soltanto uno dei punti di vista possibili, e che gli altri punti di vista abbiano tanta ragion d’essere e buone motivazioni come il nostro, seppur diversi, o meglio differenti. E dunque è a partire dal riconoscere il nostro punto di vista come legittimo, ma anche come solamente uno dei molteplici possibili, che possiamo aprirci e confliggere con l’altro, e ricercando, con l’altro, la possibilità di un dialogo.
Allora possiamo concludere affermando che attraverso il conflitto non si ricerca la guerra bensì una situazione di armonia e che, citando l’imperatore stoico Marco Aurelio,
“È conflitto la vita, è viaggio di un pellegrino”.
Note:
1. L’articolo qui ripreso, “Conflitto intrapsichico. Il teatro interno.”, così come la successiva citazione del Dott. Ugo Morelli, sono reperibili all’indirizzo www.polemos.it: sito dal quale, oltre a quelli direttamente riportati, sono stati tratti molti degli stimoli che si sono utilizzati per la redazione di questo lavoro.
2. Si potrebbe addirittura sostenere che all’inizio, nelle prime fasi di vita, l’infante è l’altro, dipendendo totalmente dalle cure dell’altro, la mamma, e probabilmente sussistendo ancora una fase di indifferenziazione rispetto ad essa. Una differenziazione, a livello psichico, potendo dunque pensarsi come diverso e distaccato dall’oggetto (mamma), sopraggiungerà solamente più tardi (cfr. Josè Bleger, “Simbiosi e ambiguità”, Edizioni Lauretana, 1992).
(2008)
Condividi:
Dott. Lorenzo Sartini via Pellegrino Matteucci, 21 40137 Bologna cell: 3338443719 mail: [email protected]
C. F. SRTLNZ73C21I608M P. IVA: 02755261209