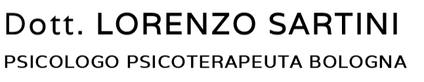TRADOTTI
RITRATTI DI ALCUNI SGUARDI DI MIO PADRE
di Marcelo Pichon-Rivière
Enrique Pichon-Rivière, lo Psicoanalista, il Maestro, Socrate, il Pioniere, il Santo, il Padre, ha sempre intravisto la follia senza paura
A mio padre, Enrique Pichon-Rivière, lo chiamavano Pinzón. Una parola che da bambino mi risultava misteriosa e musicale e che ora leggo, (la ascolto) come una miscela di punteruolo e capezzolo. Ha dato momenti dolorosi, acuti, e momenti soavi, calorosi, nutrienti. La sua intelligenza era acuta, spesso indolente. Chi provava a discutere qualche tema intellettuale con lui abitualmente ne usciva male. Aveva quell’arma che brilla come un coltello e appare nel momento più imprevisto: lo humor. Uno scherzo di Pichon disorientava chiunque. Ma anche la sua intelligenza era calorosa, nutriente. Alle ore più insperate e nei luoghi più improbabile, Pichon (come lo chiamavano i suoi discepoli, rispettando la dizione francese ma insinuando, quasi segnando, un castigliano accento nella “o”) illuminava o abbagliava tutti quelli che, semplicemente, si avvicinavano a lui per raccontare pene e confessare disattenzioni.
“Il freudomarxismo fenomenologico di uno, l’informazionalismo dell’altro, l’istituzionalismo di terzi, tutto era partito da Pichon. E per altre ragioni, o altri livelli, anche la Scuola Freudiana. Chi non ricorda quando Pichon diceva che il segreto di uno schizofrenico è ciò di cui nella famiglia non si parla, o che si doveva seguire le loro tracce, ma per interpretarle come una sciarada? La sua vita era una vera e propria deriva e, in qualche modo, aveva sempre a che fare con essa. Aveva qualcosa dell’immagine del Santo a cui si perdonava tutto e a cui alcuni hanno spiato ciò che non si poteva perdonare. Un Santo a cui sono caduti troppi oggetti ‘a’ nel suo percorso traballante. La sua seduzione era la sua generosità: sembrò sempre desiderare l’oggetto della domanda dell’altro. In un’epoca, nella quale la mia propria deriva mi avvicina alla sua, mi chiedevo perché gli sarebbe piaciuto avere più di un accendino nelle tasche e regalarli. In un paese senza una tradizione culturale consolidata e con una capitale troppo sofisticata, ma senza difesa contro la massiva entrata di informazione (quella che hanno, per esempio, i paesi europei: a Londra nel 1975 si ignora Lacan; a Buenos Aires esiste una maggior famigliarità, tra i quadri medi degli psicoanalisti, con l’opera di Melanie Klein, che tra i praticanti dello stesso livello di Parigi), uno psicoanalista come Pichon-Rivière, dotato inoltre di una solida formazione psichiatrica (per la sua formazione alcune volte lo si paragonava a Lacan), non cessava di apparire come quei medici del lontano ovest o dell’affamata campagna irlandese che devono fare tutto: estrarre un proiettile, assistere a una nascita, fare massaggi, operare alle tonsille, seppellire le persone”, dice Oscar Masotta in Ensayos lacanianos.
“La sua seduzione era la generosità”. Come spesso accade con i seduttori, mio padre seduceva tutti meno che sua moglie, Arminda Aberstury, ed i suoi figli: Enrique, Joaquín e Marcelo. Noi formavamo parte della retroguardia, della tranquilla e umida trincea dove il Santo tornava per riprendere le forze. I Santi, come gli ubriachi, inciampano. Si fermano alla prima cosa che li incrocia lungo la strada. Vanno alla deriva. Quel modo di essere non si adatta alla vita famigliare. Amava sua moglie ed i suoi figli, ma aveva anche bisogno di scappare. Le vie di fuga erano molteplici. L’alcool, gli psicofarmaci e, fondamentalmente, il lavoro. L’alcool attenuava una costante attività mentale e intellettuale, offrendogli un riposo caldo ed effimero. Le droghe della farmacia lo stimolavano, rendevano possibile un’onnipotenza impossibile. Nei primi anni di matrimonio, mia madre ignorava che lui prendeva stimolanti; ha provato a seguire il treno fino a quando non si è esaurita. (Parlando di treno: Joaquín, quando aveva due anni, aprì il cassetto del tavolo luminoso di mio padre e prese una di quelle pastiglie: non dormì per due giorni e nella sua agitazione, uno dei capricci è stato di andare a vedere i treni dopo la mezzanotte). Le sue presunte ubriacature erano, prima di tutto, momenti di collasso: la sua enorme forza lo abbandonava e cadeva fulminato dopo giorni e notti di incessante attività. Quando eravamo bambini il tema della sua dipendenza era qualcosa di conosciuto dai miei fratelli e da me. Per questo mi impressionò molto vedere L’uomo dal braccio d’oro, un film dove Frank Sinatra interpreta il ruolo di un morfinomane che cerca di abbandonare la droga. La terza via di fuga, l’ho detto, era il lavoro. Il suo impegno era assoluto. Con i discepoli ed i pazienti, con tutti coloro che si avvicinavano a lui, in cerca dello Psicoanalista, del Santo o del Padre. Poteva essere un appuntamento nel suo studio o un incontro casuale a Mau Mau o in una pizzeria del quartiere. Ricordo una notte che cenammo, mio padre, Ana Quiroga ed io, con un’amica e un nordamericano, veterano della guerra di Corea. Passammo dalle tranquille delizie della cucina francese in un ristorante di San Telmo, alle trincee della guerra nell’appartamento dell’hotel dell’americano. Mio padre sembrava un bambino: lanciava granate, strisciava tra i mobili con uno sguardo furioso, si immergeva sotto un letto come qualcuno che attraversa un campo pieno di filo spinato e mine nascoste. Certo, non faceva altro che accompagnare il soldato nel suo brusco ritorno all’Inferno. All’alba, il soldato aveva detto addio alle armi e stava tornando alla normalità.
Come disse Masotta: poteva estrarre un proiettile o assistere un parto. Era un medico di paese, amato, cercato, desiderato. Quando passava da qualche parte, era tanto normale invitarlo con una bevuta come gettargli addosso – letteralmente – il pazzo occulto della famiglia.
Nel prologo a Vie di fuga, un libro di memorie, Graham Green dice: “Scrivere è una forma di terapia; a volte mi domando come si organizzano tutti quelli che non scrivono, compongono o dipingono per scappare, dalla follia, dalla malinconia, dal terrore panico inerente alla situazione umana”. E cita un’osservazione di Auden: “L’uomo ha tanta necessità di scappare come del cibo e del sonno profondo”.
La forma di terapia di mio padre non era la scrittura. Un Santo alla deriva non scrive: parla. La gente si riuniva intorno a mio padre per ascoltarlo. In aula era insuperabile. Tutta la ricchezza che non hanno i suoi scritti (residui del discorso prolissamente redatti) la avevano le sue lezioni. Il suo pensiero ed il suo modo di parlare formavano un’unità dinamica, seduttrice, generosa. Dalla frase illuminata passava alla battuta tanto opportuna quanto imprevista; dalla densità di uno sviluppo della teoria passava al concreto, facendo sentire a ciascuno di coloro che erano presenti che la conoscenza è possibile, che ogni apprendimento è un transito vitale, un’iniziazione. Salvo nell’adolescenza, quando compose alcuni poemi in francese, a mio padre non interessò mai scrivere. Non aveva nessuna passione per la scrittura. I soliti mediocri attribuivano alla dispersione, ad una vita irregolare, disordinata, quella mancanza di interesse. Non è la spiegazione corretta. Quando decide di riunire in due volumi i suoi diversi articoli e le sue conferenze (Dalla psicoanalisi alla psicologia sociale, 1971), lo fa prima di tutto per lasciare una testimonianza, un’eredità scritta. Ma la sua passione si trovava nella parola detta, nella parola condivisa con il discepolo. Gli piaceva paragonare la sua attitudine con quella di Socrate. La sua passione, la sua via di fuga, era l’insegnamento, il continuo apprendimento, con e dai suoi alunni e pazienti. Pensare e curare, dire e interpretare formavano una stessa trama di parole e gesti. Erano la sua terapia per affrontare il terrore panico inerente alla situazione umana. Una terapia attiva e trasformatrice, il suo rimedio di medico di paese, per la follia e la malinconia.
Durante i viaggi, nelle vacanze e nei fine settimana lunghi, era solito raccontarci, ai miei fratelli e a me, le sue storie dell’infanzia. La prima cosa che mi abbagliava era la prossimità degli indios e degli animali. Un maiale selvaggio gli aveva morso un orecchio e per lui quella ferita era un motivo di orgoglio. Mi affascinava anche il suo passaggio dalla neve al fogliame della selva. Lo immaginavo su una slitta sulle strade innevate di Ginevra e poi avevo l’immagine di quella slitta, inutile, in un angolo della casa paterna nel Chaco. Un’altra storia mi impressionava particolarmente: una manica di locuste che radono al suolo il raccolto di cotone e tutto il resto, mentre il nonno, al momento che scompare il tetto di paglia della casa, esclama: “Quanto è bello, quanto è azzurro questo cielo!”. La storia che più a mio padre divertiva raccontare era quella di un uomo, un importante politico della zona, che andava per le isole cercando l’eco. Gridava: “Eco! Eco! Eco!”, e aspettava il riverbero del suono. Un giorno, mio padre ed i suoi amici salirono sugli alberi di una delle isole e aspettarono quest’uomo. Quando cominciò a cercare con le sue grida, gli risposero: “La puttana che ti ha partorito!”.
In una nitida sera del 1942 (due anni prima che io nascessi) Nieves Otero stava pulendo i resti di un incendio che aveva appiccato un bambino incendiario, nello studio di mia madre. Seguendo il ritmo della scopa, ripeteva instancabilmente: “Tutti pazzi, quelli che ci sono e quelli che verranno”. La cameriera ricordava un altro piccolo incidente: alla stessa ora, mio padre riceveva un epilettico che nei momenti critici urinava sul piano che si trovava nel soggiorno. 1942 è l’anno della fondazione dell’Associazione Psicoanalitica Argentina. Le prime riunioni dell’APA, che erano iniziate a casa di Celes Carcamo, ruotavano da un posto all’altro; così, mio padre venne nominato membro didatta nella sua propria casa. Nell’anno ’43 affittano un appartamento in Calle Juncal: appena un soggiorno e due camere, dove Ángel Garma, Marie Langer, Cárcamo, Arnaldo Rascovsky e mio padre discutono se gli analisti dovevano far pagare 3 o 5 pesos. Per Marie Langer, la cifra corretta era 3,50.
A quei tempi, la sentenza di Nieves era il commento abituale di tutti coloro che si affacciavano sull’infimo mondo della psicoanalisi in Argentina (cinque professori, dieci alunni, Arminda Aberastury tra essi): “Tutti pazzi, quelli che ci sono e quelli che verranno”. Con gli anni, i pregiudizi continuarono ad essere notevoli e suscitavano l’immaginazione della gente. Quando vivemmo in Calle Copernico, agli inizi dei ’50, una paziente raccontò a mia madre la versione che allora correva per il quartiere: con le tende chiuse, alla tenue luce dei candelabri, pranzavamo e cenavamo completamente nudi. I pionieri hanno una vita leggendaria. All’epica dei loro gesti quotidiani, delle loro grandezze e debolezze, si uniscono – come un’ombra grottesca – le confabulazioni della gente che non tollera le situazioni di cambiamento, e tanto meno coloro che sono i protagonisti di quelle trasformazioni. Per molti anni i nemici erano fuori. Erano i medici che non credevano che si potesse curare con la parola, quelli che volevano rinchiudere i pazzi e neutralizzare i nevrotici. Dopo, i nemici erano dentro. L’APA smise di essere la piccola e informale istituzione nella quale mio padre si muoveva come un pesce nell’acqua. Le sue idee vennero attaccate; la sua persona, diffamata. Negli anni ’60 molti predissero una fine lenta e sicura. Al contrario, dopo una grave crisi nel 1957 e un’altra nel 1965, Pichon non smise di lavorare, di rinnovarsi e di mantenere una notevole indipendenza di fronte alle successive divisioni che ebbero luogo nell’APA.
“Quando con il trascorrere del tempo Pichon danneggia seriamente la sua salute per un certo abuso di alcool e di droghe, non quelle pesanti e né quelle moderne, quelle di farmacia, il vecchio è inibito dall’Associazione Psicoanalitica Argentina. Che cosa gli si può rimproverare? Dopo avergli offerto assistenza medica e psicoanalitica, cos’altro potevano fare? Come quelle famiglie troppo strutturate, o forse solo troppo torturate internamente, alle quali nulla insegna la produzione di un pazzo. Da allora in poi la vita di Pichon è sempre stata appesa a un filo”, continua Oscar Masotta.
Era da tempo in realtà che Pichon metteva tutta la sua energia in un’altra istituzione, la Prima Scuola di Psicologia Sociale, la sua scuola. Anche lì dovette sopportare guerre interne, tentativi di usurpazione. Ma nessuno ha potuto piegarlo nel suo ambito. L’ambito di Socrate. Quando la sua voce diminuì quasi fino al limite del silenzio, dopo la lunga malattia che soffrì nel 1974, la sua presenza nella Scuola era quasi totemica. Il Santo già non parlava più, ma con il suo sguardo e con i suoi gesti manteneva inalterabile il fuoco della comunicazione, il transito vitale dell’apprendimento. Un tubo di plastica usciva dalla sua narice e già non poteva usare la bocca per bere e mangiare. Era esile. Ma la sua fragilità era ingannevole. Una forza profonda sorgeva da ciascuno dei suoi gesti. Egli disse sempre di fare la veronica alla morte. L’ombra di un corno di toro – come direbbe Michel Leiris – fu la pungente minaccia che lo accompagnò tutta la vita: la psicoanalisi e la psicologia sociale considerati come una tauromachia.
Mio padre diceva: “… Il mio interesse per l’osservazione della realtà ebbe, inizialmente, caratteristiche prescientifiche, più esattamente, mitiche e magiche, e acquisì una metodologia scientifica attraverso il compito psichiatrico…”, “… Collocato in un contesto nel quale le relazioni causali erano celate dall’idea dell’arbitrarietà del destino, la mia vocazione analitica nasce come necessità di chiarimento dei misteri famigliari e di indagine dei motivi che governavano la condotta dei gruppi immediati e mediati…”, “… La conoscenza psichiatrica , ciò che chiamiamo lo schema di riferimento della psichiatria, è nella mente dello studente. Ha dentro di sé il funzionamento di tutti i meccanismi della malattia con variazioni quantitative tra lui ed il malato più grave dell’ospedale psichiatrico. Per poter conoscerlo, entrarci dentro, l’apprendista deve assumere il ruolo del paziente…”.
La responsabilità di scrivere su un padre che fu psicoanalista è quasi uno stigma. Un marchio. La gente si aspetta che uno psicoanalista sia una persona equilibrata, padrona di se stessa. Che viva senza eccessi, senza errori. Soprattutto, questo: senza errori. Non c’è nulla di più lontano dalla vita – e, conseguentemente, dalla psicoanalisi – di un’esistenza ordinata. Bruno Bettelheim dice: “Si considera che l’obiettivo della psicoanalisi sia quello di semplificare la vita; ma non è questo ciò che la sua funzione intendeva. La psicoanalisi venne creata affinché l’uomo fosse capace di accettare la problematica della vita senza essere sopraffatto da essa o senza cedere all’evasione. Freud affermò che l’uomo può solo estrarre senso dalla sua esistenza lottando valorosamente contro quelle che sembrano schiaccianti forze superiori”.
Nessuno separa il poeta dalla poesia. Un giorno nessuno separerà gli psicoanalisti dalla psicoanalisi. Mio padre lottò contro quelle che sembravano schiaccianti forze superiori. Splendido modo che trovò Bettelheim per dire: il passato – famigliare, culturale – ci schiaccia come la legge il personaggio di Kafka. E in quel processo, inevitabile, mio padre uscì vittorioso. La lotta di mio padre fu doppia, come quella di ogni vero psicoanalista: combatté per la sua vita e per quella degli altri. E iniziò ad esercitare la sua professione in un’epoca nella quale le idee di Freud erano duramente attaccate, sia con l’indifferenza che con strategie scioccanti, di forza. Quando riuscì a formare un servizio esemplare nell’Hospicio de las Mercedes – a metà degli anni ’40 – fu buttato fuori e degradato.
La metafora della lotta continua. Un giorno, agli inizi degli anni ’70, andai a visitarlo. Quel giorno – in una sera luminosa – un uomo aspettava mio padre con ansietà, con angoscia. Quell’uomo – si direbbe – era pazzo. In un sussurro, Juana – una cameriera così enorme da dover passare di profilo da alcune porte e corridoi – mi avvertì che quell’uomo era stato arrestato perché dirigeva il traffico. Non era un poliziotto, [si capiva] da alcuni dati. Per un momento, mi ritrassi. La pazzia ci fa paura. Ma ricordai un consiglio di mio padre, una volta che si trovava – di visita – alla clinica che aveva nella Calle Rodríguez Peña: “Il pazzo – in qualche modo bisogna chiamarlo – ti aggredisce solo quando hai paura. Se un pazzo ti guarda negli occhi e non scopre paura, nulla ti può accadere”. Lo guardai negli occhi. Non vide paura nei miei occhi. Allora mi parlò. Mi disse: “Non me ne importa più”. Il suo corpo cadde. Letteralmente, cadde. Rintanato, guardando attraverso il corridoio la porta dello studio di Pichon, disse: “È come combattere contro Nicolino… non lo potrò mai raggiungere… colpisco, colpisco e non riesco a raggiungerlo, non si può…”.
Parlava di Locche, il pugile. Locche vinceva sempre l’avversario. Era lì, ma invincibile, irraggiungibile. Quante cose condensava quell’astuzia, quella prodigiosa occupazione? Si aprì la porta dello studio di mio padre. Gli fece un gesto affinché andasse lì. L’uomo, quell’uomo, cadde ancora. Qualcosa lo distruggeva. Mio padre fece un altro gesto, questa volta con la mano. Lo chiamava. L’uomo faceva no con la testa, con le mani. Immobile nella sua distruzione. All’improvviso, insperatamente, si raddrizzò, camminò attraverso il corridoio. Entrò nello studio. La porta si chiuse. Non conosco il finale di questa esperienza, di questa storia. Ciò che importa ora è l’immagine: due che lottano dalla stessa parte per qualcosa di quasi inafferrabile, che tante volte risulta intangibile: la vita.
Mio padre vinse forze schiaccianti. E ci lasciò una certezza: ci sono occhi che intravedono senza paura la follia.
Il mio omaggio va a quello sguardo.
(Pubblicato sulla rivista Uno Mismo)
Enrique Pichon-Rivière, lo Psicoanalista, il Maestro, Socrate, il Pioniere, il Santo, il Padre, ha sempre intravisto la follia senza paura
A mio padre, Enrique Pichon-Rivière, lo chiamavano Pinzón. Una parola che da bambino mi risultava misteriosa e musicale e che ora leggo, (la ascolto) come una miscela di punteruolo e capezzolo. Ha dato momenti dolorosi, acuti, e momenti soavi, calorosi, nutrienti. La sua intelligenza era acuta, spesso indolente. Chi provava a discutere qualche tema intellettuale con lui abitualmente ne usciva male. Aveva quell’arma che brilla come un coltello e appare nel momento più imprevisto: lo humor. Uno scherzo di Pichon disorientava chiunque. Ma anche la sua intelligenza era calorosa, nutriente. Alle ore più insperate e nei luoghi più improbabile, Pichon (come lo chiamavano i suoi discepoli, rispettando la dizione francese ma insinuando, quasi segnando, un castigliano accento nella “o”) illuminava o abbagliava tutti quelli che, semplicemente, si avvicinavano a lui per raccontare pene e confessare disattenzioni.
“Il freudomarxismo fenomenologico di uno, l’informazionalismo dell’altro, l’istituzionalismo di terzi, tutto era partito da Pichon. E per altre ragioni, o altri livelli, anche la Scuola Freudiana. Chi non ricorda quando Pichon diceva che il segreto di uno schizofrenico è ciò di cui nella famiglia non si parla, o che si doveva seguire le loro tracce, ma per interpretarle come una sciarada? La sua vita era una vera e propria deriva e, in qualche modo, aveva sempre a che fare con essa. Aveva qualcosa dell’immagine del Santo a cui si perdonava tutto e a cui alcuni hanno spiato ciò che non si poteva perdonare. Un Santo a cui sono caduti troppi oggetti ‘a’ nel suo percorso traballante. La sua seduzione era la sua generosità: sembrò sempre desiderare l’oggetto della domanda dell’altro. In un’epoca, nella quale la mia propria deriva mi avvicina alla sua, mi chiedevo perché gli sarebbe piaciuto avere più di un accendino nelle tasche e regalarli. In un paese senza una tradizione culturale consolidata e con una capitale troppo sofisticata, ma senza difesa contro la massiva entrata di informazione (quella che hanno, per esempio, i paesi europei: a Londra nel 1975 si ignora Lacan; a Buenos Aires esiste una maggior famigliarità, tra i quadri medi degli psicoanalisti, con l’opera di Melanie Klein, che tra i praticanti dello stesso livello di Parigi), uno psicoanalista come Pichon-Rivière, dotato inoltre di una solida formazione psichiatrica (per la sua formazione alcune volte lo si paragonava a Lacan), non cessava di apparire come quei medici del lontano ovest o dell’affamata campagna irlandese che devono fare tutto: estrarre un proiettile, assistere a una nascita, fare massaggi, operare alle tonsille, seppellire le persone”, dice Oscar Masotta in Ensayos lacanianos.
“La sua seduzione era la generosità”. Come spesso accade con i seduttori, mio padre seduceva tutti meno che sua moglie, Arminda Aberstury, ed i suoi figli: Enrique, Joaquín e Marcelo. Noi formavamo parte della retroguardia, della tranquilla e umida trincea dove il Santo tornava per riprendere le forze. I Santi, come gli ubriachi, inciampano. Si fermano alla prima cosa che li incrocia lungo la strada. Vanno alla deriva. Quel modo di essere non si adatta alla vita famigliare. Amava sua moglie ed i suoi figli, ma aveva anche bisogno di scappare. Le vie di fuga erano molteplici. L’alcool, gli psicofarmaci e, fondamentalmente, il lavoro. L’alcool attenuava una costante attività mentale e intellettuale, offrendogli un riposo caldo ed effimero. Le droghe della farmacia lo stimolavano, rendevano possibile un’onnipotenza impossibile. Nei primi anni di matrimonio, mia madre ignorava che lui prendeva stimolanti; ha provato a seguire il treno fino a quando non si è esaurita. (Parlando di treno: Joaquín, quando aveva due anni, aprì il cassetto del tavolo luminoso di mio padre e prese una di quelle pastiglie: non dormì per due giorni e nella sua agitazione, uno dei capricci è stato di andare a vedere i treni dopo la mezzanotte). Le sue presunte ubriacature erano, prima di tutto, momenti di collasso: la sua enorme forza lo abbandonava e cadeva fulminato dopo giorni e notti di incessante attività. Quando eravamo bambini il tema della sua dipendenza era qualcosa di conosciuto dai miei fratelli e da me. Per questo mi impressionò molto vedere L’uomo dal braccio d’oro, un film dove Frank Sinatra interpreta il ruolo di un morfinomane che cerca di abbandonare la droga. La terza via di fuga, l’ho detto, era il lavoro. Il suo impegno era assoluto. Con i discepoli ed i pazienti, con tutti coloro che si avvicinavano a lui, in cerca dello Psicoanalista, del Santo o del Padre. Poteva essere un appuntamento nel suo studio o un incontro casuale a Mau Mau o in una pizzeria del quartiere. Ricordo una notte che cenammo, mio padre, Ana Quiroga ed io, con un’amica e un nordamericano, veterano della guerra di Corea. Passammo dalle tranquille delizie della cucina francese in un ristorante di San Telmo, alle trincee della guerra nell’appartamento dell’hotel dell’americano. Mio padre sembrava un bambino: lanciava granate, strisciava tra i mobili con uno sguardo furioso, si immergeva sotto un letto come qualcuno che attraversa un campo pieno di filo spinato e mine nascoste. Certo, non faceva altro che accompagnare il soldato nel suo brusco ritorno all’Inferno. All’alba, il soldato aveva detto addio alle armi e stava tornando alla normalità.
Come disse Masotta: poteva estrarre un proiettile o assistere un parto. Era un medico di paese, amato, cercato, desiderato. Quando passava da qualche parte, era tanto normale invitarlo con una bevuta come gettargli addosso – letteralmente – il pazzo occulto della famiglia.
Nel prologo a Vie di fuga, un libro di memorie, Graham Green dice: “Scrivere è una forma di terapia; a volte mi domando come si organizzano tutti quelli che non scrivono, compongono o dipingono per scappare, dalla follia, dalla malinconia, dal terrore panico inerente alla situazione umana”. E cita un’osservazione di Auden: “L’uomo ha tanta necessità di scappare come del cibo e del sonno profondo”.
La forma di terapia di mio padre non era la scrittura. Un Santo alla deriva non scrive: parla. La gente si riuniva intorno a mio padre per ascoltarlo. In aula era insuperabile. Tutta la ricchezza che non hanno i suoi scritti (residui del discorso prolissamente redatti) la avevano le sue lezioni. Il suo pensiero ed il suo modo di parlare formavano un’unità dinamica, seduttrice, generosa. Dalla frase illuminata passava alla battuta tanto opportuna quanto imprevista; dalla densità di uno sviluppo della teoria passava al concreto, facendo sentire a ciascuno di coloro che erano presenti che la conoscenza è possibile, che ogni apprendimento è un transito vitale, un’iniziazione. Salvo nell’adolescenza, quando compose alcuni poemi in francese, a mio padre non interessò mai scrivere. Non aveva nessuna passione per la scrittura. I soliti mediocri attribuivano alla dispersione, ad una vita irregolare, disordinata, quella mancanza di interesse. Non è la spiegazione corretta. Quando decide di riunire in due volumi i suoi diversi articoli e le sue conferenze (Dalla psicoanalisi alla psicologia sociale, 1971), lo fa prima di tutto per lasciare una testimonianza, un’eredità scritta. Ma la sua passione si trovava nella parola detta, nella parola condivisa con il discepolo. Gli piaceva paragonare la sua attitudine con quella di Socrate. La sua passione, la sua via di fuga, era l’insegnamento, il continuo apprendimento, con e dai suoi alunni e pazienti. Pensare e curare, dire e interpretare formavano una stessa trama di parole e gesti. Erano la sua terapia per affrontare il terrore panico inerente alla situazione umana. Una terapia attiva e trasformatrice, il suo rimedio di medico di paese, per la follia e la malinconia.
Durante i viaggi, nelle vacanze e nei fine settimana lunghi, era solito raccontarci, ai miei fratelli e a me, le sue storie dell’infanzia. La prima cosa che mi abbagliava era la prossimità degli indios e degli animali. Un maiale selvaggio gli aveva morso un orecchio e per lui quella ferita era un motivo di orgoglio. Mi affascinava anche il suo passaggio dalla neve al fogliame della selva. Lo immaginavo su una slitta sulle strade innevate di Ginevra e poi avevo l’immagine di quella slitta, inutile, in un angolo della casa paterna nel Chaco. Un’altra storia mi impressionava particolarmente: una manica di locuste che radono al suolo il raccolto di cotone e tutto il resto, mentre il nonno, al momento che scompare il tetto di paglia della casa, esclama: “Quanto è bello, quanto è azzurro questo cielo!”. La storia che più a mio padre divertiva raccontare era quella di un uomo, un importante politico della zona, che andava per le isole cercando l’eco. Gridava: “Eco! Eco! Eco!”, e aspettava il riverbero del suono. Un giorno, mio padre ed i suoi amici salirono sugli alberi di una delle isole e aspettarono quest’uomo. Quando cominciò a cercare con le sue grida, gli risposero: “La puttana che ti ha partorito!”.
In una nitida sera del 1942 (due anni prima che io nascessi) Nieves Otero stava pulendo i resti di un incendio che aveva appiccato un bambino incendiario, nello studio di mia madre. Seguendo il ritmo della scopa, ripeteva instancabilmente: “Tutti pazzi, quelli che ci sono e quelli che verranno”. La cameriera ricordava un altro piccolo incidente: alla stessa ora, mio padre riceveva un epilettico che nei momenti critici urinava sul piano che si trovava nel soggiorno. 1942 è l’anno della fondazione dell’Associazione Psicoanalitica Argentina. Le prime riunioni dell’APA, che erano iniziate a casa di Celes Carcamo, ruotavano da un posto all’altro; così, mio padre venne nominato membro didatta nella sua propria casa. Nell’anno ’43 affittano un appartamento in Calle Juncal: appena un soggiorno e due camere, dove Ángel Garma, Marie Langer, Cárcamo, Arnaldo Rascovsky e mio padre discutono se gli analisti dovevano far pagare 3 o 5 pesos. Per Marie Langer, la cifra corretta era 3,50.
A quei tempi, la sentenza di Nieves era il commento abituale di tutti coloro che si affacciavano sull’infimo mondo della psicoanalisi in Argentina (cinque professori, dieci alunni, Arminda Aberastury tra essi): “Tutti pazzi, quelli che ci sono e quelli che verranno”. Con gli anni, i pregiudizi continuarono ad essere notevoli e suscitavano l’immaginazione della gente. Quando vivemmo in Calle Copernico, agli inizi dei ’50, una paziente raccontò a mia madre la versione che allora correva per il quartiere: con le tende chiuse, alla tenue luce dei candelabri, pranzavamo e cenavamo completamente nudi. I pionieri hanno una vita leggendaria. All’epica dei loro gesti quotidiani, delle loro grandezze e debolezze, si uniscono – come un’ombra grottesca – le confabulazioni della gente che non tollera le situazioni di cambiamento, e tanto meno coloro che sono i protagonisti di quelle trasformazioni. Per molti anni i nemici erano fuori. Erano i medici che non credevano che si potesse curare con la parola, quelli che volevano rinchiudere i pazzi e neutralizzare i nevrotici. Dopo, i nemici erano dentro. L’APA smise di essere la piccola e informale istituzione nella quale mio padre si muoveva come un pesce nell’acqua. Le sue idee vennero attaccate; la sua persona, diffamata. Negli anni ’60 molti predissero una fine lenta e sicura. Al contrario, dopo una grave crisi nel 1957 e un’altra nel 1965, Pichon non smise di lavorare, di rinnovarsi e di mantenere una notevole indipendenza di fronte alle successive divisioni che ebbero luogo nell’APA.
“Quando con il trascorrere del tempo Pichon danneggia seriamente la sua salute per un certo abuso di alcool e di droghe, non quelle pesanti e né quelle moderne, quelle di farmacia, il vecchio è inibito dall’Associazione Psicoanalitica Argentina. Che cosa gli si può rimproverare? Dopo avergli offerto assistenza medica e psicoanalitica, cos’altro potevano fare? Come quelle famiglie troppo strutturate, o forse solo troppo torturate internamente, alle quali nulla insegna la produzione di un pazzo. Da allora in poi la vita di Pichon è sempre stata appesa a un filo”, continua Oscar Masotta.
Era da tempo in realtà che Pichon metteva tutta la sua energia in un’altra istituzione, la Prima Scuola di Psicologia Sociale, la sua scuola. Anche lì dovette sopportare guerre interne, tentativi di usurpazione. Ma nessuno ha potuto piegarlo nel suo ambito. L’ambito di Socrate. Quando la sua voce diminuì quasi fino al limite del silenzio, dopo la lunga malattia che soffrì nel 1974, la sua presenza nella Scuola era quasi totemica. Il Santo già non parlava più, ma con il suo sguardo e con i suoi gesti manteneva inalterabile il fuoco della comunicazione, il transito vitale dell’apprendimento. Un tubo di plastica usciva dalla sua narice e già non poteva usare la bocca per bere e mangiare. Era esile. Ma la sua fragilità era ingannevole. Una forza profonda sorgeva da ciascuno dei suoi gesti. Egli disse sempre di fare la veronica alla morte. L’ombra di un corno di toro – come direbbe Michel Leiris – fu la pungente minaccia che lo accompagnò tutta la vita: la psicoanalisi e la psicologia sociale considerati come una tauromachia.
Mio padre diceva: “… Il mio interesse per l’osservazione della realtà ebbe, inizialmente, caratteristiche prescientifiche, più esattamente, mitiche e magiche, e acquisì una metodologia scientifica attraverso il compito psichiatrico…”, “… Collocato in un contesto nel quale le relazioni causali erano celate dall’idea dell’arbitrarietà del destino, la mia vocazione analitica nasce come necessità di chiarimento dei misteri famigliari e di indagine dei motivi che governavano la condotta dei gruppi immediati e mediati…”, “… La conoscenza psichiatrica , ciò che chiamiamo lo schema di riferimento della psichiatria, è nella mente dello studente. Ha dentro di sé il funzionamento di tutti i meccanismi della malattia con variazioni quantitative tra lui ed il malato più grave dell’ospedale psichiatrico. Per poter conoscerlo, entrarci dentro, l’apprendista deve assumere il ruolo del paziente…”.
La responsabilità di scrivere su un padre che fu psicoanalista è quasi uno stigma. Un marchio. La gente si aspetta che uno psicoanalista sia una persona equilibrata, padrona di se stessa. Che viva senza eccessi, senza errori. Soprattutto, questo: senza errori. Non c’è nulla di più lontano dalla vita – e, conseguentemente, dalla psicoanalisi – di un’esistenza ordinata. Bruno Bettelheim dice: “Si considera che l’obiettivo della psicoanalisi sia quello di semplificare la vita; ma non è questo ciò che la sua funzione intendeva. La psicoanalisi venne creata affinché l’uomo fosse capace di accettare la problematica della vita senza essere sopraffatto da essa o senza cedere all’evasione. Freud affermò che l’uomo può solo estrarre senso dalla sua esistenza lottando valorosamente contro quelle che sembrano schiaccianti forze superiori”.
Nessuno separa il poeta dalla poesia. Un giorno nessuno separerà gli psicoanalisti dalla psicoanalisi. Mio padre lottò contro quelle che sembravano schiaccianti forze superiori. Splendido modo che trovò Bettelheim per dire: il passato – famigliare, culturale – ci schiaccia come la legge il personaggio di Kafka. E in quel processo, inevitabile, mio padre uscì vittorioso. La lotta di mio padre fu doppia, come quella di ogni vero psicoanalista: combatté per la sua vita e per quella degli altri. E iniziò ad esercitare la sua professione in un’epoca nella quale le idee di Freud erano duramente attaccate, sia con l’indifferenza che con strategie scioccanti, di forza. Quando riuscì a formare un servizio esemplare nell’Hospicio de las Mercedes – a metà degli anni ’40 – fu buttato fuori e degradato.
La metafora della lotta continua. Un giorno, agli inizi degli anni ’70, andai a visitarlo. Quel giorno – in una sera luminosa – un uomo aspettava mio padre con ansietà, con angoscia. Quell’uomo – si direbbe – era pazzo. In un sussurro, Juana – una cameriera così enorme da dover passare di profilo da alcune porte e corridoi – mi avvertì che quell’uomo era stato arrestato perché dirigeva il traffico. Non era un poliziotto, [si capiva] da alcuni dati. Per un momento, mi ritrassi. La pazzia ci fa paura. Ma ricordai un consiglio di mio padre, una volta che si trovava – di visita – alla clinica che aveva nella Calle Rodríguez Peña: “Il pazzo – in qualche modo bisogna chiamarlo – ti aggredisce solo quando hai paura. Se un pazzo ti guarda negli occhi e non scopre paura, nulla ti può accadere”. Lo guardai negli occhi. Non vide paura nei miei occhi. Allora mi parlò. Mi disse: “Non me ne importa più”. Il suo corpo cadde. Letteralmente, cadde. Rintanato, guardando attraverso il corridoio la porta dello studio di Pichon, disse: “È come combattere contro Nicolino… non lo potrò mai raggiungere… colpisco, colpisco e non riesco a raggiungerlo, non si può…”.
Parlava di Locche, il pugile. Locche vinceva sempre l’avversario. Era lì, ma invincibile, irraggiungibile. Quante cose condensava quell’astuzia, quella prodigiosa occupazione? Si aprì la porta dello studio di mio padre. Gli fece un gesto affinché andasse lì. L’uomo, quell’uomo, cadde ancora. Qualcosa lo distruggeva. Mio padre fece un altro gesto, questa volta con la mano. Lo chiamava. L’uomo faceva no con la testa, con le mani. Immobile nella sua distruzione. All’improvviso, insperatamente, si raddrizzò, camminò attraverso il corridoio. Entrò nello studio. La porta si chiuse. Non conosco il finale di questa esperienza, di questa storia. Ciò che importa ora è l’immagine: due che lottano dalla stessa parte per qualcosa di quasi inafferrabile, che tante volte risulta intangibile: la vita.
Mio padre vinse forze schiaccianti. E ci lasciò una certezza: ci sono occhi che intravedono senza paura la follia.
Il mio omaggio va a quello sguardo.
(Pubblicato sulla rivista Uno Mismo)
Condividi:
Dott. Lorenzo Sartini via Pellegrino Matteucci, 21 40137 Bologna cell: 3338443719 mail: [email protected]
C. F. SRTLNZ73C21I608M P. IVA: 02755261209