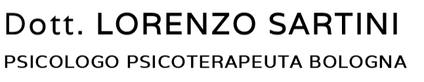SCRITTI
SINTESI DE "IL GRUPPO COME ISTITUZIONE E IL GRUPPO NELLE ISTITUZIONI" DI JOSE' BLEGER
(da “Psicoigiene e psicologia istituzionale”, pagg. 187–200, Libreria Editrice Laureatana, 1989)
a cura di Lorenzo Sartini
Si può considerare il gruppo come “un insieme di individui che interagiscono attenendosi a determinate norme nello svolgimento di un compito”.
In ogni gruppo c’è un tipo di relazione che è, paradossalmente, una non-relazione, ossia una non-individuazione che si impone come matrice fondamentale e strutturante di ogni gruppo e che persiste in maniera variabile per tutta la vita di quest’ultimo.
L’esistenza e l’identità di una persona o di un gruppo sono determinate, nella realtà quotidiana e manifesta, dalla struttura e dall’integrazione che raggiunge in ciascun caso l’Io individuale e del gruppo: per Io di gruppo si intende il grado di organizzazione, di estensione e di integrazione di quell’insieme di manifestazioni che chiamiamo verbalizzazione, motricità, azione, giudizio, raziocinio, pensiero, ecc. Ma questa individuazione si fonda necessariamente su una certa immobilizzazione degli stati sincretici e non discriminati della personalità o del gruppo.
Fra i due strati della personalità (o dell’identità) si stabilisce un forte clivaggio che impedisce loro di entrare reciprocamente in relazione: è questa immobilizzazione degli aspetti sincretici che permette l’organizzazione, la mobilizzazione, la dinamica ed il lavoro terapeutico sugli aspetti più integrati della personalità e del gruppo.
In effetti le crisi più profonde attraversate da un gruppo sono dovute alla rottura di questo clivaggio ed alla conseguente comparsa dei livelli sincretici. L’identità, dunque, non è data solamente dall’Io bensì anche dall’Io sincretico (ovvero quella parte della personalità non chiaramente differenziata che potrebbe, in qualche modo, essere avvicinata all’Es o al Super-Io freudiani).
Nei gruppi esistono anche degli aspetti che potremmo definire istituzionalizzati e che corrispondono ai modelli, alle norme ed alle strutture che sono state o erano già organizzate in un determinato modo.
Considereremo gli aspetti istituzionali del gruppo terapeutico che opera al di fuori delle istituzioni e poi i gruppi terapeutici che operano all’interno di un’istituzione.
Quindi, come si diceva, un gruppo è un insieme di persone che entrano in relazione tra loro, ma il gruppo è anche essenzialmente una socialità stabilita su uno sfondo di indifferenziazione o di sincretismo, in cui gli individui non esistono in quanto tali e fra di essi opera un transitivismo permanente. Nel gruppo terapeutico poi interviene uno dei suoi componenti, il terapeuta, con un ruolo specializzato e predeterminato, ma quest’ultima funzione viene svolta su una base in cui il terapeuta è coinvolto nello stesso sfondo di sincretismo del gruppo.
Sartre, a questo proposito, considerava che fintanto che non si stabilisce l’interazione il gruppo non è tale, ma è solamente una serialità, nel senso che ogni individuo è equivalente ad un altro ed insieme costituiscono una serie di persone equiparabili, non distinte le une dalle altre. Bleger sostiene che tale serialità sia precisamente quello sfondo di solidarietà, di indiscriminazione o di sincretismo che costituisce il vincolo più potente fra i membri del gruppo: tanto che senza di esso l’interazione non sarebbe possibile.
Tale sfondo di solidarietà è, per Bleger, una socialità particolare caratterizzata da una non-relazione e da una indifferenziazione in cui nessun individuo si distingue da un altro o è discriminato rispetto ad un altro, e in cui non vi è una discriminazione stabilita fra Io e non-Io, fra corpo e spazio, o fra l'Io e l’altro.
Bleger fa una distinzione tra il punto di vista naturalistico e quello fenomenologico:
1) per punto di vista naturalistico si intende la descrizione di un fenomeno fatta da un osservatore che lo vede “dall’esterno”, ossia, come un fenomeno della natura che esiste indipendentemente dal soggetto osservatore;
2) per descrizione od osservazione fenomenologica si deve invece intendere quella effettuata dall’interno dei fenomeni stessi, così come vengono percepiti, sperimentati, vissuti od organizzati da coloro che prendono parte al fenomeno o ad un dato evento.
A questo proposito Bleger fa rilevare come gran parte di ciò che si definisce comunemente identificazione proiettiva e introiettiva costituisca in realtà una descrizione naturalistica di quello che da un punto di vista fenomenologico corrisponde al sincretismo.
Per spiegare questo concetto Bleger propone l’esempio di una madre e del bimbo che si trovano in una stanza; la madre va in un’altra stanza e, seppur non parlandosi, il bimbo la segue. Si presume dunque che, anche laddove manchi l’interazione, non ci si parla o non ci si guarda, sia però presente la socialità sincretica, nella quale ciascuno di coloro che, da un punto di vista naturalistico, consideriamo persone isolate si trova in uno stato di fusione o di indiscriminazione. Il bambino che gioca isolato può, per l’appunto, restare isolato e riuscire a giocare fintanto che ha la sicurezza di mantenere clivata, grazie ad un depositario fedele, la socialità sincretica (simbiosi).
Uno degli esempi che Sartre cita come tipici della serialità è quello di una fila di persone in attesa di un autobus; egli presuppone che la caratteristica fondamentale di tale serialità è che ciascuna persona in fila sia un individuo perfettamente isolato e sostituibile, come numero, con un altro. Bleger dice che anche in questo tipo di situazione è presente la socialità sincretica depositata nelle norme e nei modelli che vigono per tutti gli individui. E ognuna delle persone in coda ha questa sicurezza, a un punto tale che non arriva neanche ad esserne cosciente. Possiamo comportarci come individui in interazione nella misura in cui condividiamo una convenzione di modelli e di norme che sono taciti, ma che esistono e grazie ai quali possiamo costituire altri modelli di comportamento. Perché si possa interagire deve esserci uno sfondo comune di socievolezza. L’interazione è la figura di una Gestalt il cui sfondo è la socievolezza sincretica: la seconda è il codice della prima.
Quando un gruppo di persone che si incontra per fare un gruppo terapeutico si ritrova per la prima volta nello studio del terapeuta, il terapeuta osserva immediatamente una serie di fenomeni che classifichiamo come reazioni paranoidi: manifestazioni di paura di fronte ad una situazione nuova, di fronte all’ignoto. Quando diciamo che il gruppo reagisce con paura di fronte ad un’esperienza nuova, all’indeterminato e all’ignoto, esprimiamo una verità molto più vasta di quanto noi stessi siamo disposti ad ammettere: non è solamente il nuovo a fare paura, ma l’ignoto che è racchiuso nel noto (l’Unheimlich di Freud).
Quando si rilevano ansie paranoidi, della paura di fronte all’ignoto o a una situazione nuova, in realtà si dice che la paura è generata dall’ignoto che ogni persona porta con sé sotto forma di non-persona e di non-identità (o di Io sincretico): quello che si esplicita in termini di ansie paranoidi è la paura dei membri del gruppo di non poter continuare a reagire secondo i modelli consolidati che hanno assimilato come individui e di trovarsi di fronte ad una socialità che li destituisca dal loro essere persone e li trasformi in un unico ambiente omogeneo, sincretico, in cui nessuno emerga come figura (persona) dallo sfondo, ma nel quale ciascuno si trovi immerso, il che implica una dissoluzione dell’identità strutturata dei livelli più integrati dell’Io, del Sé o della personalità. La paura nasce in presenza di questa organizzazione.
Da un prospettiva fenomenologica ciò implica la perdita dell’identità (di una identità) e l’immersione in una identità di gruppo che è al di là, o al di qua, dell’identità convenzionale da noi riconosciuta come tale. Si tratta della paura del gruppo di regredire ai livelli di una socialità sincretica che non è costituita da un’interrelazione o da un’interazione, ma esige una dissoluzione dell’individualità ed il recupero dei livelli della socialità incontinente non manifesti in quel momento, ma presenti già prima che si facesse parte del gruppo e fin dal primo incontro con esso.
Bleger sta parlando di gruppi terapeutici formati da persone nevrotiche, cioè da persone che conservano o hanno raggiunto un buon livello di integrazione della personalità, poiché i gruppi formati da persone che non hanno raggiunto un certo grado di individuazione o di identità individuale cercano immediatamente di creare una situazione simbiotica di dipendenza e di identità di gruppo.
L’identità di gruppo ha due livelli in tutti i gruppi: uno è quello di un’identità prodotta da un lavoro in comune e sulla base della quale si stabiliscono modelli di interazione e di comportamento istituzionalizzati all’interno del gruppo; l’altro è presente in tutti i gruppi, e a volte l’unico esistente (o l’unico che il gruppo è in grado di raggiungere), è quello rappresentato da una forma di identità molto particolare che possiamo chiamare identità sincretica di gruppo e che si costituisce non sulla base di un’integrazione, di un’interazione e di modelli di livelli evoluti, ma di una socializzazione in cui tali limiti non esistono e in cui ognuno di coloro che da un punto di vista naturalistico noi vediamo come soggetti, individui o persone, non ha identità in quanto tale, ma in quanto appartenente al gruppo.
Quanto maggiore è il grado di appartenenza ad un gruppo tanto maggiore sarà l’identità sincretica di gruppo (in contrapposizione all’identità per integrazione). E quanto maggiore è l’identità per integrazione tanto minore sarà l’appartenenza sincretica al gruppo: l’appartenenza è sempre, paradossalmente, una dipendenza ai livelli della socialità sincretica.
Bleger parla di tre tipi di gruppi o di individui che possono appartenere allo stesso gruppo o a gruppi diversi:
1) gli individui dipendenti o simbiotici utilizzeranno immediatamente il gruppo come un gruppo di dipendenza o di appartenenza e cercheranno di stabilizzare la propria identità attraverso questa appartenenza, che è la forma di identità più completa da essi raggiunta nel corso dell’evoluzione. Si tratta di individui in cui l’organizzazione simbiotica ha avuto una durata superiore al necessario. Essi cercheranno di trasformare manifestamente il gruppo in un’organizzazione stabile, ma l’interazione sarà superficiale e tenderà a non favorire un vero processo di gruppo;
2) gli individui nevrotici o normali, in cui la nevrosi riguarda soltanto una parte della personalità, mentre hanno raggiunto in buona misura una certa individuazione e personificazione. Tenderanno a muoversi nella socialità d’interazione e possono presentarsi come gruppi molto attivi, molto vivaci, ma su un piano soltanto e con rafforzamento del clivaggio. Possono succedere molte cose perché non succeda nulla;
3) coloro che non hanno mai avuto una relazione simbiotica e che non ne stabiliranno una nemmeno all’interno del gruppo: le personalità psicopatiche, perverse, le as if personalities descritte da Helene Deutsch e tutte le personalità ambigue. In tali individui il gruppo sembra giocare un ruolo alquanto marginale e poco importante ma non è così: in realtà essi tendono al tipo di gruppo caratterizzato dalla socialità sincretica, non manifesta (soprattutto pre-verbale).
Fino ad ora si è parlato del gruppo, ora veniamo all’istituzione.
Il termine istituzione verrà utilizzato in relazione all’insieme di norme, modelli e attività imperniate su valori e funzioni sociali. Benché l’istituzione venga definita anche come un’organizzazione, nel senso di una disposizione gerarchica di funzioni che si svolgono generalmente all’interno di un edificio, di un’area o di uno spazio delimitato, per questa seconda accezione utilizzerò esclusivamente la parola organizzazione.
Il gruppo è sempre un’istituzione molto complessa, o meglio è sempre un’insieme di istituzioni, ma nello stesso tempo tende a consolidarsi come organizzazione, con modelli propri o fissi. Il fatto importante è che quanto più il gruppo tende a stabilizzarsi come organizzazione, tanto più esso è portato a concentrarsi sulla propria esistenza ponendo in secondo piano, o subordinando a quest’ultimo obiettivo, quello più propriamente terapeutico. L’organizzazione dell’interazione arriva ad un punto in cui diviene antiterapeutica, e questo per due ragioni fondamentali:
a) innanzitutto perché si organizzano i livelli di interazione in maniera fissa e stabile;
b) ma poi la fissità e la stereotipia dell’organizzazione si fondano anche ed essenzialmente sul consolidamento del controllo operato sul clivaggio fra i due livelli, in modo tale che la socialità sincretica rimanga immobilizzata.
Questo fenomeno corrisponde ad un legge generale delle organizzazioni, secondo la quale in tutte le organizzazioni gli obiettivi espliciti per cui sono state create corrono sempre il rischio di passare in secondo piano, mentre acquisisce primaria importanza la perpetuazione dell’organizzazione in quanto tale. E questo accade non soltanto al fine di preservare la stereotipia dei livelli di interazione, ma principalmente per salvaguardare e rafforzare il clivaggio, la depositazione e l’immobilizzazione della socialità sincretica (o parte psicotica del gruppo).
Un gruppo in cui si è arrestato il processo per lasciar posto al consolidamento delle sue caratteristiche di organizzazione si trasforma da gruppo terapeutico in gruppo antiterapeutico: ossia il gruppo si è burocratizzato, intendendo per burocrazia quell’organizzazione in cui i mezzi si trasformano in fini e si dimentica di essere ricorsi ai mezzi per conseguire determinati obiettivi.
La tendenza all’organizzazione ed alla burocratizzazione è volta a rafforzare il clivaggio e ad occultare o bloccare, in tal modo, i livelli simbiotici o sincretici: così può anche accadere che un gruppo “lavori bene”, riuscendo a rompere delle stereotipie, ma soltanto a livello di interazione, una situazione dunque dove il gruppo cambia continuamente ma, in realtà, senza mai cambiare.
Questa considerazione è molto importante poiché si deve considerare che è possibile sostenere che qualsiasi organizzazione tende ad avere la stessa struttura del problema che deve affrontare e per il quale è stata creata (dunque un ospedale finisce con l’avere le stesse caratteristiche dei malati: isolamento, deprivazione sensoriale, carenze nella comunicazione, ecc.)
Le nostre organizzazoini psichiatriche, le nostre terapie, le nostre teorie e le nostre tecniche hanno la stessa struttura dei fenomeni che dobbiamo affrontare. Sono diventate e non sono nient’altro che organizzazioni, e assolvono pertanto, con la loro tendenza alla formalizzazione burocratica, un’identica funzione di mantenimento e controllo del clivaggio.
A tale proposito possiamo pensare alla funzione iatrogena e di rafforzamento delle malattie svolta dai nostri ospedali psichiatrici, ma vi sono anche altri aspetti che hanno lo stesso effetto burocratico iatrogeno e un’uguale funzione latente: quella di mantenere il clivaggio controllando la socialità sincretica.
La società tende ad istaurare una separazione fra quello che considera sano e quello che considera malato, fra quello che ritiene normale e quello che giudica anormale. Stabilisce così una scissione molto profonda fra essa (la società “sana”) e tutti quelli che, come i pazzi, i delinquenti e le prostitute, presentano deviazioni o malattie che si suppone non abbiano niente a che vedere con la struttura sociale. La società si autodifende, ma non dai pazzi, dai delinquenti e dalle prostitute, bensì dalla sua stessa pazzia, delinquenza e prostituzione, che in questo modo aliena, disconosce e tratta come se le fossero estranee e non la riguardassero.
Una segregazione ed una scissione che si trasmettono poi ai nostri strumenti ed alle nostre conoscenze. Allora, rispettare il clivaggio di un gruppo terapeutico e non esaminare i livelli di socialità sincretica significa accettare questa segregazione sancita dalla società, così come i suoi criteri normativi; accettare i meccanismi in base ai quali determinati soggetti risultano ammalati e segregati, nonché il criterio di adattamento applicato alla salute e alla malattia e la segregazione di quest’ultima intesa come “cura”.
Anche lo staff tecnico di un ospedale o la sua équipe amministrativa tendono a strutturarsi come organizzazioni, e le resistenze al cambiamento non necessariamente provengono sempre e soltanto dai pazienti o dai loro famigliari, ma molto più spesso derivano proprio da noi in quanto apparteniamo a delle organizzazioni e queste sono parte della nostra personalità. Nelle organizzazioni accade, inoltre, che i conflitti suscitati ai livelli superiori si manifestino o vengano rilevati ai livelli inferiori: succederà allora che i conflitti dello staff tecnico diverranno manifesti non nei suoi componenti, ma nei pazienti o nel personale subalterno, così come le tensioni ed i conflitti fra i genitori molto spesso non compaiono in loro ma come sintomi nei loro figli.
Nelle nostre teorie concettuali contrapponiamo l’individuo al gruppo e all’organizzazione, presupponendo poi che gli individui vivano isolati e poi si riuniscano per formare i gruppi e le organizzazioni. Ma l’essere umano prima che una persona è sempre un gruppo, ma non nel senso che appartiene ad un gruppo, bensì in quanto la sua personalità è il gruppo.
È per tale motivo che la dissoluzione di un’organizzazione o il tentativo di cambiamento della stessa possono essere la causa diretta della disgregazione della personalità, e non solo per proiezione, ma per il fatto che il gruppo e l’organizzazione sono la personalità dei loro componenti (considerare, ad esempio, la grande frequenza di malattie organiche gravi nei neopensionati).
Dunque, c’è una specie di travaso in ciò che si sta dicendo: prima si diceva che ogni gruppo tende ad essere un’organizzazione ed ora, parlando di organizzazioni, si afferma che queste ultime costituiscono parte della personalità degli individui e a volte l’intera personalità.
Se E. Jaques sostiene che le istituzioni servono come difesa di fronte alle ansie psicotiche, Bleger rileva che tale affermazione è riduttiva poiché le istituzioni e le organizzazioni sono depositarie della socialità sincretica o della parte psicotica e ciò spiegherebbe in gran parte la tendenza alla burocrazia e la resistenza la cambiamento.
Quando si lavora nelle organizzazioni come psicologi istituzionali, la dinamica di gruppo è una tecnica che permette di affrontare problemi di tipo organizzativo, ma per utilizzare tali tecniche dobbiamo poter disporre di una strategia del nostro intervento e nello stesso tempo di una “diagnosi” della situazione dell’organizzazione.
Uno dei problemi fondamentali all’interno di un’organizzazione riguarda non soltanto la dinamica dell’intragruppo, ma anche quelle fra i gruppi, e il nostro obiettivo può non essere costituito dai gruppi bensì dall’organigramma.
(2009)
a cura di Lorenzo Sartini
Si può considerare il gruppo come “un insieme di individui che interagiscono attenendosi a determinate norme nello svolgimento di un compito”.
In ogni gruppo c’è un tipo di relazione che è, paradossalmente, una non-relazione, ossia una non-individuazione che si impone come matrice fondamentale e strutturante di ogni gruppo e che persiste in maniera variabile per tutta la vita di quest’ultimo.
L’esistenza e l’identità di una persona o di un gruppo sono determinate, nella realtà quotidiana e manifesta, dalla struttura e dall’integrazione che raggiunge in ciascun caso l’Io individuale e del gruppo: per Io di gruppo si intende il grado di organizzazione, di estensione e di integrazione di quell’insieme di manifestazioni che chiamiamo verbalizzazione, motricità, azione, giudizio, raziocinio, pensiero, ecc. Ma questa individuazione si fonda necessariamente su una certa immobilizzazione degli stati sincretici e non discriminati della personalità o del gruppo.
Fra i due strati della personalità (o dell’identità) si stabilisce un forte clivaggio che impedisce loro di entrare reciprocamente in relazione: è questa immobilizzazione degli aspetti sincretici che permette l’organizzazione, la mobilizzazione, la dinamica ed il lavoro terapeutico sugli aspetti più integrati della personalità e del gruppo.
In effetti le crisi più profonde attraversate da un gruppo sono dovute alla rottura di questo clivaggio ed alla conseguente comparsa dei livelli sincretici. L’identità, dunque, non è data solamente dall’Io bensì anche dall’Io sincretico (ovvero quella parte della personalità non chiaramente differenziata che potrebbe, in qualche modo, essere avvicinata all’Es o al Super-Io freudiani).
Nei gruppi esistono anche degli aspetti che potremmo definire istituzionalizzati e che corrispondono ai modelli, alle norme ed alle strutture che sono state o erano già organizzate in un determinato modo.
Considereremo gli aspetti istituzionali del gruppo terapeutico che opera al di fuori delle istituzioni e poi i gruppi terapeutici che operano all’interno di un’istituzione.
Quindi, come si diceva, un gruppo è un insieme di persone che entrano in relazione tra loro, ma il gruppo è anche essenzialmente una socialità stabilita su uno sfondo di indifferenziazione o di sincretismo, in cui gli individui non esistono in quanto tali e fra di essi opera un transitivismo permanente. Nel gruppo terapeutico poi interviene uno dei suoi componenti, il terapeuta, con un ruolo specializzato e predeterminato, ma quest’ultima funzione viene svolta su una base in cui il terapeuta è coinvolto nello stesso sfondo di sincretismo del gruppo.
Sartre, a questo proposito, considerava che fintanto che non si stabilisce l’interazione il gruppo non è tale, ma è solamente una serialità, nel senso che ogni individuo è equivalente ad un altro ed insieme costituiscono una serie di persone equiparabili, non distinte le une dalle altre. Bleger sostiene che tale serialità sia precisamente quello sfondo di solidarietà, di indiscriminazione o di sincretismo che costituisce il vincolo più potente fra i membri del gruppo: tanto che senza di esso l’interazione non sarebbe possibile.
Tale sfondo di solidarietà è, per Bleger, una socialità particolare caratterizzata da una non-relazione e da una indifferenziazione in cui nessun individuo si distingue da un altro o è discriminato rispetto ad un altro, e in cui non vi è una discriminazione stabilita fra Io e non-Io, fra corpo e spazio, o fra l'Io e l’altro.
Bleger fa una distinzione tra il punto di vista naturalistico e quello fenomenologico:
1) per punto di vista naturalistico si intende la descrizione di un fenomeno fatta da un osservatore che lo vede “dall’esterno”, ossia, come un fenomeno della natura che esiste indipendentemente dal soggetto osservatore;
2) per descrizione od osservazione fenomenologica si deve invece intendere quella effettuata dall’interno dei fenomeni stessi, così come vengono percepiti, sperimentati, vissuti od organizzati da coloro che prendono parte al fenomeno o ad un dato evento.
A questo proposito Bleger fa rilevare come gran parte di ciò che si definisce comunemente identificazione proiettiva e introiettiva costituisca in realtà una descrizione naturalistica di quello che da un punto di vista fenomenologico corrisponde al sincretismo.
Per spiegare questo concetto Bleger propone l’esempio di una madre e del bimbo che si trovano in una stanza; la madre va in un’altra stanza e, seppur non parlandosi, il bimbo la segue. Si presume dunque che, anche laddove manchi l’interazione, non ci si parla o non ci si guarda, sia però presente la socialità sincretica, nella quale ciascuno di coloro che, da un punto di vista naturalistico, consideriamo persone isolate si trova in uno stato di fusione o di indiscriminazione. Il bambino che gioca isolato può, per l’appunto, restare isolato e riuscire a giocare fintanto che ha la sicurezza di mantenere clivata, grazie ad un depositario fedele, la socialità sincretica (simbiosi).
Uno degli esempi che Sartre cita come tipici della serialità è quello di una fila di persone in attesa di un autobus; egli presuppone che la caratteristica fondamentale di tale serialità è che ciascuna persona in fila sia un individuo perfettamente isolato e sostituibile, come numero, con un altro. Bleger dice che anche in questo tipo di situazione è presente la socialità sincretica depositata nelle norme e nei modelli che vigono per tutti gli individui. E ognuna delle persone in coda ha questa sicurezza, a un punto tale che non arriva neanche ad esserne cosciente. Possiamo comportarci come individui in interazione nella misura in cui condividiamo una convenzione di modelli e di norme che sono taciti, ma che esistono e grazie ai quali possiamo costituire altri modelli di comportamento. Perché si possa interagire deve esserci uno sfondo comune di socievolezza. L’interazione è la figura di una Gestalt il cui sfondo è la socievolezza sincretica: la seconda è il codice della prima.
Quando un gruppo di persone che si incontra per fare un gruppo terapeutico si ritrova per la prima volta nello studio del terapeuta, il terapeuta osserva immediatamente una serie di fenomeni che classifichiamo come reazioni paranoidi: manifestazioni di paura di fronte ad una situazione nuova, di fronte all’ignoto. Quando diciamo che il gruppo reagisce con paura di fronte ad un’esperienza nuova, all’indeterminato e all’ignoto, esprimiamo una verità molto più vasta di quanto noi stessi siamo disposti ad ammettere: non è solamente il nuovo a fare paura, ma l’ignoto che è racchiuso nel noto (l’Unheimlich di Freud).
Quando si rilevano ansie paranoidi, della paura di fronte all’ignoto o a una situazione nuova, in realtà si dice che la paura è generata dall’ignoto che ogni persona porta con sé sotto forma di non-persona e di non-identità (o di Io sincretico): quello che si esplicita in termini di ansie paranoidi è la paura dei membri del gruppo di non poter continuare a reagire secondo i modelli consolidati che hanno assimilato come individui e di trovarsi di fronte ad una socialità che li destituisca dal loro essere persone e li trasformi in un unico ambiente omogeneo, sincretico, in cui nessuno emerga come figura (persona) dallo sfondo, ma nel quale ciascuno si trovi immerso, il che implica una dissoluzione dell’identità strutturata dei livelli più integrati dell’Io, del Sé o della personalità. La paura nasce in presenza di questa organizzazione.
Da un prospettiva fenomenologica ciò implica la perdita dell’identità (di una identità) e l’immersione in una identità di gruppo che è al di là, o al di qua, dell’identità convenzionale da noi riconosciuta come tale. Si tratta della paura del gruppo di regredire ai livelli di una socialità sincretica che non è costituita da un’interrelazione o da un’interazione, ma esige una dissoluzione dell’individualità ed il recupero dei livelli della socialità incontinente non manifesti in quel momento, ma presenti già prima che si facesse parte del gruppo e fin dal primo incontro con esso.
Bleger sta parlando di gruppi terapeutici formati da persone nevrotiche, cioè da persone che conservano o hanno raggiunto un buon livello di integrazione della personalità, poiché i gruppi formati da persone che non hanno raggiunto un certo grado di individuazione o di identità individuale cercano immediatamente di creare una situazione simbiotica di dipendenza e di identità di gruppo.
L’identità di gruppo ha due livelli in tutti i gruppi: uno è quello di un’identità prodotta da un lavoro in comune e sulla base della quale si stabiliscono modelli di interazione e di comportamento istituzionalizzati all’interno del gruppo; l’altro è presente in tutti i gruppi, e a volte l’unico esistente (o l’unico che il gruppo è in grado di raggiungere), è quello rappresentato da una forma di identità molto particolare che possiamo chiamare identità sincretica di gruppo e che si costituisce non sulla base di un’integrazione, di un’interazione e di modelli di livelli evoluti, ma di una socializzazione in cui tali limiti non esistono e in cui ognuno di coloro che da un punto di vista naturalistico noi vediamo come soggetti, individui o persone, non ha identità in quanto tale, ma in quanto appartenente al gruppo.
Quanto maggiore è il grado di appartenenza ad un gruppo tanto maggiore sarà l’identità sincretica di gruppo (in contrapposizione all’identità per integrazione). E quanto maggiore è l’identità per integrazione tanto minore sarà l’appartenenza sincretica al gruppo: l’appartenenza è sempre, paradossalmente, una dipendenza ai livelli della socialità sincretica.
Bleger parla di tre tipi di gruppi o di individui che possono appartenere allo stesso gruppo o a gruppi diversi:
1) gli individui dipendenti o simbiotici utilizzeranno immediatamente il gruppo come un gruppo di dipendenza o di appartenenza e cercheranno di stabilizzare la propria identità attraverso questa appartenenza, che è la forma di identità più completa da essi raggiunta nel corso dell’evoluzione. Si tratta di individui in cui l’organizzazione simbiotica ha avuto una durata superiore al necessario. Essi cercheranno di trasformare manifestamente il gruppo in un’organizzazione stabile, ma l’interazione sarà superficiale e tenderà a non favorire un vero processo di gruppo;
2) gli individui nevrotici o normali, in cui la nevrosi riguarda soltanto una parte della personalità, mentre hanno raggiunto in buona misura una certa individuazione e personificazione. Tenderanno a muoversi nella socialità d’interazione e possono presentarsi come gruppi molto attivi, molto vivaci, ma su un piano soltanto e con rafforzamento del clivaggio. Possono succedere molte cose perché non succeda nulla;
3) coloro che non hanno mai avuto una relazione simbiotica e che non ne stabiliranno una nemmeno all’interno del gruppo: le personalità psicopatiche, perverse, le as if personalities descritte da Helene Deutsch e tutte le personalità ambigue. In tali individui il gruppo sembra giocare un ruolo alquanto marginale e poco importante ma non è così: in realtà essi tendono al tipo di gruppo caratterizzato dalla socialità sincretica, non manifesta (soprattutto pre-verbale).
Fino ad ora si è parlato del gruppo, ora veniamo all’istituzione.
Il termine istituzione verrà utilizzato in relazione all’insieme di norme, modelli e attività imperniate su valori e funzioni sociali. Benché l’istituzione venga definita anche come un’organizzazione, nel senso di una disposizione gerarchica di funzioni che si svolgono generalmente all’interno di un edificio, di un’area o di uno spazio delimitato, per questa seconda accezione utilizzerò esclusivamente la parola organizzazione.
Il gruppo è sempre un’istituzione molto complessa, o meglio è sempre un’insieme di istituzioni, ma nello stesso tempo tende a consolidarsi come organizzazione, con modelli propri o fissi. Il fatto importante è che quanto più il gruppo tende a stabilizzarsi come organizzazione, tanto più esso è portato a concentrarsi sulla propria esistenza ponendo in secondo piano, o subordinando a quest’ultimo obiettivo, quello più propriamente terapeutico. L’organizzazione dell’interazione arriva ad un punto in cui diviene antiterapeutica, e questo per due ragioni fondamentali:
a) innanzitutto perché si organizzano i livelli di interazione in maniera fissa e stabile;
b) ma poi la fissità e la stereotipia dell’organizzazione si fondano anche ed essenzialmente sul consolidamento del controllo operato sul clivaggio fra i due livelli, in modo tale che la socialità sincretica rimanga immobilizzata.
Questo fenomeno corrisponde ad un legge generale delle organizzazioni, secondo la quale in tutte le organizzazioni gli obiettivi espliciti per cui sono state create corrono sempre il rischio di passare in secondo piano, mentre acquisisce primaria importanza la perpetuazione dell’organizzazione in quanto tale. E questo accade non soltanto al fine di preservare la stereotipia dei livelli di interazione, ma principalmente per salvaguardare e rafforzare il clivaggio, la depositazione e l’immobilizzazione della socialità sincretica (o parte psicotica del gruppo).
Un gruppo in cui si è arrestato il processo per lasciar posto al consolidamento delle sue caratteristiche di organizzazione si trasforma da gruppo terapeutico in gruppo antiterapeutico: ossia il gruppo si è burocratizzato, intendendo per burocrazia quell’organizzazione in cui i mezzi si trasformano in fini e si dimentica di essere ricorsi ai mezzi per conseguire determinati obiettivi.
La tendenza all’organizzazione ed alla burocratizzazione è volta a rafforzare il clivaggio e ad occultare o bloccare, in tal modo, i livelli simbiotici o sincretici: così può anche accadere che un gruppo “lavori bene”, riuscendo a rompere delle stereotipie, ma soltanto a livello di interazione, una situazione dunque dove il gruppo cambia continuamente ma, in realtà, senza mai cambiare.
Questa considerazione è molto importante poiché si deve considerare che è possibile sostenere che qualsiasi organizzazione tende ad avere la stessa struttura del problema che deve affrontare e per il quale è stata creata (dunque un ospedale finisce con l’avere le stesse caratteristiche dei malati: isolamento, deprivazione sensoriale, carenze nella comunicazione, ecc.)
Le nostre organizzazoini psichiatriche, le nostre terapie, le nostre teorie e le nostre tecniche hanno la stessa struttura dei fenomeni che dobbiamo affrontare. Sono diventate e non sono nient’altro che organizzazioni, e assolvono pertanto, con la loro tendenza alla formalizzazione burocratica, un’identica funzione di mantenimento e controllo del clivaggio.
A tale proposito possiamo pensare alla funzione iatrogena e di rafforzamento delle malattie svolta dai nostri ospedali psichiatrici, ma vi sono anche altri aspetti che hanno lo stesso effetto burocratico iatrogeno e un’uguale funzione latente: quella di mantenere il clivaggio controllando la socialità sincretica.
La società tende ad istaurare una separazione fra quello che considera sano e quello che considera malato, fra quello che ritiene normale e quello che giudica anormale. Stabilisce così una scissione molto profonda fra essa (la società “sana”) e tutti quelli che, come i pazzi, i delinquenti e le prostitute, presentano deviazioni o malattie che si suppone non abbiano niente a che vedere con la struttura sociale. La società si autodifende, ma non dai pazzi, dai delinquenti e dalle prostitute, bensì dalla sua stessa pazzia, delinquenza e prostituzione, che in questo modo aliena, disconosce e tratta come se le fossero estranee e non la riguardassero.
Una segregazione ed una scissione che si trasmettono poi ai nostri strumenti ed alle nostre conoscenze. Allora, rispettare il clivaggio di un gruppo terapeutico e non esaminare i livelli di socialità sincretica significa accettare questa segregazione sancita dalla società, così come i suoi criteri normativi; accettare i meccanismi in base ai quali determinati soggetti risultano ammalati e segregati, nonché il criterio di adattamento applicato alla salute e alla malattia e la segregazione di quest’ultima intesa come “cura”.
Anche lo staff tecnico di un ospedale o la sua équipe amministrativa tendono a strutturarsi come organizzazioni, e le resistenze al cambiamento non necessariamente provengono sempre e soltanto dai pazienti o dai loro famigliari, ma molto più spesso derivano proprio da noi in quanto apparteniamo a delle organizzazioni e queste sono parte della nostra personalità. Nelle organizzazioni accade, inoltre, che i conflitti suscitati ai livelli superiori si manifestino o vengano rilevati ai livelli inferiori: succederà allora che i conflitti dello staff tecnico diverranno manifesti non nei suoi componenti, ma nei pazienti o nel personale subalterno, così come le tensioni ed i conflitti fra i genitori molto spesso non compaiono in loro ma come sintomi nei loro figli.
Nelle nostre teorie concettuali contrapponiamo l’individuo al gruppo e all’organizzazione, presupponendo poi che gli individui vivano isolati e poi si riuniscano per formare i gruppi e le organizzazioni. Ma l’essere umano prima che una persona è sempre un gruppo, ma non nel senso che appartiene ad un gruppo, bensì in quanto la sua personalità è il gruppo.
È per tale motivo che la dissoluzione di un’organizzazione o il tentativo di cambiamento della stessa possono essere la causa diretta della disgregazione della personalità, e non solo per proiezione, ma per il fatto che il gruppo e l’organizzazione sono la personalità dei loro componenti (considerare, ad esempio, la grande frequenza di malattie organiche gravi nei neopensionati).
Dunque, c’è una specie di travaso in ciò che si sta dicendo: prima si diceva che ogni gruppo tende ad essere un’organizzazione ed ora, parlando di organizzazioni, si afferma che queste ultime costituiscono parte della personalità degli individui e a volte l’intera personalità.
Se E. Jaques sostiene che le istituzioni servono come difesa di fronte alle ansie psicotiche, Bleger rileva che tale affermazione è riduttiva poiché le istituzioni e le organizzazioni sono depositarie della socialità sincretica o della parte psicotica e ciò spiegherebbe in gran parte la tendenza alla burocrazia e la resistenza la cambiamento.
Quando si lavora nelle organizzazioni come psicologi istituzionali, la dinamica di gruppo è una tecnica che permette di affrontare problemi di tipo organizzativo, ma per utilizzare tali tecniche dobbiamo poter disporre di una strategia del nostro intervento e nello stesso tempo di una “diagnosi” della situazione dell’organizzazione.
Uno dei problemi fondamentali all’interno di un’organizzazione riguarda non soltanto la dinamica dell’intragruppo, ma anche quelle fra i gruppi, e il nostro obiettivo può non essere costituito dai gruppi bensì dall’organigramma.
(2009)
Condividi:
Dott. Lorenzo Sartini via Pellegrino Matteucci, 21 40137 Bologna cell: 3338443719 mail: [email protected]
C. F. SRTLNZ73C21I608M P. IVA: 02755261209