Sono passati cento anni da quando Benjamin, in un saggio memorabile, denunciava la miseria spirituale della vita degli studenti berlinesi e esattamente mezzo secolo da quando un libello anonimo diffuso nell’università di Strasburgo enunciava il suo tema nel titolo Della miseria nell’ambiente studentesco, considerata nei suoi aspetti economici, politici, psicologici, sessuali e in particolare intellettuali. Da allora, non soltanto la diagnosi impietosa non ha perso la sua attualità, ma si può dire senza timore di esagerare che la miseria – insieme economica e spirituale – della condizione studentesca si è accresciuta in misura incontrollabile. E questa degradazione è, per un osservatore accorto, tanto più evidente, in quanto si cerca di nasconderla attraverso l’elaborazione di un vocabolario ad hoc, che sta fra il gergo dell’impresa e la nomenclatura del laboratorio scientifico.
Una spia di questa impostura terminologica è la sostituzione in ogni ambito della parola “ricerca” a quella, che appare evidentemente meno prestigiosa, di “studio”. E la sostituzione è così integrale che ci si può domandare se la parola, praticamente scomparsa dai documenti accademici, finirà per essere cancellata anche dalla formula, che suona ormai come un relitto storico, “Università degli studi”. Cercheremo invece di mostrare che non soltanto lo studio è un paradigma conoscitivo sotto ogni aspetto superiore alla ricerca, ma che, nell’ambito delle scienze umane, lo statuto epistemologico che gli compete è assai meno contraddittorio di quello della didattica e della ricerca.
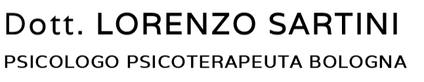
 Feed RSS
Feed RSS
