Sono passati cento anni da quando Benjamin, in un saggio memorabile, denunciava la miseria spirituale della vita degli studenti berlinesi e esattamente mezzo secolo da quando un libello anonimo diffuso nell’università di Strasburgo enunciava il suo tema nel titolo Della miseria nell’ambiente studentesco, considerata nei suoi aspetti economici, politici, psicologici, sessuali e in particolare intellettuali. Da allora, non soltanto la diagnosi impietosa non ha perso la sua attualità, ma si può dire senza timore di esagerare che la miseria – insieme economica e spirituale – della condizione studentesca si è accresciuta in misura incontrollabile. E questa degradazione è, per un osservatore accorto, tanto più evidente, in quanto si cerca di nasconderla attraverso l’elaborazione di un vocabolario ad hoc, che sta fra il gergo dell’impresa e la nomenclatura del laboratorio scientifico.
Una spia di questa impostura terminologica è la sostituzione in ogni ambito della parola “ricerca” a quella, che appare evidentemente meno prestigiosa, di “studio”. E la sostituzione è così integrale che ci si può domandare se la parola, praticamente scomparsa dai documenti accademici, finirà per essere cancellata anche dalla formula, che suona ormai come un relitto storico, “Università degli studi”. Cercheremo invece di mostrare che non soltanto lo studio è un paradigma conoscitivo sotto ogni aspetto superiore alla ricerca, ma che, nell’ambito delle scienze umane, lo statuto epistemologico che gli compete è assai meno contraddittorio di quello della didattica e della ricerca.
Qui il “ricercatore” – che si potrebbe più propriamente definire “studioso” – ha bisogno soltanto di biblioteche e di archivi, l’accesso ai quali è generalmente facile e gratuito (quando una tassa di iscrizione è richiesta, essa è irrisoria). In questo senso le proteste ricorrenti sull’insufficienza dei fondi di ricerca (effettivamente scarsi) sono destituite di ogni fondamento. I fondi in questione vengono infatti usati non per la ricerca in senso proprio, ma per partecipare a convegni e colloqui che per la loro natura non hanno nulla da spartire con i loro equivalenti nelle scienze naturali: mentre in questi si tratta di comunicarsi le novità più urgenti non soltanto nella teoria, ma anche e innanzitutto nelle verifiche sperimentali, nulla di simile può avvenire in ambito umanistico, in cui l’interpretazione di un passo di Plotino o di Leopardi non è legata ad alcuna urgenza particolare. Da queste diversità strutturali consegue inoltre che mentre nelle scienze della natura le ricerche più avanzate sono generalmente condotte da gruppi di scienziati che lavorano insieme, nelle scienze umane i risultati più innovativi sono ottenuti di solito da studiosi solitari, che passano il loro tempo nelle biblioteche e non amano partecipare a convegni.
Se già questa sostanziale eterogeneità dei due ambiti consiglierebbe di riservare il termine ricerca alle scienze naturali, anche altri argomenti suggeriscono di restituire le scienze umane a quello studio che le ha caratterizzate per secoli. A differenza del termine “ricerca”, che rimanda a un girare in circolo senza ancora aver trovato il proprio oggetto (circare), lo studio, che significa etimologicamente il grado estremo di un desiderio (studium), ha sempre già trovato il suo oggetto. Nelle scienze umane, la ricerca è solo una fase temporanea dello studio, che cessa una volta identificato il suo oggetto. Lo studio è, invece, una condizione permanente. Si può, anzi, definire studio il punto in cui un desiderio di conoscenza raggiunge la sua massima intensità e diventa una forma di vita: la vita dello studente – meglio, dello studioso. Per questo – al contrario di quanto implicito nella terminologia accademica, in cui lo studente è un grado più basso rispetto al ricercatore – lo studio è un paradigma conoscitivo gerarchicamente superiore alla ricerca, nel senso che questa non può raggiungere il suo scopo se non è animata da un desiderio e, una volta raggiuntolo, non può che convivere studiosamente con esso, trasformarsi in studio.
Si può obiettare a queste considerazioni che mentre la ricerca ha sempre di mira una utilità concreta, non si può dire lo stesso dello studio, che, in quanto rappresenta una condizione permanente e quasi una forma di vita, può difficilmente rivendicare un’utilità immediata. Occorre qui rovesciare il luogo comune secondo cui tutte le attività umane sono definite dalla loro utilità. In forza di questo principio, le cose più evidentemente superflue vengono oggi iscritte in un paradigma utilitaristico, ricodificando come bisogni attività umane che sono sempre state fatte soltanto per puro diletto. Dovrebbe essere chiaro, infatti, che in una società dominata dall’utilità, proprio le cose inutili diventano un bene da salvaguardare. A questa categoria appartiene lo studio. La condizione studentesca è anzi per molti la sola occasione di fare l’esperienza oggi sempre più rara di una vita sottratta a scopi utilitari. Per questo la trasformazione delle facoltà umanistiche in scuole professionali è, per gli studenti, insieme un inganno e uno scempio: un inganno, perché non esiste né può esistere una professione che corrisponda allo studio (e tale non è certamente la sempre più rarefatta e screditata didattica); uno scempio, perché priva gli studenti di ciò che costituiva il senso più proprio della loro condizione, lasciando che, ancor prima di essere catturati nel mercato del lavoro, vita e pensiero, uniti nello studio, si separino per essi irrevocabilmente.
15 maggio 2017
(da www.quodlibet.it)
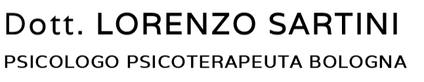
 Feed RSS
Feed RSS
