
a cura di Paola Scalari e Francesco Berto
Un insieme di persone non necessariamente può dirsi gruppo. Per definirsi tale occorrono presupposti ben precisi che attengono al compito, alle finalità e alle dinamiche. Lavorare in gruppo modifica gli equilibri dei saperi e dei comportamenti, richiede un cambiamento continuo (di punti di vista, di idee, di visioni, di relazioni) e, dunque, la capacità di misurarsi con la resistenza al cambiamento, la capacità di padroneggiare e conoscere le dinamiche che nel gruppo si generano (e a volte si scatenano).
Non è sempre facile discriminare ciò che fa parte della quotidianità della nostra vita. Poiché quello che ci circonda diventa quasi invisibile, è complesso prenderlo in considerazione, interrogarlo, osservarne e riguardarne il significato.
Così è per il gruppo. Tutti viviamo in una dimensione collettiva. Essa fa parte del nostro incontrarci, a tal punto che osservarla disturba le nostre abitudini.
L’occasione per approfondire quali competenze necessitano per lavorare con i gruppi è data da questa intervista ad Armando Bauleo, psichiatra e psicoanalista argentino, fondatore della concezione del gruppo operativo. Dalla fine degli anni Ottanta risiede in Italia seppur la sua dimensione di lavoro sia rimasta a cavallo tra l’America Latina e l’Europa permettendo continui e fecondanti intrecci di pensiero non solo tra realtà sociali diverse, ma anche tra molteplici apporti filosofici, politici, oltre che psicologici, che sostengono il suo continuo e incessante fermento di idee. Sempre attento a cogliere i nuovi problemi emergenti, oggi si sta dedicando in modo particolare al mondo della tossicodipendenza, allo sviluppo dell’interculturalità e alla promozione della crescita dei bambini e degli adolescenti.
Domanda. Lavorare in gruppo è una proposta semplice che molti professionisti fanno sia per affrontare le problematiche con gli utenti sia per confrontarsi tra di loro. Le dinamiche che compaiono all’interno del gruppo però diventano spesso difficili da gestire. Esiste allora una specifica competenza per poter portare un gruppo a sviluppare l’intento per cui si è costituito?
Risposta. Quando si parla di gruppo tutti pensano di sapere cos’è. Questo fa sì che molti professionisti anche senza avere in mente un solo concetto sul gruppo, senza cioè aver studiato nulla a tal proposito, si mettano a lavorare con dei gruppi. Si crede cioè, con grande faciloneria, che chiunque sia autorizzato a proporre un’esperienza di gruppo. Viene allora da chiedersi: come mai se lo permettono? Come mai in questo ambito diventa possibile legittimarsi a fare una cosa che non si conosce?
Nessuno pensa di fare il meccanico senza aver prima studiato cos’è un motore.
Molti invece propongono lavori di gruppo senza sapere nulla sulla teoria dei gruppi.
Penso che tanta disinvoltura ci sia perché ognuno ha sperimentato più volte cosa significhi vivere in un gruppo. Ogni essere umano, infatti, è nato in una famiglia e da lì è poi passato per diversi altri gruppi (quello degli amici, dei compagni, della scuola). Nella sua storia personale ciascuno passa quindi per diversificate dimensioni collettive. Questo però non vuol dire avere una teoria sulla dinamica del gruppo. Una cosa è essere vissuti dentro a un gruppo, altra cosa è invece avere un’idea di quali siano i suoi meccanismi.
Conoscere il gruppo
Per condurre un gruppo diventa dunque necessario avere un punto di riferimento teorico che aiuti a comprendere i motivi che determinano certi tipi di problemi al suo interno.
Senza un riferimento concettuale sui gruppi non si può dare significato ai diversi momenti che attraversano il processo gruppale, non si può cioè cogliere, ad esempio, il perché in un certa fase il gruppo si paralizza o il perché in un’altra fase si delineano in esso sentimenti di panico. Senza una conoscenza teorica inoltre non è nemmeno possibile prefigurare quando e per quali ragioni un gruppo può esplodere. Ed infine, senza punti di riferimento per osservare e per capire come si sviluppa la finalità del gruppo, non si può nemmeno proporre un percorso. Il processo di un gruppo trova perciò uno specifico supporto solo attraverso uno schema di riferimento teorico.
Il soggetto che ha vissuto l’esperienza dello stare in gruppo non padroneggia questi eventi, li conosce soltanto attraverso i suoi vissuti. Egli cioè sa cosa significa stare in gruppo, ma non sa prevederne le dinamiche, capirne gli emergenti e interpretarne i fenomeni.
A questo punto possiamo soffermarci su un dato molto interessante che ci fa rilevare come un’esperienza profonda possa avvicinarsi a una teoria; senza tuttavia mai esserlo, poiché ogni teoria ha una sua conformazione, ha cioè un’organizzazione interna dove i concetti si articolano attraverso differenti e precise modalità proprio per permettere a chi li padroneggia di poter operare.
Domanda. Il gruppo che hai delineato come strumento di lavoro è centrato sulla funzione del coordinatore. Quali competenze sono allora necessarie per coordinare un gruppo?
Risposta. C’è una diffusa confusione tra leader del gruppo e coordinatore di un gruppo. Una questione è infatti sapere come si comanda un insieme di persone, come si possono ordinare e organizzare degli individui partendo da ciò che essi dicono, cioè dal manifesto. Un’altra questione è invece sapere coordinare un gruppo leggendo il significato latente dei conflitti che si sviluppano tra gli individui.
Leggere il latente significa, per esempio, sapere tener conto che, alle volte, una discussione tra due soggetti veicola un problema emotivo che attraversa tutto il gruppo. Ogni interpretazione deve quindi decodificare che cosa porti i membri a comportarsi, a dire e ad agire in un determinato modo. Tale significato però deve poi essere riportato a ciò che sta vivendo tutto il gruppo.
Ogni gruppo sviluppa allora due piani: un piano manifesto e un piano latente.
Il manifesto è quello che possiamo vedere, sentire, ascoltare, palpare e anche odorare (ci sono pure gruppi odorosi), mentre il piano latente è quello che potremmo paragonare a un canovaccio teatrale che va organizzandosi all’insaputa dei soggetti stessi.
In ogni gruppo si sviluppa allora una trama narrativa fatta da sentimenti, vissuti e argomenti invisibili. Questi, nel loro insieme, costituiscono una specie di opera teatrale che prende forma attraverso le parole, i gesti e le emozioni che attraversano il gruppo. Nessuno conosce prima questa rappresentazione poiché viene messa in scena nell’hic et nunc. È compito del coordinatore svelarla e renderla visibile anche al gruppo.
Il lavoro del coordinatore è allora quello di mostrare la parte latente, ossia di rendere visibile l’opera teatrale che il gruppo sta «rappresentando». Egli, per dare parola al tema rappresentato, deve mantenere quella distanza ottimale che gli impedisce di immedesimarsi sia con il gruppo sia con la trama dell’opera che i «personaggi» stanno mettendo in scena. Ed è solamente da questa sua specifica posizione che il coordinatore può vedere l’argomento che il gruppo sta sviluppando. Se egli infatti va troppo vicino al gruppo o se si mantiene eccessivamente lontano dallo sviluppo narrativo perde la possibilità di vedere la trama. Ci vuole quindi molta flessibilità mentale per trovare continuamente la «giusta distanza» che non è né l’andare troppo dentro né lo stare troppo fuori dal gruppo.
Il coordinatore è colui che svela l’argomento dell’opera, mentre il leader è invece colui che la organizza come gli piace o come pensa sarebbe utile.
Il coordinatore non conosce l’opera e deve quindi scoprirla per rivelarla al gruppo che la sta interpretando.
Il leader invece ha una sua idea di come deve svilupparsi l’opera e deve condurre il gruppo a realizzarla. Ritiene quindi di sapere qual è il modo migliore di procedere per tutti: quello a cui mira è infatti il riuscire ad avere il loro consenso.
Il leader è parte della struttura di un gruppo, pertanto questa posizione non è mai assunta dal coordinatore.
Cosa definisce un gruppo
Domanda. Per sviluppare una sua originale trama affettiva ed emotiva il gruppo ha bisogno che siano sempre presenti i tre vertici costituiti dal coordinatore, dal compito e dal gruppo stesso?
Risposta. Una situazione gruppale è sempre triangolare poiché ci sono sempre un insieme di persone, un compito e un coordinatore ed è sempre così anche se, apparentemente, può mancare un vertice del triangolo.
Ci sono momenti in cui può mancare l’insieme di persone. Penso, infatti, al colloquio individuale. In un colloquio con un’unica persona si può scoprire ben presto che, anche in questa occasione, il soggetto sta portando in scena un suo gruppo. Si tratta del suo gruppo interno con tutti i personaggi e tutti i diversi ruoli da essi ricoperti. La persona, infatti, racconta di come era sua madre, suo padre, di come vive i suoi amici, i suoi colleghi, eccetera... Ecco quindi che un insieme di persone prende forma attraverso la visione che ne ha il soggetto. Anche durante un colloquio individuale, allora, è ugualmente presente una situazione triangolare, pur non essendo visibile poiché l’insieme dei soggetti che entrano nella stanza di consultazione è rappresentato dal gruppo interno messo in scena dalla persona venuta all’incontro.
Ci sono pure situazioni nelle quali sembra che nel gruppo manchi un compito comune. Nelle équipe questa sensazione l’ho vissuta ripetutamente. Il gruppo di lavoro alla domanda «Voi che cosa fate?» scopre di aver dato per scontato e risaputo il compito e trovandosi a doverlo esplicitare non lo sa definire.
Ciascun componente ha in mente una sua personale finalità che spesso è diversa da quella di ogni altro collega e si evidenzia quindi un gruppo che sembra lavori senza compito. Questo però non significa che a quella determinata équipe non sia stato assegnato un compito comune.
Ci sono, infine, occasioni nelle quali può mancare il coordinatore. Penso al famoso gruppo di autogestione portato avanti tempo fa soprattutto dagli anarchici. Qui il coordinatore entra dentro alla struttura gruppale. I membri, come fratelli, giocano infatti tra loro il ruolo di coordinatore. È come se i soggetti si fossero mangiati il coordinatore e ognuno l’avesse «digerito», mettendolo poi in gioco in accordo con i bisogni del gruppo e la capacità di ognuno dei suoi partecipanti di interpretarli. Sono cioè i membri del gruppo che coordinano la situazione assumendo, in conformità alle peculiarità personali, una delle funzioni del coordinatore. A questo punto il soggetto più organizzatore dirà una certa cosa e quello più affettivo ne dirà un’altra. Anche nel gruppo autogestito allora c’è una coordinazione. È presente però in modo implicito in quanto apparentemente, poiché tutti i partecipanti svolgono una parte di questa funzione, sembra che nessuno rivesta in modo esplicito il ruolo di coordinatore.
Domanda. Nei gruppi di lavoro compaiono spesso tensioni insolubili che portano a rifugiarsi nelle acquisizioni di sterili tecnicismi o di scisse competenze. Come si possono aiutare gli operatori a superare queste difficoltà?
Risposta. Quando inizia un’esperienza di formazione, di apprendimento, di lavoro clinico o di altro ancora ogni membro del gruppo ha una propria idea sulla finalità dell’esperienza che si appresta a vivere. Ed è proprio su questa sua personale raffigurazione che il singolo ha stabilito un contratto, accettando di riunirsi con altri per un numero predefinito di giorni e di ore, oltre che per uno scopo.
Quando inizia la prima riunione, allora, inizia anche un confronto tra i diversi soggetti e ognuno mette in gioco l’idea che si era fatto a casa di come dovesse essere quell’esperienza. Quest’idea primitiva del singolo si scontra con l’idea primitiva degli altri ed è a partire da questo scontro-confronto che comincia la dinamica di gruppo. Il momento iniziale del gruppo, quindi, è sempre un momento difficile proprio perché ognuno rimane un po’ confuso e sbalordito nello scoprire le idee che un altro soggetto ha della stessa finalità.
È in questi frangenti che diviene essenziale per il coordinatore avere una teoria che gli permetta di capire e di sopportare che c’è una fase di confusione, ma che questa è necessaria all’interno della dinamica gruppale. È a partire da questo punto di riferimento che il coordinatore non tende immediatamente a trovare una soluzione alle difficoltà che appaiono e non opera quindi per tranquillizzare il gruppo, ma si pone invece proprio nella posizione di poter capire quello che succede.
Egli infatti sa che la confusione è parte dell’apprendimento e sa anche che non lo può mai dimenticare se non vuole correre il rischio di omogeneizzare il gruppo. Per il coordinatore mantenere le differenze significa allora sapere che sono proprio le diversità che rendono dinamico un gruppo.
Mi vengono alla mente molte équipe che evitano gli incontri di lavoro per evitare la confusione e operatori che scappano, si assentano, disertano le riunioni poiché non capiscono come mai non ci siano idee chiare.
Chi accetta di vivere il confronto con gli altri deve inevitabilmente passare attraverso momenti di dubbio e fasi di indecisione. Voglio inoltre sottolineare che chi non ha dubbi è sicuramente più patologico di chi invece i dubbi li ha.
Non tutti però possono sopportare tranquillamente la confusione e l’ansia che essa produce. Stare nella confusione, con l’angoscia che deriva dal perdere un certo tipo di indirizzo, significa allora perdere sicurezze e certezze, significa cioè non essere capaci di far fronte a questo stato d’animo senza sentirsi andare a pezzi.
In un processo gruppale, quindi, c’è sempre un momento di incertezza che bisogna sopportare poiché la rottura degli schemi di riferimento precedenti non viene immediatamente sostituita con un altro schema di riferimento. Un’idea cioè non viene sostituita subito con un’altra!
Se ogni soggetto non fa un grande lavoro psichico, che comporta l’articolazione tra le proprie idee e quelle dell’altro, non arriva mai all’integrazione tra i diversi punti di vista. Ed è proprio questa integrazione il vero cambiamento prodotto dal lavoro gruppale. Diversamente sarebbe solo accettare un’altra idea.
Punto e basta. Ma non è in questo modo che l’esperienza gruppale favorisce processi trasformativi. Trasformarsi significa arrivare con le proprie idee primitive e integrarle con quelle degli altri per uscire dall’incontro con un diverso sapere che non è né il proprio né quello dell’altro. Trasformarsi significa stare in situazioni che non si riesce subito a capire dove portino e a quale nuovo sapere facciano approdare. Trasformarsi significa, allora, per ciascun partecipante, lasciare le proprie idee per ricercarne di nuove. E sottolineo ancora una volta che questo deve avvenire per tutti, senza che nessuno assuma il ruolo di quello che dispensa nuove idee.
Il processo gruppale parte quindi dall’io, passa per il noi, per riapprodare poi all’io. È un processo che integra idee che molte volte sono contraddittorie e che ognuno deve elaborare dentro di sé proprio nella loro contraddittorietà.
Il problema che deve affrontare ogni gruppo è il cambiamento del sapere di ciascun componente e non l’acquisizione di un sapere altrui al posto del proprio. Per raggiungere questo obiettivo ogni soggetto deve rompere i propri stereotipi, le proprie fissità e ripetitività. Il gruppo produce così nuove conoscenze in quanto ogni membro modifica aspettative, comportamenti e pensieri.
Nessuno rimane uguale a come era prima dell’esperienza e questo rimettersi in gioco di tutti dà alla luce idee che non erano mai state precedentemente pensate.
Nel percorso «io-noi-io» è quindi molto importante che vi sia un coordinatore perché può aiutare i soggetti a sopportare l’ansia che deriva dalla confusione che insorge durante il processo di cambiamento. Ogni individuo arriva al gruppo con le sue posizioni e, per non dover sperimentare il dolore che comporta il processo di trasformazione di sé, le vorrebbe sentire confermate. Il coordinatore fa in modo che l’angoscia non blocchi la rottura delle certezze stereotipate.
Nel passaggio dall’io al noi, allora, c’è sempre in agguato il desiderio soggettivo di arroccarsi in posizioni sicure. Ogni individuo mette in gioco il bisogno di difendere le proprie posizioni, idee, sicurezze e acquisizioni.
Il coordinatore però garantisce l’acquisizione di un noi poiché rende possibile a tutti d’imparare, anche se questo li destabilizza, e di tollerare, quindi di mescolarsi con gli altri.
Il percorso è questo: io vado al gruppo con una struttura determinata e con una potenzialità affettiva personale. Passo poi per questa esperienza di integrazione con gli altri, transito cioè per il noi. Alla fine recupero il mio io che però è diverso da quello che è entrato nel gruppo.
Quella del gruppo coordinato è allora un’esperienza di cambiamento. Il passaggio per i gruppi arricchisce il proprio io.
Mi viene in mente l’immagine di un vecchio che racconta di sé. Non c’è dubbio che l’anziano quando narra la sua vita non parla solo di se stesso, ma anche di quella sua esperienza passata connotata da tanti incontri con persone che hanno segnato, modificato, colorato e trasformato la sua storia.
Penso pure a come un medico, uno psicologo, un assistente sociale, passando per un gruppo, modifichino inevitabilmente la loro professionalità poiché ne usciranno diversi.
Questo cambiamento, si guardi bene, non è né automatico né semplice. Al processo integrativo del gruppo, infatti, si oppongono a volte non solo le resistenze dell’io, ma anche le resistenze delle università, dei colleghi, delle associazioni, della società. Sono proprio queste appartenenze istituzionali che possono rinforzare le resistenze alla modifica di saperi e comportamenti.
A volte l’io professionale ha una corazza costruita all’uopo dagli ordini di appartenenza e messa lì proprio per non favorire un lavoro di équipe.
È dunque importante che l’io professionale non sia così tanto stereotipato e fisso da rendere impossibile il passaggio al noi. Che questo io sia passato o meno per un gruppo non cambia nulla, anzi rinforza lo stereotipo che gli consente di continuare a essere, anche dopo l’esperienza gruppale, quello che era prima. Si potranno allora riunire persone di diversa professionalità e ognuna dirà la propria opinione; ma questa è un’altra cosa rispetto al fatto che un’équipe risponda come tale a una certa problematica. Per arrivare a questo obiettivo infatti il gruppo, a partire dall’indiscriminazione primitiva e dalle differenze professionali, deve trovare un codice in comune capace di organizzare un comportamento organico intorno a un compito determinato. Solo così si stabilisce una strategia condivisa di lavoro (sia esso terapeutico, preventivo o di formazione).
Il gruppo di lavoro deve allora attraversare un processo di differenziazione e di discriminazione, ma anche di coesione. La coesione è rappresentata dal fatto che ciascuno ha in testa la rappresentazione degli altri ed è questa conoscenza che, al momento di agire, lo rende capace di pensare a cosa farebbero questi altri se si trovassero nella sua stessa situazione.
Mi riferisco a quando devo prendere una decisione e provo ad immaginare cosa farebbe un altro al posto mio. Avere una rappresentazione interna significa allora che io mi muovo con questo gruppo che mi accompagna.
Per avere però questa rappresentazione, ossia questo gruppo interno, è necessario un lavoro gruppale che conduca ciascun componente a passare dal punto in cui ogni soggetto conosce un insieme di persone al punto nel quale questi individui non sono da lui conosciuti solo esternamente, ma diventano personaggi che appartengono al suo mondo interno ed è da questa collocazione che discutono con lui. Questo passaggio è difficile; se fosse facile non sarebbe necessaria una teoria sui gruppi. Se si trattasse solo di mettere insieme delle idee non sarebbe necessaria nessuna nozione teorica per sostenere tale processo. Ed è proprio questo il punto di vista della «sociologia delle organizzazioni» che, pur considerando i gruppi, spesso non ha un pensiero sulle dinamiche gruppali!
Il percorso gruppale riguarda il dare così tanta dignità all’altro che certe volte mi arrabbio con lui dicendo tra me e me: ma perché si comporta in modo tale che io non ne capisco il motivo?
Ho preso a modello l’équipe di lavoro, ma possiamo pensare alle stesse dinamiche con un gruppo di adolescenti, con le classi a scuola o anche con le famiglie.
Questo passaggio dall’io al noi per tornare all’io con un gruppo interno con il quale interloquire, dialogare e confrontarsi avviene in ogni gruppo che passa attraverso un’esperienza di gruppo coordinato.
Lo schema di riferimento gruppale
Domanda. Ci sembra di capire che adoperi la parola «aggregazione» per definire un insieme di persone e la parola «gruppo» per definire invece un collettivo. Eppure nel linguaggio comune si dice «Lavoro con un gruppo di ragazzini, lavoro con un gruppo di adulti, lavoro con un gruppo di famiglie, lavoro con un gruppo di genitori...». Nella lingua italiana infatti si usa la parola «gruppo» quando si mettono insieme delle persone, mentre secondo te c’è una precisa differenza tra incontrare più persone e avere di fronte un gruppo. Manca una distinzione linguistica?
Risposta. Non è per una mancanza linguistica, bensì per la mancanza di un coordinatore fornito di una teoria. È infatti lo schema di riferimento teorico che consente al coordinatore, mentre accompagna un insieme di persone a divenire gruppo, di sopportare le diverse circostanze cariche di tensione senza entrare egli stesso in uno stato di angoscia e di ansietà.
La funzione della teoria, in questo caso, non è solo quella di far capire al coordinatore cosa sta succedendo, ma rappresenta anche una difesa che gli evita di essere investito dall’angoscia del gruppo e di cadere perciò in uno stato confusionale.
Il coordinatore, appunto perché supportato dall’apparato teorico, può riconoscere gli affetti messi in moto dal processo di comunicazione delle diverse idee primitive con le quali i soggetti sono venuti al gruppo. La funzione del coordinatore è allora quella di trasformare un’aggregazione di persone in un gruppo. Queste persone infatti, se il coordinatore sa mantenere lo sviluppo della dinamica, non usciranno dall’esperienza uguali a prima; se invece non la sa mantenere rimarranno tutte con l’idea primitiva con la quale erano arrivate poiché non l’hanno potuta interscambiare con quella degli altri e trasformarla. In questo modo il loro stare assieme rimane un’aggregazione di individui che non diventano mai un gruppo.
Nelle équipe dei servizi i soggetti rimangono spesso un’aggregazione proprio perché realizzano solamente una maniera multiprofessionale di lavorare. Non diventeranno mai un gruppo di lavoro, ma saranno solo un insieme di persone che rimangono sempre uguali a se stesse.
Verrebbe a questo punto da domandarsi: come mai si promuovono così tanti gruppi se poi non si persegue l’idea di utilizzare questo dispositivo come luogo della trasformazione?
Torna di nuovo il problema di fornire al coordinatore uno schema di riferimento concettuale. È il coordinatore che permette l’inizio di un’interazione tra le varie persone che si riuniscono poiché sa che ogni comunicazione va collegata con uno stato affettivo (pensiamo a quando i partecipanti sono arrabbiati, magari senza saperne il perché!). Se all’interno del gruppo, infatti, emergono situazioni troppo affettive e troppo cariche emotivamente, egli sa come dare senso a queste emozioni poiché pensa al ruolo che possono giocare nello sviluppo del processo gruppale. Attenzione, però, che dare un senso a queste emozioni non significa razionalizzarle!
I gruppi ci hanno insegnato giustamente che c’è un passaggio tra affetto e pensiero, e che molte volte gli affetti rappresentano proprio una maniera di pensare.
Giacomo Leopardi è stato uno dei primi a porsi su questa strada. Faccio ricorso a Leopardi per non nominare sempre psicoanalisti come Freud e Bion e per far notare come la letteratura abbia già messo in gioco queste problematiche.
Leopardi è stato uno dei primi poeti della letteratura italiana a dimostrare, attraverso la poesia, come si possono esprimere un certo tipo di manifestazioni dell’essere. La sua poesia si avvicina infatti al pensiero inconscio di Freud e al pensiero mutativo di Bion quando questi due autori parlano della possibilità di trasformare l’emozione in concetto.
Pensiamo al controtransfert. Sono proprio i sentimenti, le emozioni e i vissuti che il soggetto prova che gli permettono di conoscere quello che sta sentendo, vivendo, sperimentando un’altra persona. Come diceva Paula Heimann in un suo famoso articolo: «il sentimento che ho sofferto mi ha permesso di arrivare al conflitto dell’altro prima che io lo potessi pensare».
Gli affetti dunque sono anche conoscenze proprio perché ci consentono di apprendere sia sull’altro sia su noi stessi.
Questa possibilità di trasformare le emozioni in concetti emerge quando la gente sta insieme per lavorare su un compito. Il gruppo diventa sì l’occasione per raggiungere una conoscenza intellettiva quale potenziamento dei pensieri, ma diventa soprattutto l’occasione per immergersi in un’esperienza che stimola emotivamente.
L’individuo si sente altamente pungolato e spronato quando sta in un gruppo perché entra in gioco la rappresentazione della famiglia. Questo fantasma gli viene immediatamente addosso. Solo successivamente saranno anche altre cose quelle che verranno messe in gioco, ma all’inizio c’è un vissuto che risuona, più o meno, in questi termini: «Quelli che ho davanti sono o non sono fratelli?
Sono uguali a me o sono diversi da me? Chissà cosa pensa quello? Quell’altro... che sia un po’ stupido? E l’altro ancora non cerca forse di essere migliore di me?». Il clima familiare si è così acceso.
Questo rientrare in campo della situazione familiare determina appunto la particolarità e la singolarità dell’esperienza gruppale.
Domanda. I coordinatori si scontrano spesso con aspettative già codificate che fanno dichiarare ai partecipanti, quando siamo sul versante comunitario, che quello non è un luogo terapeutico e, quando siamo invece sul versante clinico, che quello non è uno spazio per l’apprendimento. Il modo in cui tu pensi i gruppi è un modello che funziona sia che si lavori per andare a vedere cosa c’è bisogno di fare nella comunità sia che si lavori per apprendere delle nozioni, sia che si lavori in un gruppo clinico sia che si lavori in una équipe?
Risposta. Ricordatevi sempre che i membri di un gruppo non definiscono il gruppo. Il gruppo è definito dal suo compito.
Voglio dire che se mi parlate di un gruppo di preadolescenti non mi comunicate nulla se non mi dite prima qual è il compito per il quale questi ragazzi si incontrano. Può essere che si riuniscano per apprendere, per formarsi, per riabilitarsi, per lavorare insieme, per ricrearsi, per giocare.
Un gruppo, per esistere, deve avere sempre un compito perché è il compito che lo determina!
Due gruppi composti dagli stessi adolescenti possono essere profondamente diversi perché, ad esempio, uno può essere terapeutico e l’altro di formazione.
È il compito che determina la loro diversità. Se è diverso il compito, infatti, è diverso anche il comportamento delle stesse persone dentro al gruppo.
Se non vogliamo generalizzare dobbiamo allora definire sempre il contesto, il compito, la finalità.
Io posso riunire un gruppo di gente e dire che facciamo sei riunioni per vedere su che cosa possiamo lavorare insieme. Il gruppo, in questo caso, ha come compito di «trovare il compito» per lavorare insieme. Il non-compito diviene dunque il compito. Si cerca insieme una finalità, ci si riunisce cioè per trovare l’argomento su cui lavorare assieme. Questi incontri possono anche non portare a nulla, cioè si può non trovare un compito su cui lavorare insieme, ma nonostante tutto, si vive ugualmente un’esperienza di gruppo.
Quante volte si dice: «Ti ricordi quel gruppo? È fallito miseramente. Ma quanto ho imparato!».
Per lavorare in gruppo c’è bisogno di un tempo e di uno spazio per operare, non soltanto di un compito. Ecco, allora, che è necessario strutturare un tempo per il gruppo e anche un tempo per permettere a ciascuno di tornare alla propria dimensione individuale.
L’obiettivo dell’esperienza di gruppo è di aiutare i soggetti a stare da soli.
Il setting serve poiché ciascuno, avendo uno speciale lavoro psichico da fare, deve avere anche garantito un momento di silenzio e di tranquillità nel quale ogni individuo, dopo aver trascorso il tempo convenuto insieme ad altri, può usufruire di uno spazio per ripensare e risentire le cose che sono successe. È inoltre utile anche assicurare a ogni soggetto un tempo in cui far riposare il pensiero dopo tanto impegno mentale.
È importante, per esempio, che i bambini facciano esperienze di gruppo, ma in realtà, come ci ricorda Donald Winnicot, devono imparare a stare e a giocare da soli. E siccome sappiamo che nel piccolo il pensiero passa attraverso il gioco, sappiamo quindi che ha bisogno di aver garantito anche il gioco solitario.
Tutti noi però, non solo i bambini, abbiamo bisogno di essere soli per poter «giocare» con il nostro gruppo interno. Non possiamo rapportarci continuamente solo con gruppi esterni. Il gruppo interno è come noi: attraverso tutti i rapporti che abbiamo con i gruppi, interiorizziamo a poco a poco quelli che più ci toccano, quelli con cui sentiamo di poterci maggiormente identificare, quelli che più empaticamente sollecitano i nostri affetti e quelli che ci hanno dato e continuano a darci importanti conoscenze.
Attraverso l’esperienza gruppale andiamo allora configurando un gruppo interno rappresentato dal ricordo di una serie di personaggi con le loro frasi, le loro immagini e i loro sentimenti. Quella che ci portiamo dentro non è però una fotografia, bensì una scena viva fatta di emozioni. Questi personaggi interni vengono riattivati quando siamo soli, ma ritornano in scena anche quando iniziamo un nuovo gruppo. Quando si comincia un gruppo, cioè, rientrano sempre in gioco i tanti gruppi precedenti che ognuno porta dentro di sé.
Il gruppo come strumento
Domanda. Offrire alle persone un gruppo significa avvicinarle con uno strumento facilmente accettabile perché incontrarsi fa parte del vivere comune. A volte però il gruppo viene banalizzato fino al punto da essere utilizzato senza alcuna attenzione a cosa succede incontrandosi. Dove si colloca allora il malinteso che porta a considerare la proposta del gruppo sia come un’offerta altamente professionale sia come uno strumento utilizzabile da tutti?
Risposta. Il gruppo è uno strumento con il quale si può lavorare sulla vita quotidiana.
Abbiamo cominciato dicendo che la gente è sempre stata in gruppo e che la sua vita si articola tra diverse esperienze collettive. Gli operatori quindi utilizzano facilmente il gruppo proprio perché fa parte del vivere quotidiano.
Abbiamo però già potuto constatare che gli individui, inevitabilmente, hanno molteplici esperienze di vita collettiva e credono perciò di possedere anche la conoscenza sulla teoria dei gruppi. Questa convinzione ha portato però a una confusione. La stessa confusione che si fa spesso tra il vivere una situazione e l’avere una teoria su quella problematica.
Affrontare un problema economico, per esempio, non equivale certamente ad avere una teoria sull’economia! Un altro esempio è che in Argentina, come del resto in Italia, chi ha giocato al calcio (e tutti lo hanno fatto da piccoli) pensa di essere in grado di allenare una squadra. Non sa evidentemente che una cosa è aver giocato al calcio e un’altra è avere invece una teoria su questo gioco, fatta di conoscenze tecniche e di strategie.
Allora, gli operatori che lavorano sul quotidiano credono di sapere già tutto e rischiano pertanto di operare trattando in maniera volgare, banale e superficiale questo modo di intervenire. Lavorare sul quotidiano invece è un mezzo che, pur partendo dalle cose più ovvie, permette di andare in profondità.
Utilizzando il gruppo come articolatore della vita di ogni giorno si usa in realtà uno strumento altamente sofisticato. Il gruppo consente infatti di rovesciare le cose comuni della vita quotidiana tramutandole in possibilità di profondi cambiamenti. Affinché questo avvenga è necessario però saper lavorare con le resistenze al cambiamento. E il cambiamento inizia proprio lì dove comincia la resistenza.
Quando, per esempio, inviti una famiglia che poi non si presenta, osservi la resistenza ed è di questa che un operatore deve occuparsi.
In tutto questo discorso, che colloca l’intervento nella vita normale delle persone, ma che, per incidervi, si equipaggia di uno strumento molto particolare qual è la concezione di gruppo, dobbiamo riflettere su come ciò che motiva questo tipo di proposte sia proprio il cambiamento dei soggetti che sono chiamati a vivere l’esperienza.
Il concetto di cambiamento è centrale per sostenere il senso dell’offerta di una opportunità di incontro. Porsi l’obiettivo di trasformare i soggetti significa perciò doversi scontrare con il problema della loro resistenza al cambiamento.
L’evoluzione degli individui che partecipano a un gruppo non rappresenta quindi il vero punto di vista con cui operare poiché ciò che bisogna saper comprendere riguarda invece proprio le loro resistenze al cambiamento. È un problema che si ha spesso con le famiglie.
Noi non possiamo determinare come sarà il cambiamento perché è impossibile prevedere il futuro. Il cambiamento può essere intellettivo, affettivo, comportamentale, di progetti, di vita... Il cambiamento non si può mai definire prima che avvenga, però si può definire la resistenza al cambiamento, ossia l’impossibilità di mettersi in condizione di modificare qualcuno dei nostri aspetti, atteggiamenti, azioni, pensieri, sentimenti. È così che si lavora sulla resistenza al cambiamento. Dopo, la trasformazione viene da sé.
I cambiamenti molte volte avvengono dopo mesi, non sono sempre immediati. Anche se ci sono effetti subito riscontrabili, alcune modificazioni possono comparire solo successivamente.
La burocrazia è il miglior esempio di resistenza al cambiamento. Il tempo passa e le cose non cambiano. La burocrazia è la difesa collettiva che nega il passare del tempo e con esso la morte. La temporaneità delle cose non esiste per la burocrazia. Merton ha evidenziato come si possa correlare la burocrazia con un tipo di comportamento patologico grave quale la nevrosi ossessiva.
Pure il gruppo, quindi, deve finire. Quello del portare a termine un’esperienza è un vecchio problema che si presenta anche in qualsiasi psicoterapia, psicoanalisi o nella formazione.
In realtà, la cosa che uno si aspetta è che il gruppo continui sempre. Potremmo dire che in effetti è proprio così. Il gruppo infatti continua per sempre, in quanto l’esperienza di incontro avvenuta in uno spazio-tempo determinato si costituisce nel mondo mentale del soggetto come gruppo interno che diviene perciò permanente.
Il coordinatore nel sancire la conclusione dell’esperienza sottolinea la fine formale del gruppo. I partecipanti imparano così che le cose iniziano e terminano. L’inquadramento indica lo spazio-tempo da usare in ogni seduta o in ogni riunione, ma serve anche per poter pensare a un momento d’inizio e a un momento di conclusione del processo dentro al quale deve avvenire un certo apprendimento.
Anche per il coordinatore, quindi, il momento conclusivo è una fase molto impegnativa. Egli infatti si è impegnato, ha sopportato l’angoscia del primo momento, la confusione, l’indiscriminazione, il fatto che tutti gli volessero bene o male... ed è per questo che sente la difficoltà di chiudere il legame. Il gruppo diviene un vincolo anche per lui malgrado la sua estraneità all’esperienza di gruppo.
Per il gruppo come per il coordinatore si stabilisce quindi un vincolo che per essere chiuso richiede l’elaborazione della perdita e la capacità di affrontare il lutto. E questa è una questione non facilmente accettabile perché implica sofferenza. È un vero e proprio dolore psichico. Quell’oggetto non ci sarà più.
Questa è la cosa difficile da accettare poiché capire che quell’oggetto non ci sarà più significa che anch’io non ci sarò più o non sarò più così importante per loro.
Penso che questo sia un problema del mondo contemporaneo, dove si gioca tutto sull’astoricità. Giocare sull’astoricità (che è anche il problema della burocrazia) vuol dire infatti giocare sull’inesistenza della perdita, giocare cioè sul non ricordo, sul non avere memoria della cosa. È chiaro però che il gruppo interno ha una memoria e non solo una memoria di fatti, ma anche di sentimenti e di pensieri.
Oggi purtroppo la memoria gioca sull’oblio; nella società si gioca solamente sull’effimero e non c’è pertanto mai profondità nel problema. Credo che ciò derivi dal fatto che si vive sulla superficialità e che sia proprio per questo motivo che molti non vogliono neanche sapere una teoria dei gruppi. Queste persone vogliono negare una temporalità che è diversa dal tempo che scorre.
Temporalità significa infatti avere in mente un processo interno. Ma oggi si vive come se non ci fossero processi interni poiché tutto è in superficie.
Domanda. Il discorso sullo schema di riferimento gruppale porta a chiedere: da dove viene questa «teoria dei gruppi operativi»? Perché è stata pensata così? Come si va avanti per approfondirne i concetti?
Risposta. Questa teoria ha origine in Argentina e viene avviata in un ospedale psichiatrico da Pichon Rivière nel reparto dove erano ricoverati degli adolescenti. È in questo luogo che si inizia a lavorare con i gruppi per la soluzione di problemi pratici. In un determinato momento infatti, Pichon si è visto obbligato a fare un gruppo operativo poiché, a causa di uno sciopero, rimane senza personale. Egli aveva letto che era possibile fare questi gruppi e quindi si è messo a farli.
Anche Bion ha avviato un’esperienza per affrontare i bisogni pratici dei traumatizzati di guerra. Aveva centinai di reduci da trattare. Che fare? La sua intuizione fu quella di fare dei gruppi.
Pichon e Bion partono quindi da una necessità pratica. Ed è proprio questa «pratica» che — grazie alla genialità dei due e alla loro capacità di ricerca, oltre che alla grande cultura personale di cui disponevano — porta alla modifica della psichiatria, della psicoanalisi e anche della medicina.
Questo pensiero, al quale io aderisco, deriva dunque da esperienze nelle quali medicina, psicoanalisi e sociologia interagiscono direttamente per ripensare a una situazione di insieme. È la necessità sociale che spinge a pensare alla situazione collettiva in un’altra maniera. Uno sente di dover risolvere al più presto una situazione collettiva. A partire da questo suo sentire e da questa sua urgenza pensa al gruppo. È a questo punto che inizia a interrogarsi su cosa sia un collettivo e su come funzioni un gruppo.
Ho nominato Pichon e Bion, ma un grande contributo alla teoria dei gruppi è dato anche da José Bleger.
Tutti noi cerchiamo di approfondire questa teoria che permette di capire il vivere collettivo. Approfondiamo questo studio perché ci serve per i diversi compiti che dobbiamo sviluppare: terapia, riabilitazione, prevenzione, formazione, insegnamento. Sono tutti compiti nei quali si lavora collettivamente.
Nel mio ultimo libro, "Psicoanalisi e gruppalità", ho cercato di affrontare nuovi temi, come l’immigrazione e la tossicodipendenza, che la società ci pone di fronte. Bisogna però ripensare anche alla prevenzione perché c’è un’idea diffusa, e per me tanto stupida, che si possa affrontare la prevenzione in termini individuali. È un’idea stupida perché la prevenzione ha sempre a che vedere con contesti e non con problemi individuali.
Pichon aveva l’idea dell’«uomo in situazione»: un essere umano non può essere pensato fuori dalla situazione nella quale abita e convive, non può essere pensato fuori del suo contesto culturale e sociale. L’idea di base consiste allora nell’aver pensato a un’epistemologia convergente. Spieghiamo questo concetto partendo dalla stessa pratica di Pichon. Egli, in un momento determinato, per risolvere un problema del suo servizio, vede che ha come risorse un medico, uno psichiatra, uno psicologo (che neanche aveva finito gli studi), quattro o cinque infermieri, un assistente sociale e tre pazienti già trattati. È con questi che organizza il primo gruppo operativo. Pichon afferma che ognuno di loro ha una conoscenza sulla malattia, compresi i pazienti perché l’hanno passata. La cosa interessante è come egli ha messo insieme il sapere di ogni soggetto per trovare una modalità per trattare la malattia mentale in quel momento. È così che hanno potuto individuare una strategia per aiutarsi tra loro.
L’epistemologia convergente, che oggi è considerata l’ultima novità, noi la conosciamo e pratichiamo dal 1948.
Nel servizio dove voi operate, i Centri età evolutiva, applicate un’epistemologia convergente. Mettete insieme infatti educatori, insegnanti, psicologi, assistenti sociali, laureati in diverse discipline. La cosa interessante è che adesso si comincia a capire, grazie a Morin, che cosa è un pensiero complesso. È la possibilità di utilizzare l’interazione del sapere e delle conoscenze per vedere la complessità senza bisogno di ridurla e semplificarla. Le persone hanno delle loro conoscenze. Troppo frequentemente si pensa che quel pensiero sia volgare invece che una personale conoscenza della quale bisogna approfittare. Pichon diceva che il grande problema del gruppo è come strumentalizzare i saperi o le conoscenze che sono all’interno del gruppo stesso, sia a livello conscio sia inconscio, sia a livello cognitivo sia affettivo. I soggetti, se sostenuti dalla coordinazione, possono infatti avviare processi di comunicazione che permettono di scoprire cose nuove. Si ribalta così l’idea che si deve andare a imparare di qua e di là saltando fuori dal proprio gruppo. Il vero compito è invece valutare quello che si sa e cominciare da lì a lavorare. Per fare questo bisogna però che ci sia il gruppo.
(da "Animazione sociale", maggio 2000)
Condividi:
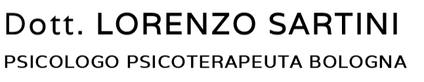
 Feed RSS
Feed RSS
