
1. PREMESSA
L’essere animale è qualcosa che ci riguarda in modo diretto, ma non nella veste di contro-termine da cui ricavare per esclusione la nostra condizione umana né come cifra regressiva, retaggio oscuro che in ogni momento può risalire dai fondali filogenetici per mettere a rischio la nostra umanità, bensì come fondamento stesso della nostra soggettività, del nostro essere affacciati al mondo attraverso la vitalità del desiderio. L’essere animale ha a che fare con il non-equilibrio, l’apertura referenziale che rigetta qualunque autarchia ontologica, la non esplicabilità in termini di fenomeno attraverso una ricognizione seppur puntuale ed esaustiva delle causalità agenti nel qui-e-ora. L’essere animale è una continua invenzione di presente, un andare oltre l’algoritmica delle cause, un trascendere il fenomeno attraverso l’emergenza epifanica, l’invenzione singolare dell’esistere.
La condizione animale è un continuo porre a sintesi “scansioni temporali” differenti e moventi altrettanto diversi, per cui il suo porsi nel momento, la sua presenza, si realizza nel non essere mai interamente compreso nell’istantaneità della funzione. Paradossalmente l’animale può dire di esserci, cioè di avere una presenza, perché non interamente spiegabile facendo riferimento a meccanismi causali agenti nell’istante in cui lo si considera. L’essere animale è pertanto un continuo desiderare, l’azione di un’infaticabile Penelope che mette in relazione cause prossime e cause remote, moventi filogenetici e moventi ontogenetici, motivazioni inerenti e opportunità contestuali, in un flusso diacronicorelazionale dove l’animalità si manifesta in questa presenza connettiva piuttosto che nella funzione in sé. Diciamo che l’animale è soggettivo perché sfugge all’oggettività delle cause agenti nell’istantaneità.
L’essere animale può manifestare un Dasein solo a patto di ammettere una titolarità espressiva e, di conseguenza, solo a patto di considerare l’individuo titolare delle proprie dotazioni: è lui che le utilizza e non sono loro che lo muovono.
Tuttavia, per fare questo, è indispensabile cambiare profondamente il modello esplicativo che da Cartesio in poi ha caratterizzato la spiegazione del comportamento animale. Come sappiamo, nell’idea cartesiana l’incapacità del modello isocrono e lineare della res extensa di spiegare il comportamento umano veniva compensata dalla controparte cogitans, principio trascendente che non richiedeva una spiegazione scientifica. È ovvio d’altro canto che in una visione materialistica l’elisione della gemella cogitans richiede un ripensamento epistemologico della res extensa, pena il dover ricorrere ad altri dualismi chiamati in soccorso di una spiegazione zoppicante. Nel momento in cui riconosciamo il principio darwiniano della continuità, non possiamo mantenere inalterato il paradigma metapredicativo del meccanicismo esplicativo. Dobbiamo cioè considerare le dotazioni filo-ontogenetiche, innate e apprese, non più come automatismi che muovono l’individuo - il burattino - ma come strumenti che lui utilizza. Dobbiamo tornare al desiderio come mastro di soggettività.
2. LA MACCHINA ANIMALE QUALE CONDIZIONE METAPREDICATIVA
La tradizione occidentale, informata sul modello cartesiano di animale come “automa” - ossia entità meccanica totalmente retta da cascate d’inneschi, destinati a produrre determinismi funzionali - ha dato luogo a una ricca tradizione di modelli degli uomini mortali, gli uccelli del cielo e tutte le specie animali, che la terra e il esplicativi, varianti spesso antagoniste o conflittuali tra loro, ma in realtà filiazioni del medesimo paradigma concettuale e perfettamente coerenti con i suoi presupposti epistemologici.
Tanto la psicoidraulica di tradizione europea quanto il chaining nordamericano, pur nel dibattito che li ha visti contrapposti nella prima metà del Novecento, non mettono in discussione il principio meccanicistico che esautora l’animale di qualunque soggettività espressiva. L’animalità viene letta come dimensione biomeccanica: poco importa se l’innesco sia pulsionale o reattivo, se l’automatismo sia informato dalla filogenesi o dall’ontogenesi. Spogliare l’animale del carattere di soggettività vuol dire metterlo alla mercé del caso e della necessità, sottrargli persino il barlume di una presenza che non sia il mero esercizio funzionale.
È con questa tradizione che ci si deve confrontare, indagandone i presupposti paradigmatici e non la semplice epidermide descrittiva, ogni volta che si desidera mettere a fuoco il significato dell’agibilità, ancor prima che della specifica azione, inerente all’essere animale. Qual è il campo d’azione di questa dimensione che vediamo interpretare il suo qui-e-ora con un protagonismo implicito e articolato, utilizzando le proprie dotazioni più che esserne agito?
Considerare la condizione animale in termini meccanicistici significa infatti non solo valutarne l’espressione secondo canoni retti da una molteplicità di fattori ontopoietici ed elicitativi - non necessariamente lineari nel loro svolgersi causale - ma soprattutto negare qualsivoglia forma di titolarità dell’essere animale sul proprio comportarsi.
La condizione animale non viene perciò interpretata come piena presenza nel mondo: l’animale non è libero, non sceglie, non è in grado di valutare, di prendere distanza dal magnete stimolativo-pulsionale, non decide ma semplicemente fruisce, seguendo meccaniche prefissate.
L’analisi evoluzionistica, basata sulla specializzazione adattativa, cui fa da contrafforte quella ecologica, attenta alle dinamiche di sostenibilità dei diversi biomi, ci mette di fronte a una pluralità di forme che rivelano precisi range di espressioni – le famose Umwelten del barone Jakob von Uexküll(1) o gli etogrammi di Niko Tinbergen(2) - ma, così facendo, distrarci dal problema paradigmatico: cosa significa essere animale? Analizziamo i coreogrammi delle varie specie, i processi di strutturazione dei diversi pattern, l’organizzazione gestaltica dei segnali-chiave, le molteplici immersioni della percezione, le plurali scansioni dei comportamenti alimentari, territoriali, parentali, sociali e via dicendo, arrivando persino a compilare articolati repertori di occorrenze culturali, di utilizzo di strumenti, di flessibilità espressiva, fino alle soglie della coscienza, ma senza andare a fondo sul presupposto di base e, di conseguenza, senza metterlo in discussione(3). Ripeto: cosa significa essere animali?
Secondo la tradizione, ogni specie non è altro che una forma, una particolare declinazione di questa meccanica paradigmatica, che rappresenta lo statuto di base dell’essere animale quale res-extensa, ossia entità misurabile e perciò trasformabile nella condizione astorico-necessitata di formula algebrica. La conseguenza è molto semplice: gli animali sono macchine – è il fondamento comune – e ogni specie ne è un particolare modello. Ecco allora che tutte le descrizioni ecologico-adattative altro non divengono che modi per descrivere la macchina animale, plurale come molteplici sono le funzioni richieste per dissipare l’energia nei diversi ambienti e nelle differenti posizioni lungo la catena trofica. Il principio cartesiano resta in sottofondo, ma ben saldo nel dettare le coordinate di traduzione esplicativa, qualunque sia la genealogia descrittiva pronta a enunciare un suo modello. La descrizione della macchina diventa un modo come un altro per non entrare nello specifico paradigmatico del problema o, meglio, per non mettere in discussione lo status quo esplicativo.
Il trucco del sottinteso paradigmatico o metapredicativo consente di spostare l’attenzione su altri dettagli e quindi di evitare di porsi il vero problema di cosa significhi essere animali alla luce del continuismo darwiniano: 1) ci si limita all’analisi predicativa – i famosi quattro perché dell’esplicazione etologica di Tinbergen – spostando la discussione dall’animalità, come condizione, al repertorio adattativo ed evolutivo specie specifico; 2) ci si sofferma sui caratteri generali della macchina, se chimica o termodinamica, se cibernetica o informatica, spostando la spiegazione sulle configurazioni energetico-funzionali e non sul paradigma esplicativo di fondo. Si tratta di un trucco o di una rimozione che consente di assumere Darwin come prodotto topico, senza cioè farlo interagire con la sistemica dell’organismo culturale umanistico. Fuorviati dall’attenzione sui caratteri descrittivi - l’etogramma del cane oppure del gatto - o dalle spiegazioni funzionali, vale a dire se ha ragione Lorenz con la sua teoria psicoenergetica(4) o Skinner con la sua cibernetica(5), ci scordiamo del non-detto cartesiano che può continuare a dettar legge sul principio ontologico di base.
Questo aspetto era stato ben compreso da Martin Heidegger(6) allorché si rese conto che la spiegazione predicativa, ancora in voga tra i veteroumanisti affascinati dalla plasticità del vitruviano, non era il nodo della questione, perché, tra l’essere umano e l’alterità animale, la differenza andava posta in termini ontologici ossia metapredicativi.
L’animale macchina può esercitare delle azioni, prendere parte a delle funzioni, essere compreso in un lasso temporale, ma se/finché resterà macchina: non potrà essere veramente presente, perché una macchina si trova in uno stato d’isocronia e non possiede un hic-et-nunc.
Di conseguenza: a) può avere orme-fossili del suo passato, non ricordi; b) cascate di eventi sul futuro, non progetti; c) uno scorrere di funzioni, non un’esistenza; d) un termine o spegnimento del processo, non una morte. Inoltre una macchina non ha una vera relazione con il mondo, perché in realtà si limita a processarlo, a tradurre cioè gli input in voci di output, a fruirlo o a evitarlo, giacché prossimità non è in lui vicinanza e distanza non è mai contemplazione.
L’animale è stordimento funzionale, povero di mondo: quello utile per sopravvivere.
Ecco allora che in Heidegger si chiarisce il non-detto cartesiano.
Con la traduzione macchinica dell’animalità si poneva una distanza incolmabile tra l’essere umano e le altre specie e parallelamente si sanciva in modo definitivo la libertà operativa sull’universo non-umano. Indubbiamente è stata un’evoluzione paradigmatica non facile e controversa fin dal XVII secolo: si trattava pur sempre di accentuare quella dialettica esclusiva solo in nuce nei primi umanisti.
Non stupisce pertanto che, accanto alle ipotesi postcartesiane che sempre più configuravano un piano riduzionista dell’espressività animale, a singhiozzo tornavano in modo, per così dire polare, proposte tese a riportare la soggettività tra le pieghe della natura. D’altro canto innumerevoli fattori hanno finito per previlegiare quella sponda riduzionista cui Cartesio offriva un nodo paradigmatico particolarmente efficace – primo fra tutti l’operatore autarchico e autopoietico dell’umano quale unico protagonista, principio già attivo nella metamorfosi umanista che da due secoli imperversava in Occidente.
A ciò aggiungasi che il meccanicismo indubbiamente era in linea con lo spirito del tempo, dove le conquiste scientifiche andavano ad affiancarsi a quelle geografiche, sociali, tecnologiche, in uno scialo di potenza e di meraviglia. La macchina perciò fungeva da ottima icona a quell’espansione operativa dell’uomo tuffato nella modernità. L’antroposfera si allargava attraverso ruote dentate e macchine idrauliche e così anche il non-umano veniva ingoiato all’interno degli ingranaggi. A ulteriore vantaggio c’era peraltro un artifizio esplicativo non indifferente: l’appello a una meccanica apparentemente esplicitata ma, di fatto, totalmente teorica. A ben vedere l’ipotesi meccanicistica di Cartesio non rispetta i canoni popperiani di falsificabilità(7) perché, non specificando il tipo di meccanismo chiamato a regolare la funzione animale – ovvero non avendo a disposizione una macchina capace di riprodurre la condizione animale – si appella a un dettato che non può essere messo alla prova, ma solo accettato. Tuttavia la criptotautologia riduzionista si presta a un dinamismo metamorfico in linea con la progressione tecnopoietica del progresso e ogni innovazione, col suo seguito di stupore e autocompiacimento, si presta a interpretare l’animalità godendo di una sorta di sospensione del giudizio critico: è cioè in grado di celare l’artificio.
Come ho detto, a differenziare il principio descrittivo della macchina, non c’è solo la forma-immagine di specie - l’essere cane invece che gatto - ma anche il tipo di macchina cui far riferimento, ovviamente in continua trasformazione in virtù dell’evoluzione tecnologica.
Da Cartesio in poi assisteremo pertanto a un susseguirsi di “modelli esplicativi” chiamati a descrivere il modo funzionale degli animali automata, senza intaccare il paradigma: la condizione di macchina. Il pullulare di modelli di spiegazione circa la costruzione del catalogo dei diversi automatismi e del loro innesco (definizione predicativa) non ha cioè messo in discussione il paradigma di base chiamato all’esplicazione della condizione di animalità (definizione metapredicativa). Questa situazione di stallo paradigmatico è giunto fino ai giorni nostri, nonostante la discussione sull’intelligenza o sulla coscienza delle altre specie.
In altre parole, nel susseguirsi di tentativi interpretativi che dal Seicento sono stati proposti, a mutare non è stata la condizione metapredicativa - l’essere una macchina - chiamata a spiegare la condizione animale, bensì la tipologia di automatismi invocati alla funzione esplicativa, ossia come funzionava e a che tipo di macchina era plausibile attribuire l’animalità. Cambiavano i predicati di risulta assunti dall’essere-animale: non più fili e pulegge come pretendeva Cartesio ma, in rapida successione, in virtù della febbrile evoluzione tecnologica dei secoli successivi alla rivoluzione scientifica, eccolo diventare “sensore chimico” orientabile attraverso tropismi, “motore a vapore” per pulsionalità interpretabili secondo logiche termodinamiche, “meccanismo cibernetico” retto da complesse ricorsività di retroazioni, computer istruito filogeneticamente da algoritmi ed euristiche.
3. DIALETTICA DELL’ESCLUSIONE E MACCHINA ANTROPOLOGICA
A tutto questo vanno aggiunti altri elementi per comporre il quadro dell’essereanimale, quale ancora si presenta ai nostri occhi. Il riduzionismo meccanicista non è stato l’unica bussola orientativa circa il modo di interpretare l’animalità come condizione. Possiamo dire che altre tradizioni e altri presupposti l’hanno preceduto e accompagnato dando luogo a un prospetto sincretistico che lo ha reso “cifra oppositiva” rispetto alla condizione umana. Riflettere sulla condizione animale significa pertanto incamminarsi all’interno di un labirinto involuto e ricorsivo di attribuzioni e d’interpretazioni preconcette. L’animalità è stata puntualmente trasformata: a) in oscura dimora ove proiettare paure o scomode presenze, b) in fondale per fare emergere la distinzione metapredicativa dell’essere umano, c) in amorfa categoria fatta di pluralità apparenti, d) nel tappeto elastico da cui balzare verso l’iperuranio, e) in territorio infettivo da evitare attraverso riti di purificazione. Difficile attribuire una genealogia a questa lettura pregiudiziale, ovvero un’unica fonte o una prevalenza.
Possiamo dire che ognuna ha reso il suo piccolo contributo al grande castello dell’antropocentrismo ontologico, proiettato sulla disgiunzione. Accanto alla tradizione meccanicista, la cultura occidentale ha stigmatizzato la condizione animale facendone un contro-termine rispetto all’umana dimensione. Si è trattato di un processo graduale e articolato, una narrazione che ha percorso l’arte, la religione, la filosofia, ma da cui si sono innalzate le colonne portanti dell’antropopoiesi stessa, ossia di quel percepirsi
e riconoscersi, intercettare il proprio telos e tendere, indirizzare l’ontopoiesi attraverso prassi antropotecniche, normare i codici di accettazione e rifiuto. L’animalità è divenuta così la sponda da cui congedarsi e parimenti da tenere sempre sotto osservazione per capire se la rotta tenuta era corretta, quasi una stella polare capace di indicarci il cammino da non percorrere. A presupposto o come logica conseguenza - difficile dirlo e probabilmente entrambi - si è stabilita la creazione di una “categoria animale”, più semplicemente “gli animali”, caratterizzata da predicati contrapposti a quelli attribuibili all’essere umano.
In un certo senso possiamo dire che il percorso tracciato nella nostra cultura - seppur con momenti di deviazione di rotta e stagnazioni ma, per converso, con momenti d’improvvise accelerazioni - è stato all’insegna di un distanziamento da un’idea fittizia di animalità, categorizzata attraverso un’arbitraria attribuzione di predicati che, quantunque impropri e nell’errore categoriale, si rivelavano utili all’operazione oppositiva presupposta. Per comprendere tale dettato occorrerebbe entrare in profondità in quella dialettica dell’esclusione che ha caratterizzato il progetto umanistico, teso a estrarre un’immagine metrico-sussuntiva, ossia universale dell’umano, attraverso operazioni di rigetto di ogni forma di declinazione funzionale. Il progetto umanistico si basa su un’epurazione radicale dei caratteri epimeteici dall’umano per dar luogo a due genealogie differenti.
La stirpe animale, frutto dell’incarnato funzionale, ossia del rango performativo, figlia del titano Epimeteo(8), non ha nulla a che vedere con quella umana, dalla virtualità somatica, larvale e indeclinata, perciò applicabile come unità di misura, priva di un rango e di conseguenza libera e autopoietica, figlia di Prometeo, dell’estro e della techne, dell’esternalizzazione performativa e quindi in grado di sussumere qualsivoglia performazione. L’artificio della doppia genealogia, tutt’altro che una semplice mitopoiesi, influenza alla radice la filosofia occidentale che ne ripeterà come una cantilena, seppur in forme poetico-semantico sempre differenti, gli stessi contenuti. A ben vedere tale operazione si manifesta come una tautologia tutt’altro che criptica: gli animali non condividono nulla con gli umani essendo, per l’appunto, animali. Nondimeno oggi è difficile uscire da questo errore interpretativo cosicché l’animale come contro-termine e alterità, più che una realtà su cui discutere diviene la cifra stessa del confronto e lo sfondo che consente di far emergere l’essere umano.
Come ho detto l’errore è triplice: 1) si disgiunge l’essere umano, nei suoi caratteri precipui, vale a dire in ciò che lo rende tale, dalla condizione animale; 2) si pretende di estrarre una struttura categoriale che preveda denominatori comuni agli eterospecifici in opposizione all’essere umano; 3) si attribuisce a tale categoria, in modo arbitrario, predicati che l’essere umano vuole rimuovere da sé. Si tratta in buona sostanza di un’epurazione dell’animalità dall’essere umano. Si scambiano le differenze predicative, vigenti in ogni specie (e in un certo senso persino in ogni individuo) e quindi valide per l’essere-umano, qualitativamente diverso dall’essere-gatto, per differenze metapredicative, vale a dire riguardanti non il profilo adattativo-ecologico bensì la dimensione ontologica.
Proponendo una diversità sui predicati poi la si elegge come dimensione profonda e quindi la si contrappone non alla singola specie non-umana ma alla condizione stessa di animalità.
Di questo pertanto occorre discutere, andando fino in fondo nell’analisi del modello paradigmatico chiamato a spiegare l’espressione animale, ancor prima di soffermarsi sulle performatività cognitive o sui livelli d’intenzionalità presenti nelle specie non-umane. Rimanendo adesi in modo tolemaico al paradigma antropocentrico e all’artificio cartesiano, ogni tentativo di costruire un continuismo, che da una parte faccia emergere la soggettività animale dall’altra sia rispettosa di una diversità di specie, è vano o forviante. Parlare di soggettività significa infatti accettare la sfida darwiniana delle peculiarità adattativo-ecologiche, applicando alle dotazioni cognitivo-comportamentali le stesse categorie analitiche che utilizziamo in anatomia o fisiologia comparata.
Dobbiamo tuttavia aver presente che, così facendo, estrarremo contiguità di parentela - le omologie - e convergenze in semantiche adattative - le analogie - ma non la tradizionale dicotomia tra essere umano e animale che sta alla base del progetto umanistico. L’animalità è una costellazione che ci comprende, non il contro-termine per una dicotomia antropo-poietica.
Penso che si debba affrontare la questione dell’animalità secondo due scansioni: 1) l’analisi predicativa, partendo dal fatto che ogni singolarità animale è un modo specifico di inventare uno o più mondi, sulla base di specificità che non possono essere ricondotte nella dicotomia esclusiva dell’animale contro-termine o in quella inclusiva dell’antropomorfismo; 2) l’analisi metapredicativa, riflettendo su cosa significhi essere-animale, ovviamente includente l’umano, rimettendo in discussione il paradigma meccanicistico della res extensa e considerando la soggettività non come espressione cosciente o razionale dell’essere, bensì come comprensione nel desiderio, come intenzionalità del desiderio. Agendo di concerto sulle due scansioni, si annulla quell’operazione umanistica che Agamben chiama “macchina antropologica”, per riscoprire la pluralità della condizione animale e parimenti quella matrice comune dell’essere-animale che ci rende parti della stessa costellazione.
4. RITORNO ALLA SOGGETTIVITÀ IRRAZIONALE
È indubbio che la condizione di animalità ci riguardi da vicino, in specie dopo la rivoluzione operata da Darwin. Il naturalista inglese ha posto in evidenza la continuità dei viventi e, in ossequio a una logica popolazionale dei predicati e a prossimità filogenetiche di somiglianze e divergenze, ha fatto emergere una tassonomia non antropocentrica, fondata su piani di appartenenza genealogici e non su essenze – queste ultime per definizione disgiunte(9). Con l’evoluzionismo – e nelle successive sintesi operate dalla genetica, dall’embriologia, dalla paleontologia, dalle scienze informatiche – si rompe l’isolamento ontologico dell’essere umano e ogni tentativo di mantenere le vecchie distinzioni di matrice umanista è destinato a vacillare, tenendosi in equilibrio precario su matrici ontopoietiche esterne come il linguaggio, la techne, la cultura.
Anche sospinta nei fondali dell’essere umano, da una tradizione che non accetta di rinunciare all’ancoraggio pichiano, l’animalità forza il confinamento ed entra nel cuore della costruzione identitaria e della manifestazione espressiva, per cui non è più possibile l’operazione di distanziamento: il nostro essere fluttua nella condizione animale.
D’altro canto, forse proprio in risposta allo tsunami darwiniano, abbiamo assistito nel corso del XX secolo a modelli che, seppur in differente modo, rilanciavano il dettato cartesiano proponendosi di spiegare l’espressione meccanizzando le dotazioni dell’animale. L’istinto, o automatismo innato, della tradizione di etologia classica, e il condizionamento, o automatismo appreso, del behaviorismo, ne sono esempi eclatanti, che ancora campeggiano nella spiegazione dell’espressione animale. Come si può notare, non c’è spazio in questo modello esplicativo per una soggettività giacché l’istinto è condizionamento, ossia le dotazioni, sono già in sé esaustive a spiegare ciò che l’animale compie.
Non può darsi una presenza soggettiva perché manca una sovranità sulla dotazione: l’animale non può averne titolarità perché il modello che spiega la dotazione è meccanicistico e imperativo sul soggetto. Se la dotazione è da sola responsabile nella sua struttura di ciò che esprime, la soggettività di fatto non esiste, è pura apparenza. Inutile a questo punto aggiungere la coscienza se abbiamo compreso il principio d’intenzionalità di Brentano.
È ovvio che per ammettere una soggettività animale sia indispensabile assumere una non esaustività esplicativa della dotazione nell’espressione comportamentale: è il soggetto che la utilizza, che ne è titolare, avendo dei margini di utilizzo ovvero una pluralità di uso e una possibilità di modifica. Se infatti la dotazione in sé viene chiamata a spiegare in modo esaustivo ciò che l’animale fa, inevitabilmente la dotazione non è più uno strumento a disposizione del soggetto - una dotazione per l’appunto - ma diventa un automatismo che muove l’individuo, un filo che trasforma l’animale in un burattino. Non è pertanto la complessità della funzione espressa a liberare l’animale dal paradigma esplicativo meccanicistico che va da Cartesio ai giorni nostri, bensì è la pretesa di leggere il comportamento come la manifestazione diretta di un automatismo.
Finché rimarremo imbrigliati in questa pretesa non ci sarà espressione per quanto complessa che non possa venir trasformata in modo meccanicistico, togliendo tuttavia il cuore stesso dell’essere-animali che si basa su una presenza e non semplicemente su una funzione espressiva.
Quando diciamo che gli animali non sono oggetti poniamo un problema epistemologico ineludibile che non può essere bypassato attraverso il ricorso al deus ex machina della coscienza o al principio tautologico della capacità di cogliere il mondo in quanto tale. Se di un esistenzialità animale bisogna parlare occorre farlo sulla base non di una petizione di principio trascendente, ma su un ripensamento profondo della condizione dell’essere animali. E il problema non riguarda, perlomeno non in prima battuta, il modello che utilizziamo per descrivere e spiegare l’espressione della soggettività, quanto piuttosto i presupposti che rendono possibile la soggettività e ancor prima il concetto stesso di soggettività. Soggettivo può essere solo un ente il cui comportamento non sia predeterminato dalle strutture che lo compongono. Perché si possa parlare di soggettività l’individuo dev’essere titolare dei propri strumenti, qualsiasi componente innata o acquisita nel corso della propria esistenza dev’essere uno strumento e non un automatismo.
Essere soggettivi significa poter utilizzare le proprie dotazioni come si usa una mappa di una città per realizzare in modo corretto la singolarità del proprio itinerario.
Ma allora, non volendo ricadere nell’infinita regressione dell’homunculus o ricorrere ad altre forme di pseudo-spiegazioni che, a ben vedere, altro non sono che sottili sotterfugi tautologici o petitio principii, occorre tornare a riflettere sulla soggettività, ammettendo che le espressioni predicative dell’essere animale mi mostrano un modo di declinare la soggettività, un come-espressivo di questa, ma non risolvono interamente la questione. Ogni animale - ed è ovvio che sottintendo l’essere umano, ma altresì le diverse scansioni dell’identità tassonomica che non si ferma all’individualità ma alla momentaneità della condizione vissuta - si esprime utilizzando, in modo libero, creativo, cooptativo e chi più ne ha più ne metta, le dotazioni che si ritrova: endocrine, cognitive, metaboliche, motorie, sensoriali. Ed è ovvio che modificando dette dotazioni l’espressione soggettiva risulterà modificata. Tuttavia il motore della soggettività sta nell’utilizzare dette dotazioni in modo libero e creativo, non aderendo pienamente ai suoi dettati performativi. La soggettività sta più nel desiderio che espone il soggetto al mondo e lo porta a immergersi in una costante condizione di problematicità.
Desiderare significa infatti avere/porsi dei problemi. La vita di ogni essere vivente è in una continua condizione di scacco, ove con tale termine si debba intendere sia la necessità/opportunità di raggiungere un target non disponibile sia evitare un rischio immediato o uscire da una situazione di criticità. La parola
“scacco” implica cioè una condizione di problematicità, vale a dire l’essere inserito nel qui-e-ora come dimensionato in un problema. Lo stato di problematicità è perciò la condizione stessa dell’essere animale, che attraverso il suo comportamento, ossia il suo agire nel/sul mondo, esprime inevitabilmente una connotazione desiderante, una vitalità libidica. Soffermarsi sulle modalità di espressione di questo stato di languore permanente è senz’altro utile per carpire il profilo di chi abbiamo di fronte ma non per comprendere fino in fondo il suo stato. Questo sembra più un portato emergenziale ovvero sistemico, che pertanto trascende la singola dotazione, piuttosto che l’effetto sommatorio di queste. Forse proprio per questo l’essere-animale si caratterizza etimologicamente come colui che trascende il suo essere fenomenico.
D’altro canto la soggettività richiede sempre un’intersezione epifanica con il mondo, se consideriamo il semplice principio di singolarità del reale, espresso da Ilya Prigogine(10) in aperta opposizione all’immagine deterministica, vecchio retaggio del demone di Pierre-Simon Laplace. Desiderare pertanto significa costruire un dialogo singolare con la realtà, facendo emergere un piano negoziale - un range di possibilità nel campo virtuale - con essa e non semplicemente adattarsi a condizioni prefissate. Il comportamento non va pertanto interpretato come consumazione di una pulsione o come reazione a uno stimolo, bensì come espressione di permanere nel desiderio scalando sempre nuovi piani di realtà. Se il mondo si presenta al soggetto in modo singolare, è evidente che, seppur riconducibile a somiglianze, ogni scacco presenta connotati di novità, per cui il soggetto se vuole dar corso ai propri desideri deve giocoforza essere creativo: visionario e cooptativo rispetto alle dotazioni possedute.
Torniamo a vecchi paradossi, che Cartesio ha semplicemente dribblato con eleganza nel suo dualismo, trasformando il vivente in carne putrefatta. Ciò che ci rende soggettivi, vitali perché desideranti, emergenti perché non sussumibili, infedeli a noi stessi, sempre pronti all’infrazione e all’emancipazione dei vincoli costitutivi per paradosso non ci appartiene. Non scegliamo i nostri desideri, le emozioni che percorrono i nostri sogni, i languori che agitano la nostra immaginazione, i sentimenti che si prendono gioco della nostra razionalità, le motivazioni che ci coniugano e ci orientano verso il mondo. Tutto ciò che possiamo fare è dar loro una qualche figurazione fittizia, ben sapendo che non è la pallina che muove il predatorio del nostro gatto: la stessa cosa vale per le mille scuse che ci diamo per spiegare l’incontenibile voglia che ci fa dipanare la vita come una matassa, per poi arrivare in fondo e rimpiangere quel languore ignorante che ci faceva rimaner stupiti da bambini.
C’è più soggettività nel sogno e nell’allucinazione che nel logico raziocinio con cui riponiamo i desideri nel cassetto dei pensieri e delle rappresentazioni.
Ecco allora che per comprendere la nostra soggettività dobbiamo tornare al desiderio che anima, abbandonando la pretesa di essere al timone di questa vita che ci possiede.
Note:
1. Jakob von Uexküll, Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata in mondi sconosciuti e invisibili, trad. it. di M. Mazzeo, Quodlibet, Macerata 2010.
2. Nikolaas Tinbergen, Il comportamento sociale degli animali, Einaudi, Torino, 1963.
3. Cfr. Roberto Marchesini, Fondamenti di zooantropologia. La zooantropologia teorica, Apeiron, Bologna, 2014 ed Epifania animale. L’oltreuomo come rivelazione, Mimesis, Milano-Udine 2014. Qui ho mostrato come l’incontro con l’animale non umano stia alla base della nostra dimensione culturale.
4. Konrad Lorenz, L’aggressività, Mondadori, Milano, 1986.
5. B. F. Skinner, Verbal behaviour, Appleton-Century-Crofts, New York, 1957.
6. Martin Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo – finitezza - solitudine, Il Melangolo, Genova, 1999.
7. Karl Popper, Logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino, 1970.
8. Cfr. Roberto Marchesini, Alla fonte di Epimeteo, “Aut Aut. La condizione postumana”, 361, 2014, pp. 34-51.
9. Charles Darwin, L’origine delle specie. Selezione naturale e lotta per l’esistenza, Bollati Boringhieri, Torino, 1967 e L’origine dell’uomo, Rizzoli, Milano, 1982.
10. Ilya Prigogine, Le leggi del caos, Laterza, Roma-Bari, 1993.
Roberto Marchesini (bologna, 1959) è filosofo, etologo e zooantropologo. da oltre vent’anni conduce una
ricerca interdisciplinare volta a ridefinire il ruolo degli animali non umani nella nostra società. Direttore del centro studi filosofia Postumanista e della scuola di interazione Uomo-animale (siua), è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni nel campo della bioetica animale, delle scienze cognitive e della filosofia post-human. Tiene conferenze in tutto il mondo (stati Uniti, germania, lituania, regno Unito, grecia, india, corea) nelle quali affronta il tema del rapporto uomo-animale (zooantropologia). tra gli ultimi lavori: Contro i diritti degli animali? Proposta per un antispecismo postumanista (sonda, 2014), Epifania Animale. L’oltreuomo come rivelazione (mimesis, 2014), Così parlò il postumano (con leonardo caffo) (novalogos ,2014), Fondamenti di zooantropologia (apeiron, 2014), Il dio Pan. Racconti lirici (graphe.it, 2015) e l’autobiografia Ricordi di animali (mursia, 2013). È inoltre direttore della rivista “animal studies. rivista italiana di antispecismo” (novalogos).
Articolo tratto da: "Animot – l’altra filosofia", anno III, numero 1, giugno 2016
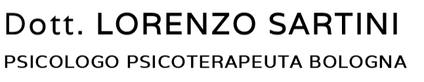
 Feed RSS
Feed RSS
