
Intervista di Erminio Ferrari ed Ellade Ossola (da: www.planetmountain.com)
«Vorrei essere ricordato come l’alpinista che ha fallito più di tutti sugli Ottomila». Ecco, se avete un’idea di Reinhold Messner ricalcata sull’immagine che ne hanno dato (complice lui stesso) giornali, libri e televisioni, cambiatela. Le parole che riempiono una sala spoglia di Castel Firmiano, dove ha sede il maggiore dei cinque musei fondati dall’alpinista altoatesino, sono quelle di un uomo di 65 anni, che è sì cresciuto sulle proprie certezze, ma che non ha mai esitato davanti ai fatti o agli incontri che gliele hanno fatte correggere. Ricordarlo come il primo salitore di tutte le quattordici cime di ottomila metri è davvero poca cosa. Prima che in Himalaya, la sua grandezza alpinistica aveva già fatto sensazione sulle Alpi e sulle Dolomiti; poi vennero le traversate dell’Antartide, della Groenlandia, quella in solitaria del Deserto del Gobi, il mandato di parlamentare europeo, l’avventura dei musei della montagna. Ma sono stati senza dubbio i giganti himalayani a dargli una fama che nessun alpinista aveva mai conosciuto, né forse avrà più. Cominciamo da qui, allora.
Come si portano l’onore e la responsabilità di essere la prima figura di alpinista universalmente nota?
«La notorietà non significa per forza qualità dell’alpinista. Ma è vero, sono una persona nota perché faccio attività anche al di fuori dell’alpinismo. Sono una figura che attira interesse; ma a me interessa soprattutto poter fare la mia vita, senza volere essere un leader, né compiacere i desideri di qualcuno o di un pubblico. Non voglio essere seguito».
«No. Non abbiamo responsabilità nei confronti di chi ci prende a modello. Non sono responsabile di chi vorrebbe ma non sa fare».
L’alpinista è spesso dipinto come un uomo libero o piuttosto come un individualista. Non ha mai sentito limitata la sua libertà da questa figura?
«La mia libertà di alpinista include la responsabilità di ciò che faccio nei confronti di chi mi è vicino, figli, moglie, genitori. È chiaro che chi svolge un’attività pericolosa porta con sé questa responsabilità e solo chi se l’assume può veramente dirsi libero alpinista. L’alpinismo si pratica in un mondo arcaico dove non ci sono leggi, ma proprio per questo non c’è quasi rimedio agli errori. È una vita anarchica che chiede di assumersi la responsabilità di ciò che si fa. In ogni salita difficile va contemplata la possibilità di morire, e in questo senso l’alpinismo è egoista».
Ma lei non si è mai sentito limitato in quanto uomo dall’essere un personaggio?
«Sono una persona pubblica e questo è un onere; ma lo accetto, perché so che non mi condiziona nelle scelte. Non mi curo di chi mi applaude o mi fischia. Voglio essere giudicato sul palco come oratore; sul piano letterario se scrivo un libro, su quello artistico se giro un film. Ma non come un vitello a tre teste perché ho fatto i 14 Ottomila o l’Everest o queste cose qui».
Quando ha portato a termine l’ultimo Ottomila lei ha scritto: sono contento di averlo fatto, ma non ne sono fiero. Può spiegare perché?
«Sono stato uno dei primi a dare un taglio all’alpinismo eroico, nato nei primi decenni del secolo in Italia e Germania – non a caso culle del fascismo europeo – sopravvissuto anche dopo la seconda guerra mondiale e in parte vivo ancora oggi. E sono stato il primo a dire: io non porto bandiere in vetta, la mia bandiera è il mio fazzoletto; venendo per questo fischiato e insultato. Non condivido neppure la filosofia secondo cui un alpinista che muore in montagna è in qualche sorta un eroe. No: se l’alpinista muore è solo una disgrazia. E la sola cosa da fare è prendersi cura di chi ha lasciato».
Sempre a proposito delle sue salite agli Ottomila, lei ha scritto di aver a un certo punto perso le motivazioni per continuare la collezione. Che cosa era successo?
«Mi mancavano le sfide e le possibilità. Io, per ragioni anagrafiche, sono entrato nell’alpinismo d’alta quota alla fine della fase della cosiddetta conquista. La generazione mia e di Bonington, ha così tentato di salire quelle stesse montagne lungo vie difficili o pareti inviolate. La nostra meta era sì di raggiungere la vetta più alta, ma con il minimo equipaggiamento e per una via possibilmente difficile. È un tipo di alpinismo che ho sviluppato passo dopo passo. All’inizio (nel 1970 al Nanga Parbat) scelsi una via difficile con una spedizione classica; poi (nel 1975 al Gasherbrum I) venne la via difficile in una cordata a due (con Peter Habeler ndr); nel 1978 la solitaria al NangaParbat e poi (nello stesso anno, con Peter Habeler) l’Everest senza ossigeno; a cui seguì la solitaria sulla stessa montagna nel 1980. Quattro anni dopo la traversata dei due Gasherbrum (con Hans Kammerlander ndr). Ormai non restava che la collezione degli Ottomila, ma non era il mio obiettivo iniziale. Certo, giunto a quel punto, anche sulla spinta dei giovani alpinisti che mi seguivano nelle salite e facevano conto su di me, dopo aver fatto tre Ottomila in un anno ho pensato che tanto valeva finirli tutti».
La crisi arrivò sull’ultimo, il Lhotse, nel 1986 fu la paura di vedere l’obiettivo così vicino, o si trattò d’altro?
«Finendo gli Ottomila era chiaro che mi liberavo di un peso che io stesso mi ero caricato. Ma avevo già altre idee, per la verità. Sul Lhotse, sulla espostissima cresta finale soffiava un vento fortissimo che rischiava di buttarci giù.Ma Kammerlander, che era con me, ha insistito: andiamo avanti, e così abbiamo fatto. Fu una liberazione, ma anche il momento della crisi: per sedici anni non avevo fatto altro (occupandomi di tutto dalla logistica alla ricerca dei finanziamenti). Ora i miei compagni non condividevano i progetti futuri di traversate ai Poli, e non ho trovato nessuno disposto a seguirmi; forse non capivano la dimensione di quella nuova avventura, o la temevano. Ho dovuto imparare da zero e per fortuna ho trovato specialisti in quel campo, scoprendo compagni straordinari».
È un fatto di esposizione mediatica? Forse le grandi montagne sono più note dei Poli?
«A lungo è stato il contrario. La vera competizione era quella per i Poli, il cui prestigio era molto maggiore di quello degli Ottomila. È cambiato tutto negli anni 50: gli inglesi avevano investito soldi e perso uomini nella corsa ai Poli, ma furono battuti a Nord e a Sud. Allora si volsero all’Everest, inventando il “terzo polo”. Ma già dopo la conquista dell’Everest, gli Ottomila persero gran parte del loro fascino. In seguito, però, dato che ogni nazione importante nel campo alpinistico voleva il proprio Ottomila, la loro notorietà crebbe e dura ancora oggi. Putroppo la gente non ha ancora capito quale è il valore delle grandi traversate dell’Artico o dell’Antartide, perché sono lontane, e chi ne scrive la fa in maniera troppo tecnica o fredda, senza parlare delle emozioni, senza avere in coraggio di mettersi a nudo».
Il business può condizionare la scelta degli obiettivi alpinistici, o forzare gli alpinisti a osare più del lecito?
«Il lecito non esiste. Ognuno può prendersi tutti i rischi che vuole e io non mi farò mai giudice delle scelte altrui. Detto questo, è vero che la sponsorizzazione spinge l’alpinismo di punta a tentare certe realizzazioni. Naturalmente chi paga ha interesse a un ritorno di immagine, ma è l’alpinista che deve saper scegliere i propri obiettivi e resistere alle eventuali pressioni».
Lei ha anche conosciuto l’esperienza del fallimento. Come se ne esce, che cosa si impara?
«Non c’è alpinista di punta che non abbia conosciuto il fallimento. Si impara attraverso il fallimento, non attraverso ciò che riteniamo essere vittorie. Per la propria consapevolezza è importante conoscere i propri limiti, e li si conosce soltanto sperimentandoli. Io ho fallito tredici ottomila. Vorrei essere ricordato come l’alpinista che ha fallito più volte sugli Ottomila. Io ho fatto 18 volte la salita di un Ottomila, perché mi interessavano le salite non i record. Se non avessi fallito (come mi è capitato sul Dhaulagiri, sul Makalu e sul Lhotse) sarei già morto. Ho dimostrato di essere coraggioso nelle sfide, ma anche nel ritirarmi».
Nel suo La mia vita al limite, lei scrive che “quando sei appeso là in alto saresti disposto a qualsiasi cosa pur di salvare l’altro”. Le cronache alpinistiche sono tuttavia colme di episodi di grettezza o meschinità costate anche la vita ad alcuni alpinisti. L’uomo regredisce o si mostra per ciò che è nelle esperienze al limite?
«Finché l’alpinista sale con uno o due amici, farà di tutto per salvare chi ha con sé. Ma se si è in mille su una via, questo atteggiamento lo separerà dai mille altri. È la differenza tra una cultura montana che obbliga, per le condizioni ambientali difficili o estreme, alla condivisione e alla solidarietà; e una metropolitana, dove gli individui vivono soli, pur ammassati. Quante volte leggiamo del ritrovamento di persone morte nelle proprie case senza che nessuno se ne fosse accorto? Chi, incrociando qualcuno sul marciapiede, si chiede se ha bisogno? In montagna avviene ormai che la cultura urbana, competitiva e individualista è entrata condizionandolo, nell’alpinismo. Nel 2003 ero al campo base dell’Everest e per andare dalla prima all’ultima tenda ci volevano due ore. Ho chiesto di due amici che sapevo essere lì e nessuno sapeva chi fossero, nonostante salissero tutti sulla stessa via».
Nella sua prima salita a un Ottomila, il Nanga Parbat nel 1970, lei ha perso suo fratello Günther. Quanto e come questo episodio ha mutato il suo rapporto con l’alpinismo?
«È stata un’esperienza fondamentale nella mia vita e mi ha fatto considerare del tutto morta la retorica sul cameratismo in montagna. Sapevo, salendo alla cima, che stavamo mettendoci su un cammino di rischio assoluto. Poi, nella discesa non c’è più stata scelta. Per i miei genitori è stato un colpo durissimo; per me, in più, c’era lo sgomento di non essere creduto. Il capospedizione mi aveva dato per morto e quando tornai dovette darsi e dare una spiegazione. Il mio ritorno destabilizzò i suoi piani perché si riteneva impossibile che potessimo scendere in quelle condizioni dal Nanga Parbat. Poi vennero le accuse, e solo il ritrovamento dei resti di Gunther, dopo 35 anni, ha reso la verità della storia, nonostante le speculazioni indegne costruite a mio danno».
Yuri Gagarin, dopo il primo volo spaziale disse di non aver visto dio in cielo. Lei che cosa ha visto sulle cime più alte della terra?
«Chi pensa che l’Everest sia più vicino a Dio sbaglia. Se pensiamo all’infinito non c’è nessuna differenza tra l’Everest e noi qui a questa quota modesta.L’Aldilà, o dio se si vuole chiamare così, è fuori dalla nostra portata. Rispetto l’Aldilà ma non ho il diritto né il coraggio per descriverlo, è fuori della nostra misura».
La vera avventura, scrive lei, è quella dove non è garantito il ritorno. Quale è allora il valore della vita per Reinhold Messner?
«Non è che la vita valga meno se la si mette in gioco o ci si espone al rischio di perderla. Andare in zone pericolose è un modo per vivere più intensamente. Del resto oggi le metropoli sono molto più pericolose della cima dell’Everest. Abbiamo impiegato migliaia di anni per metterci al sicuro, ma il sentimento di insicurezza non fa che crescere».
Che valutazione dà della sua esperienza di parlamentare europeo?
«È stata comunque positiva, benché mi sia reso conto che non faceva per me. Ho imparato una cosa importantissima: che l’Europa è necessaria più che mai. È sbagliato, al contrario, fare politica in Europa per difendere gli interessi locali. L’Europa è all’avanguardia nella politica ecologica, sociale e della pace. È la carta che possiamo giocare a favore di tutto il mondo».
Ancora in La mia vita al limite, lei scrive “la felicità non mi ha mai creato problemi”. Un’espressione bellissima e oscura. La vuole spiegare?
«La felicità raggiunta è una cosa noiosa. Anche il sapere e l’avere lo sono. È molto più interessante arrivarci; progettare, cercarla, la felicità».
Lei si lasciò alle spalle un mondo coeso, con un forte senso di comunità e valori saldi, che però avvertiva come chiuso e reazionario. Prese la strada del mondo e della montagna come pratica sportiva. I suoi musei sono oggi un ritorno, o la chiusura del cerchio?
«Sono stato fortunato a uscire da questa terra che era e resta molto chiusa. Sono tornato a portarvi la mia idea di pace, e vi propongo vie di convivenza praticabili. Io sono stato il primo a dire: noi sudtirolesi non siamo italiani né austriaci, né tedeschi, ma sudtirolesi e europei. Se ragioneremo così saremo d’esempio per le altre regioni d’Europa. Una volta dire queste cose bastava per essere espulsi dalla comunità. Solo ora, lentamente, la mia strada, che è quella di Alex Langer, si va confermando quella più giusta. Ho riattivato tre masi di montagna dimostrando che si può animare un’economia locale autentica, non finanziata da fuori, ma sufficiente e esemplare. Questo intendo per politica ».
Intervista di Erminio Ferrari ed Ellade Ossola - 12/09/2009
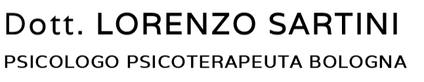
 Feed RSS
Feed RSS
