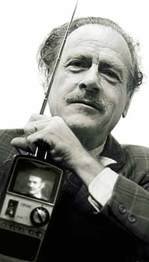
Fonte: La Repubblica
21.01.2009
Con il telegrafo, l'uomo occidentale ha iniziato ad allungare i suoi nervi fuori dal proprio corpo. Le tecnologie precedenti erano state estensioni di organi fisici: la ruota è un prolungamento dei piedi; le mura della città sono un'esteriorizzazione collettiva della pelle. I media elettronici, invece, sono estensioni del sistema nervoso centrale, ossia un ambito inclusivo e simultaneo.
A partire dal telegrafo, abbiamo esteso il cervello e i nervi dell' uomo in tutto il globo. Di conseguenza, l'era elettronica comporta un malessere totale, come quello che potrebbe provare una persona che abbia il cervello fuori dalla scatola cranica. Siamo diventati particolarmente vulnerabili. L'anno in cui fu introdotto il telegrafo commerciale in America, il 1844, fu anche l'anno in cui Kierkegaard pubblicò il concetto dell'angoscia.
Quando guidiamo la macchina o guardiamo la televisione, tendiamo a dimenticare che ciò con cui abbiamo a che fare è soltanto una parte di noi stessi messa là fuori. In questo modo, diventiamo servomeccanismi delle nostre stesse creazioni e rispondiamo ad esse nel modo immediato e meccanico che esse richiedono.
Il punto centrale del mito di Narciso non è che gli individui tendono a innamorarsi della propria immagine, ma che si innamorano di proprie estensioni, convinti che non siano loro estensioni. Penso che questa sia un'immagine piuttosto precisa di tutte le nostre tecnologie, e ci invita a riflettere su una questione fondamentale: l'idolatria della tecnologia comporta un intorpidimento psichico.
Agli occhi di osservatori successivi, ogni generazione sospesa dinanzi a un grande cambiamento sembra essere stata del tutto inconsapevole dell'imminenza e dei punti fondamentali dell'evento stesso. Ma è necessario comprendere il potere che hanno le tecnologie di isolare i sensi l'uno dall'altro, e così di ipnotizzare la società.
La formula dell'ipnosi è «un senso alla volta». I nostri sensi privati non sono sistemi chiusi ma vengono incessantemente tradotti l'uno nell'altro in quella esperienza sinestetica che chiamiamo coscienza. I nostri sensi estesi, strumenti o tecnologie, sono invece sistemi chiusi, incapaci di interazione. Ogni nuova tecnologia diminuisce l'interazione e la consapevolezza dei sensi proprio nell'area a cui quella tecnologia si rivolge: si verifica una sorta di identificazione tra osservatore e oggetto. (...)
La nuova tecnologia elettronica, però, non è un sistema chiuso. In quanto estensione del sistema nervoso centrale, essa ha a che fare proprio con la consapevolezza, con l'interazione e con il dialogo. Nell'era elettronica, la stessa natura istantanea della coesistenza tra i nostri strumenti tecnologici ha dato luogo a una crisi del tutto inedita nella storia umana. Ormai le nostre facoltà e i nostri sensi estesi costituiscono un unico campo di esperienza e ciò richiede che essi divengano collettivamente coscienti, come il sistema nervoso centrale stesso. La frammentazione e la specializzazione, tratti caratteristici del meccanismo, sono assenti. Tanto siamo inconsapevoli della natura delle nuove forme elettroniche, altrettanto ne veniamo manipolati. (...)
I modi di pensare generati dalla cultura tecnologica sono molto diversi da quelli favoriti dalla cultura della stampa. A partire dal Rinascimento, la maggior parte dei metodi e delle procedure hanno teso fortemente a enfatizzare l'organizzazione e l'applicazione visiva del sapere. I presupposti latenti nella segmentazione tipografica si manifestano nella frammentazione dei mestieri e nella specializzazione delle mansioni sociali. La scrittura favorisce la linearità, ossia una consapevolezza e un modo di operare secondo il principio «una cosa alla volta». Da essa derivano la catena di montaggio e l'ordine di battaglia, la gerarchia manageriale e la divisione in dipartimenti che caratterizza le strutture accademiche. Gutenberg ci ha dato analisi ed esplosione. Frammentando il campo della percezione e dell'informazione in segmenti statici, abbiamo realizzato cose meravigliose.
I media elettronici operano però in modo diverso. La televisione, la radio e il giornale (che a sua volta era legato al telegrafo) hanno a che fare con lo spazio acustico, vale a dire con quella sfera di relazioni simultanee creata dall'atto di ascoltare. Noi udiamo suoni provenienti da tutte le direzioni nello stesso momento; questo crea uno spazio unico, non visualizzabile. La simultaneità dello spazio acustico è l'esatto contrario della linearità, del prendere una cosa alla volta.
E' molto sconcertante rendersi conto che il mosaico di una pagina di giornale è «acustico» nella sua struttura fondamentale. Questo, tuttavia, vuole dire soltanto che qualunque struttura, le cui componenti coesistano senza connessioni o legami diretti, lineari e creino un campo di relazioni simultanee, è acustica, anche se alcuni suoi aspetti possono essere visualizzati. Le notizie e le pubblicità che si trovano sotto la data di un giornale sono tenute insieme soltanto dalla data. Non hanno alcuna interconnessione di natura logica o discorsiva. Eppure formano un mosaico legato all'immagine aziendale le cui parti si compenetrano tra loro.
Questo è anche il tipo di ordine che tende a costituirsi in una città o in una cultura. E' un'unità di tipo orchestrale e vibrante, non l'unità del discorso logico. Il potere tribalizzante dei nuovi media elettronici, il modo in cui essi ci riportano alla dimensione unificata delle antiche culture orali, alla coesione tribale e a schemi di pensiero preindividualistici, non è stato realmente compreso.
Il tribalismo è il senso di un profondo legame di famiglia, è la società chiusa come norma della comunità. La scrittura, in quanto tecnologia visiva, ha dissolto la magia tribale ponendo l'accento sulla frammentazione e sulla specializzazione, e ha creato l'individuo. D'altra parte, i media elettronici sono forme di gruppo. I media elettronici dell'uomo di una società alfabetizzata riducono il mondo a una tribù o a un villaggio in cui tutto capita a tutti nello stesso momento: ognuno conosce e dunque partecipa a ogni cosa che accade nel momento in cui essa accade. (...)
Siamo diventati come l'uomo paleolitico più primitivo, di nuovo vagabondi globali; ma siamo ormai raccoglitori di informazioni piuttosto che di cibo. D'ora in poi la fonte di cibo, di ricchezza e della vita stessa sarà l'informazione. Trasformare tale informazione in prodotti, a questo punto, è un problema che riguarda gli esperti di automazione e non più una questione che comporta la massima divisione del lavoro e delle capacità umane. L'automazione, come tutti sappiamo, permette di fare a meno della forza lavoro. Questo terrorizza l'uomo meccanico perché non sa che cosa fare nella fase di transizione, ma significa semplicemente che il lavoro è finito, morto e sepolto. (...)
Quando nuove tecnologie si impongono in società da tempo abituate a tecnologie più antiche, nascono ansie di ogni genere. Il nostro mondo elettronico necessita ormai di un campo unificato di consapevolezza globale; la coscienza privata, adatta all'uomo dell'era della stampa, può considerarsi come un cappio insopportabile rispetto alla coscienza collettiva richiesta dal flusso elettronico di informazioni.
In questa impasse, l'unica risposta adeguata sembrerebbe essere la sospensione di tutti i riflessi condizionati. Penso che, in tutti i media, gli artisti rispondano prima di ogni altro alle sfide imposte da nuove pressioni. Vorrei che ci mostrassero anche dei modi per vivere con la nuova tecnologia senza distruggere le forme e le conquiste precedenti. D'altronde, i nuovi media non sono giocattoli e non dovrebbero essere messi nelle mani di Mamma Oca o di Peter Pan. Possono essere affidati solo a nuovi artisti.
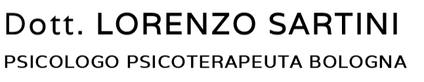
 Feed RSS
Feed RSS
