
“Tutte le nostre consocenze sulla schizofrenia come pure la possibilità di un suo trattamento sono fondamentalmente legate al manicomio”
“… (…) La nuova legge 833 che, abolendo il manicomio, ha spostato sul territorio l’intervento psichiatrico, con tutta probabilità permetterà una conoscenza della schizofrenia diversa da quella avuta fino ad oggi”.
L’introduzione del libro ci predice un passaggio da una possibilità a una probabilità, ciò che è stato possibile e ciò che sarà probabile.
Come sfondo di questo gioco di certezze si colloca la fine di una tappa, quella del manicomio, e l’inaugurazione dell’altra, quella del territorio. In mezzo alle due situazioni storiche c’è la nascita e lo sviluppo della psicoanalisi.
L’insistenza di Merini sulla questione del ‘Territorio’ (è il suo secondo libro su questo tema; il primo, curato da lui, è “Psichiatria nel territorio”, Ed. Feltrinelli) ci obbliga a considerarlo come emergente di una situazione storico-sociale, la legge 180 e la legge 833, che chiudono il manicomio e stabiliscono una ‘Assistenza a livello di comunità’.
Torniamo a Merini come emergente della situazione storico-sociale del pensiero e della pratica psichiatrica, per i problemi che indica nel suo libro e per la polemica che apre usando certe definizioni. Si trovano nel libro due posizioni: una didattica e quella dell’intervento psichiatrico. La psicoanalisi che si prende in considerazione è quella della ‘Psicologia dell’Io’ (pag. 10). I capitoli I e II espongono le ipotesi di quest’ultima sulla schizofrenia, e danno una descrizione dinamica della stessa. Lo scopo di questi due capitoli è quello che poi appare nell’appendice (2°) sulla Didattica, cioè hanno la funzione di informare gli studenti e i giovani operatori che esiste una diversa valutazione della schizofrenia.
A sua volta però questo tipo di informazione serve come introduzione all’interno, e in alcuni momenti la psicoanalisi corre il pericolo di trasformarsi paradossalmente in una ipotesi da comprovare sul campo. Non ci può sfuggire che qui si apre il primo intervento, e cioè se questa definizione dinamica della schizofrenia è stata quella possibile o sarà quella probabile della situazione storica?
Entriamo adesso nella seconda parte del libro, dal capitolo III al VI. Mi sembra che qui il libro diventi completamente polemico ed apra un insieme di interrogativi che coinvologno tutti coloro che desiderino riflettere su questa questione.
Cominciamo dai problemi che si svolgono attorno alla vita quotidiana. La situazione diventa discutibile, soprattutto se si è introdotta la psicoanalisi. Questa ci spinge a non fermarci a ciò che appare di un comportamento. Se “la regolazione degli orari” di un ex paziente, “le sue diverse letture”, “la sua voracità smisurata” o il problema della “solitudine” non si iscrivono in una interpretazione del processo dell’inserimento, rimangono solo dati sociologici o, nel migliore dei casi, psicosociologici sospesi nell’aria.
Come e chi interpreta? Quale luogo del territorio permette la interpretazione? È possibile una interpretazione ambulante, e/o qual è il suo setting? Questi sono problemi da chiarire, ma che è impossibile evitare, perché altrimenti si fissa una rottura tra una comprensione sociologica e una spiegazione psicoanalitica della situazione. Contini dice di fare entrare in “una dimensione umana lo schizofrenico” (pag. 53). Qual è questa dimensione se non quella della parola, cioè il suo discorso e la controparte, e quindi la interpretazione? A questo punto si pone il problema dell’intervento, e del territorio come luogo dell’intervento.
Merini svolge un lavoro minuzioso ridefinendo ogni passo presente e passato dell’intervento psichiatrico e psicoterapeutico. Sono d’accordo con Merini che il manicomio era “una difesa sociale” dove “si depositava la parte sincretica della personalità” (pagg. 92-93). Siamo d’accordo con lui anche contro l’eclettismo, ma vorremmo richiamare l’attenzione su certe situazioni paradossali pratiche e teoriche.
Se si parla di schizofrenia come malattia dell’Io, e, seguendo Searles (pag. 131) “…senza supporre che modificando i rapporti interpersonali la situazione del paziente possa cambiare significativamente”, se queste sono le premesse teoriche, allora il territorio appare come una situazione di cambiamento per gli operatori sociali mentre i pazienti continuano ad avere una malattia che è una questione ‘individuale’. Allora il sociale diventa un discorso ideologico di ‘buona volontà’. ‘Essere buono’, ‘essere amabile’, ‘essere comprensivo’ portano a una morale e non ad una scienza psichiatrica.
Ci troviamo quindi imprigionati tra un’Ideologia Psichiatrica (moralistica) e una Psicoanalisi delle Associazioni Psicoanalitiche.
Nel 1981, nonostante i cambiamenti avvenuti in tutti questi anni, e dei quali straordinario esponente fu Franco Basaglia (il mio mai dimenticato amico) corriamo il rischio di tornare al dopoguerra. Di nuovo la psichiatria si può trasformare in un problema di ‘Assistenza sociale’ (come direbbe Castel) e dal lato opposto sembra che, se si vuole studiare in ‘profondità’, sia necessario ricorrere alle Associazioni Psicoanalitiche.
Tra le due posizioni, una oscurità, o una paura. Quale?
Merini risponde: il territorio può essere un luogo di mediazione, a pag. 91 egli infatti afferma: “Se per territorio si intende una realtà sociale, politica e culturale ove i problemi possono essere gestiti collettivamente, diviene lecita l’ipotesi che da esso si possa sviluppare un nuovo modo di confrontarsi con la schizofrenia”. Facciamo una digressione. In altre circostanze storiche, e in un altro paese, abbiamo progettato di socializzare la conoscenza e l’assistenza psicoanalitica. Abbiamo cercato, in certi luoghi e istituzioni pubbliche (ospedali, quartieri, sindacati, ecc.) di dare una formazione alla gente (‘I lavoratori della Salute mentale’) ed un’assistenza pubblica.
I problemi insorti derivavano: dalla struttura teorica della psicoanalisi, dalla sua tecnica, dalla sua applicazione in altri campi (e le conseguenti variazioni del setting), dall’interpretazione, dalla modificazione istituzionale dell’organizzazione (soprattutto dopo l’inclusione di una prospettiva psicoanalitica), dai passaggi dalla traslazione individuale ad una istituzionale, ecc. Ciò che rimaneva fisso, ed era una situazione ‘costante’, era che qualcuno veniva (richiedente) e qualcuno riceveva (intervistatore). Si stabiliva un contatto (anche se c’era un pagamento). Il rapporto che si stabiliva aveva certi limiti.
Sul territorio, è lecito chiedersi come sono questi ruoli e quali sono i contratti. E inoltre quale rapporto esiste tra il gestore e gli utenti. Se la malattia è individuale, che ruolo svolgono gli ‘altri’ (i ‘sani’, aggiungerei)?
Come mi hanno riferito gli ‘operatori sociali’ di diverse zone, quando essi arrivano a una casa e chiedono a un familiare il perché della chiamata, la risposta è: “Il solito” (quale complicità si nasconde dietro a questa frase? E si risveglia un altro interrogativo: Psichiatria o Ordine pubblico?).
Parallelamente si pone la questione del rapporto tra la Comunità e il senso comune, o il consenso. Sappiamo che esso è ideologia, o meglio resistenza al cambiamento. È il senso comune, o il ‘senso della realtà’ che spesso impedisce l’uso della fantasia e dell’immaginazione. Queste ultime saranno stupidaggini per una Psichiatria utile?
Ci si può rispondere che attraverso la psichiatria non si possono fare cambiamenti sociali. Siamo d’accordo. Però qui non si trattava di ‘spostamenti’ (o sostituzioni), né di ‘actings’, ma di concepire in altro modo il movimento di una disciplina, la psichiatria, nel momento in cui la storia del suo sviluppo ci porta ai limiti del suo vecchio modello assistenziale.
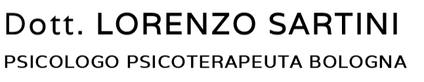
 Feed RSS
Feed RSS
