
Ricorrono i 45 anni di attività di Werner Herzog (Monaco, 1942) e Torino celebra il regista tedesco e i suoi 52 film, formando una rete di istituzioni. Il Museo Internazionale del Cinema, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, il Teatro il Regio e la Scuola Holden. Questi quattro spazi culturali hanno dato luogo a quattro diversi appuntamenti. La conferenza stampa di accoglienza, una retrospettiva con undici video inediti, fotografie e installazioni, poi un cineconcerto e, per finire, un seminario di due giorni.
Patrizia Sandretto ha così spiegato la scelta di inserire Herzog all’interno di uno spazio dedicato all’arte contemporanea: “Perché ispira molti giovani artisti d’oggi e mostra emozioni che sanno dire qualcosa al di là della rappresentazione. Ogni film inoltre potrebbe essere considerato come un’opera completa a sé stante. Dove Herzog stesso diventa attore, regista e sceneggiatore”.
Herzog è presente a ciascun evento e, alla fine di un’intensa settimana, commenta: “È stato fatto un lavoro enorme qui a Torino, a volte rimango stupito di quello che ho visto, mi sembra di avere davanti qualcuno che riconosco, ma che non, infondo, non conosco del tutto”. E forse è vero. Il regista, tra una conferenza e un seminario, si rivela, arrivando sempre a un passo dalla soluzione che risposta non ha. Il suo cinema.
Come ha iniziato Herzog?
La follia e il pericolo nei suoi film che ruolo anno?
La follia nei miei film ha un ruolo importante. Il problema di questa affermazione è, in parte, che implicitamente significa: se sono o meno interessato alla follia come film maker potrebbe voler dire che, includendola in una parte del mio immaginario, a lungo andare potrebbe succedere qualcosa. Per esempio, che arrivi la stessa follia a prendere me. Io non faccio film per cercare il pericolo. Anche se è vero che niente mi fa paura. A volte ho anche lasciato perdere quando ho intuito, come nel caso della spedizione sul K2, che sarebbe stato troppo difficile raggiungere la cima, sia per me che per la mia troupe. La natura è sempre avversa, lei sì che è il pericolo. Si guardano le stelle, nelle notti d’estate, senza considerare che sono potenziali bombe esplosive sulla nostra testa. Ci sono poi posti come l’Angola o la Cambogia dove bisogna sempre giudicare con correttezza l’eventualità di fare un film. In verità ci sono pericoli ancora più grossi, come ledere la dignità delle persone che a volte vengono riprese nei miei film. Parlo di quelle persone che mi affascinano perché mancano di qualcosa per natura, come i sordo-ciechi e muti di In the Land of darkness and silence.
Nei suoi film comincia a lavorare con le nuove tecnologie, nuove frontiere che hanno dato vita ai new media, quelli che ci assediano. Ha senso diffondere immagini di questo tipo? Quanto influisce la novità su un ritorno al cinema che sembra vitale?
Io assito a questi cambiamenti, ne sono incuriosito e, personalmente, do il benvenuto al digitale, ma sono e resto un uomo di celluloide. Quel che si può va messo sullo schermo come lo si era immaginato, è ovvio. Ma con l’avvento degli effetti speciali questo diventa molto più semplice. Esistono anche, è vero, nuove forme di comunicazione e narrazione, come la pubblicità sempre più invadente, oppure i continui incontri di wrestling, oppure la stessa Mtv, questo non m’impressiona. Noi come umani abbiamo un dono: quello di mettere in relazione il nostro comportamento con la nostra capacità di raccontarlo. Questo meccanismo si è sviluppato per migliaia di anni senza venir alterato dalla presenza di Mtv, ed è per questo, attraverso una cosa dentro di me e dentro gli spettatori di tutto il mondo, che i miei film provengono da tutto il medesimo mondo. Anche se molte delle pellicole girate sono state a margine per parecchio tempo della scena cinematografica internazionale, oggi sono tornate verso il centro, il centro dell’attenzione. Come Aguirre: 35 anni fa era stato lasciato in periferia mentre oggi è sotto i riflettori, o viceversa potrebbe succedere lo stesso a film che nel 1972-73 erano ben presenti, oggi sono diventati marginali.
Guardando al suo lavoro, lei non può essere definito né un regista, né tanto meno un semplice documentarista. A priori sono sbagliate le etichette, ma come potrebbero essere definite le sue video performance?
La fiction e l’attività di documentarista sono due dimensioni borderline, due linee di divisione che, lo so, sono all’interno del mio lavoro. Ma che, so altrettanto bene, lo comprendono. Per questo credo si faccia più fatica, si impieghi più energia a cercare una distinzione netta, più che a fare quello che io chiamo fare cinema. Per quanto riguarda le etichette da darmi, beh, io sono uno scrittore, ho scritto molti libri di cui vado fiero. Sono anche un attore, ho fatto il lavoro di performer sulla scena di un sacco dei miei film senza per questo renderle delle opere liriche. Al riguardo sono anche stato sceneggiatore e curatore della coreografia di alcuni spettacoli teatrali, senza dimenticare che sono anche un ottimo cuoco. Ecco chi sono.
Lei ritiene che l’arte possa essere un linguaggio? La riscontra all’interno dei suoi film?
Mi sento molto più a mio agio a parlare di letteratura. A me non piace l’arte oggi, è troppo concettuale secondo me, la sola cosa che conta è il pensiero che sta a monte di qualcosa, come alcune installazioni, che sembrano costruite in cinque minuti e magari con materiali di scarto. C’è spesso la tendenza a dare troppa profondità alla materia senza darne all’immagine. È per questo motivo che ho cominciato a diventare sospettoso del mondo dell’arte. È così che ho preso a considerarlo come un complicato giro d’affari. Un complotto alle spalle della cultura, quella vera intendo, tramato da una cospirazione di azionisti, di art dealer e, ovviamente, di artisti. Non mi piace andare nei musei. Forse è stato a causa di quella volta, quando ero ragazzino e facevo atletica, arrivai finalmente al Partenone, sull’acropoli ad Atene, ma ero così stanco che mi sono addormentato fra le colonne del tempio e un guardiano mi ha scacciato in maniera crudele. Da allora sono entrato molto di più in confidenza con la letteratura, con la fotografia e l’architettura. In casa mia preferisco avere appese alle pareti delle mappe, ho escluso ogni dipinto dagli spazi della mia vita. Le mappe mi danno la possibilità, con la mente, di tornare in quei posti nei quali sono stato e mi mostrano quelli in cui devo ancora andare. Nel deserto del Sahara, per esempio, oppure lì dove ho segnato che sono in corso delle guerre troppo pericolose.
Durante le riprese, lei è sempre stato attento a creare un linguaggio, una storia e un mito che alla fine è diventato un film...
L’invenzione sulla realtà, l’inventiva, la creatività comprendono anche la capacità di fondare dei miti a partire dalle immagini reali. Tutto dipende dalla capacità dall’arte intrinseca di saper raccontare, come in Bells from the deep. La città sommersa dal lago ghiacciato non esiste nella realtà, esiste solo nell’anima dei russi, nelle loro credenze. La sequenza che ho girato, quella dei pellegrini che strisciano sul lago di ghiaccio, è una mia invenzione. Questa scena in verità scende più in basso, più in profondità dell’animo collettivo della Siberia, si confonde nei sogni e nelle leggende, nonostante la mia sia stata una trovata cinematografica. I due pellegrini sono degli ubriaconi pagati per strisciare su un sottilissimo strato di ghiaccio e spinti a fingere di vedere qualcosa attraverso il lago. Proprio come narra la leggenda della città sommersa. Durante le riprese i due erano talmente ubriachi che si sono addormentati col naso sul ghiaccio. Ma questo non l’ho fatto per prendere in giro nessuno, è solo la fiction che a volte spiega la verità. Spesso è il solo modo per arrivarci, di raggiungere quella verità intensa ed estatica, che è la sola ragione per la quale faccio cinema. Persino i russi, in questo filmato si sono sentiti più vicini alla loro stessa anima impastata di fede e superstizione.
Girare un film è “una questione di atletica, non di estetica”. Potrebbe spiegarci questa sua affermazione?
È da prendere con le pinze, l’ho “sparata” fuori in un momento in cui, durante una conferenza, ero assediato da mille domande sulle ideologie politiche e sugli accademisti. Tutti problemi di concetto dai quali mi sarei potuto salvare solamente cercando in fretta un motto risolutore. Vero è che per me il film in sé non esiste solamente come concezione cerebrale, ma diventa anche uno sforzo atletico, un atto fisico che segue il regista così come si muove. I due processi avvengono nello stesso modo, nel momento in cui si parte a capire e a esplorare lo spazio attorno alla macchina da presa. E lo spazio nel cinema è importante, va attraversato, addomesticato e capito così come un bravo giocatore si muove all’interno del campo da calcio, con la medesima fiducia che gli rimane addosso, anche quando non ha più la palla ai piedi. Perché una volta individuato lo spazio, va riempito con vita e sostanza.
Ci parli del rapporto che secondo lei esiste tra inconscio personale e inconscio collettivo.
Non mi piace guardare a me stesso, la trovo una delle attività più controproducenti ed egoiste che esistano. Preferisco che me stesso guardi me, cioè che quello che è inconscio si guardi verso il fuori e non viceversa. Ritengo che la psicanalisi sia uno dei problemi principali del XX e del XXI secolo, un errore, a parer mio catastrofico, più pericoloso della stupidità. Ritengo che ci sia una visione collettiva estesa che è un po’ come se fossero dei serbatoi di immagini, le stesse visioni dalle quali tutti attingiamo sullo schermo. Come quando si guarda la Cappella sistina di Michelangelo, lì, il pathos umano, quello specifico senso di appartenenza al nostro genere, sembra esistere da sempre. Ma solo colui che lo rende visibile, come se fosse un nuovo momento per una nuova, rinnovata scoperta della visione collettiva e questo è un grande valore in sé nel suo essere.
Cosa ci dice del suo ultimo film?
Encounters at the end of the world è stato una sorpresa anche per me. Mi ha regalato una sequenza di immagini prese sotto il ghiaccio, delle viste di rara bellezza. Non me lo sarei mai aspettato. Ho chiesto il permesso alla società scientifica americana per poter avere dei filmati girati alla base artica di Murdo, mentre loro mi hanno offerto un invito per raggiungerla assieme a una spedizione di scienziati. Così, nel giro di qualche giorno, io e il mio assistente ci siamo trovati a preparare la partenza, a dover controllare in fretta le attrezzature. Normalmente faccio sempre un sopralluogo sul posto che devo andare a filmare, per un minimo di previsione, in questo caso non c’è stato il tempo materiale per farlo. Quindi ognuno al mondo potrebbe realizzare questo film, basta un buon registratore audio e una telecamera digitale. Dal punto di vista tecnico non c’era nessuna troupe e nessun effetto speciale o altri espedienti simili. Io stesso, in certi punti, mi sono occupato della registrazione del suono. E il fatto di tornare a casa con un film è stata una sorpresa. Un documentario che mi è molto vicino al cuore. Qui a Torino sarà la terza volta che viene proiettato. È già stato fatto vedere al Film Festival di Toronto e al Festival del Cinema Documentario di Amsterdam. Per ora non c’è stata nessuna proiezione da nessun’altra parte del mondo, nessuna uscita in sala, anche se credo che verrà acquistato e mandato in onda da Discovery Channel.
Che piani ha per i prossimi film?
Io non faccio piani sui film che andrò a girare, i progetti mi arrivano senza che li solleciti, è un po’ come se cadessero su di me. In America la chiamano home invasion quando qualcuno entra in casa tua mentre magari sei seduto in salotto e fa una vera e propria invasione di campo nei tuoi spazi. Ecco cos’è quella che io definisco l’invasione, è il trovarsi inciampato in situazioni e persone senza averle mai invitate ad entrare. Così è successo per Rescue Dawn: ho fatto le riprese durante la guerra in Vietnam, quando l’America si sentiva ancora invincibile. Sono così i miei film, sono inevitabili, invadono me stesso e la mia casa e non se ne vanno fino a che non mi hanno buttato fuori.
Come si emoziona Herzog nel quotidiano? Quali film guarda per farlo?
Non dobbiamo esagerare con il numero di film che si vanno a vedere. Io al cinema vado un sei o sette volte l’anno e ce ne sono ben pochi di film che mi commuovono. Non ho un vasto background di pellicole viste. Mi sono molto stupito ed emozionato qui al Museo del Cinema, quando ho visto per la prima volta un filmato dei fratelli Lumière che mi ricorda esattamente il primo film che ho girato, dopo tanta fatica, quando avevo sedici anni. Se c’è una pellicola che ho amato molto è Padre padrone, perché il protagonista vive una vita molto simile alla mia infanzia. In verità leggo molto, è così che mi sono innamorato del mondo, del concetto di visione e del fatto che solo attraverso di essa, con la poesia, si riescono a dare dei nomi alle cose, o alle persone. Uno di quei nomi che restano per sempre. Per quanto riguarda la letteratura tedesca amo molto Hölderlin, poi leggo anche Chatwin e Conrad. Per me è dunque più facile citare esempi letterari o musicali, anche se mi ha commosso molto, durante questo ultimo mio film, la potenza delle immagini associate a una colonna sonora che esplode intensa.
Che cosa intende per trasparenza, quella di cui parlava con Wenders durante le riprese di Tokyo Ga?
A volte esistono visioni collettive che si nascondono dietro, e a volte sopra, le vicende. Cercarle: è questo che porta avanti il mio pensiero e il mio lavoro. La trasparenza ha a che fare con la visione collettiva che si manifesta e si svela solo in alcuni, precisi, inavvertibili momenti. Bisogna rendere trasparente quel che è nascosto dal muro, o da una cortina di superficie facendo emergere gli esseri viventi che, prima ancora di iniziarlo, sono stati dietro il mio lavoro.
Lei ha fatto arrivare la macchina da presa ovunque ci fosse qualche luogo, anche interiore, molto intimo dell’uomo, da dover registrare e documentare. C’è qualche posto nel quale non è riuscito ad arrivare?
Credo che nel prossimo film vi sorprenderò. Sono arrivato con la macchina da presa in un tunnel sotto il ghiaccio dell’Antartico che arrivava a -70°. Di solito ritengo che chi gira film a Roma, a Parigi o a Londra non faccia altro che girare pellicole già di per sè di finzione. Mi piacerebbe fare un film in Birmania, dato che oggi la situazione lì è complessa. Oppure, e questo so per certo che lo farò, mi piacerebbe girare un documentario sulle ultime persone che parlano delle lingue minacciate dall’estinzione. Lingue che senza questi ultimi sopravvissuti, alla loro morte, saranno costrette a scomparire. Ci sono delle lingue che si stanno deteriorando, con loro finiranno intere civiltà. Questo è l’imperativo culturale di cui bisogna curarsi oggi. Noi siamo consapevoli di balene e specie animali in continuo pericolo di estinzione, ma non ci rendiamo conto che fra poco più di una generazione il 90% delle lingue scompariranno, irrevocabilmente senza lasciare alcuna traccia di sé. Tra poco arriveremo a non avere più che un solo italiano a parlare italiano.
(pubblicato il 4 febbraio 2008)
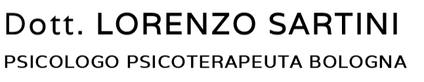
 Feed RSS
Feed RSS
